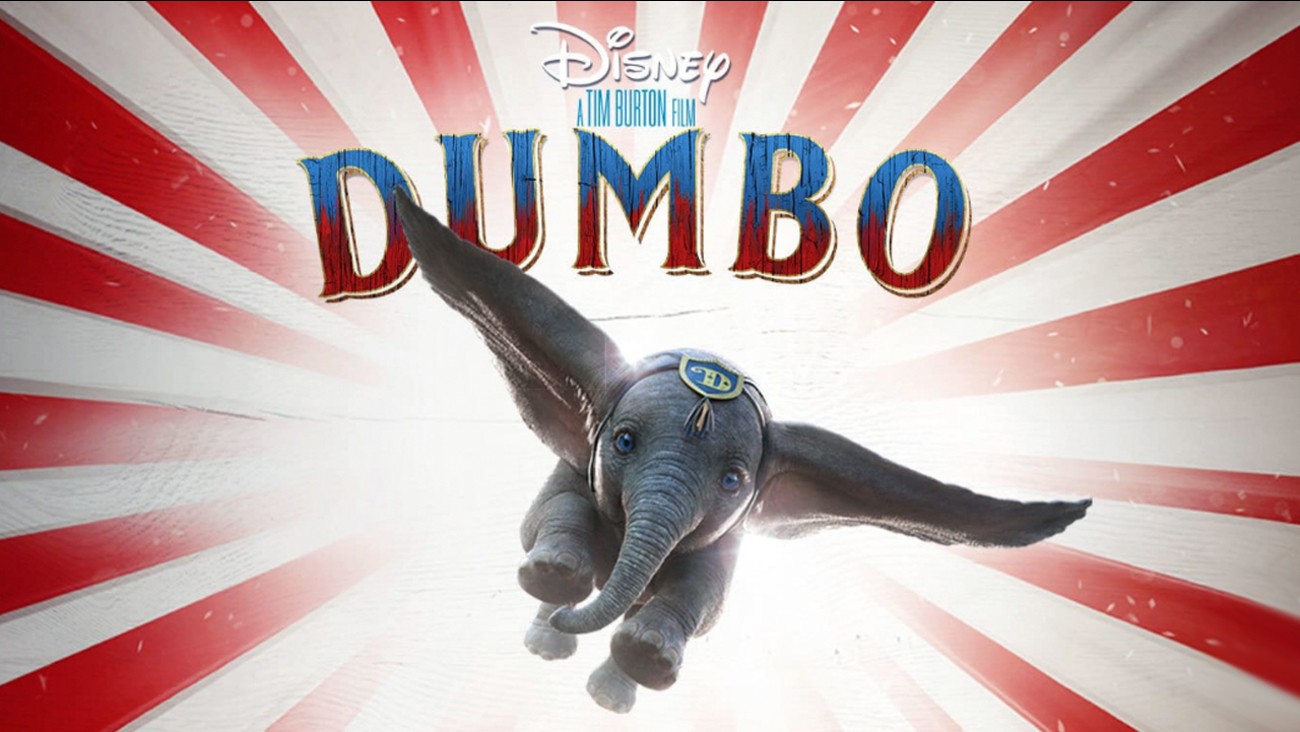Baby mine, don’t you cry
Dumbo – L’elefante volante, il capolavoro d’animazione Disney del 1941, è uno di quei classici intramontabili entrati nel cuore di tante generazioni. Riadattare un’opera del genere dunque non è affatto semplice, anche perché non pochi hanno fallito sulla via del remake o del reboot in live action tratto dall’animazione Disney.
Chi di certo non ha paura del pericolo è Tim Burton, che per il suo esperimento sceglie l’opera nata dal soggetto di Helen Aberson, che a dirla tutta è forse proprio uno dei capolavori animati più Burtoniani in assoluto, grazie al mix di scene fortemente emozionali con atmosfere sognanti e a volte persino inquietanti, in un viaggio onirico che non poteva non solleticare la fantasia del regista de La sposa cadavere.
Non ci siamo dunque stupiti più di tanto quando abbiamo saputo della sua idea di portare sul grande schermo un nuovo Dumbo (al cinema dal 28 marzo), riadattato in live action e con una storia che si mostra come una sorta di remake, ma anzi i nostri cuori hanno iniziato a pulsare, alzando l’asticella se non delle aspettative quantomeno della curiosità.
Ora, finalmente, la nostra fame di sapere è stata saziata. Bisogna soltanto capire quale retrogusto ci ha lasciato…
Ne ho vedute tante da raccontar…
Quello che possiamo affermare senza timore di smentita è che Dumbo è il miglior film di Tim Burton degli ultimi 10 anni. Il che ci porta subito a due considerazioni: la prima è che l’ultima parte della carriera del regista non è certo contraddistinta da capolavori, ed anzi da Alice in Wonderland in poi è scemata in una deliranza folle da cui Burton è uscito per un attimo solo grazie a un breve ritorno al passato, con Frankenweenie; la seconda considerazione è che comunque la si voglia mettere Dumbo non è per niente un brutto film. Fatte queste osservazioni generali e un po’ fumose, possiamo passare ai dettagli.
Tim Burton sa bene quali tasti deve premere per solleticare la sensibilità degli spettatori e lo fa con la maestria di un tempo, con un protagonista a cui non servono le parole per far emozionare. Così come l’Edward mani di forbice, Dumbo è un diverso, è deriso per i propri difetti ma le favole ci insegnano che dalle imperfezioni e dalle anomalie possono venir fuori grandi opportunità e poteri insperati, ed allora il nostro cuore si scoglie come neve al sole ogni qual volta vediamo l’elefantino librarsi in aria e volare, accompagnato dalle fantastiche note della soundtrack curata da Danny Elfman, in cui figura anche Baby mine in una toccante versione degli Arcade Fire.

Strumenti che non possono in alcun modo lasciare asciutti i vostri occhi durante la proiezione, e a cui si aggiunge un’estetica sognante in pieno stile Burton, che lascia a casa il gotico e il dark anche in un adattamento che pure, tra le reminiscenze del Dumbo originale, non avrebbe sfigurato in qualche scena (l’inquietudine sfiora il film in rare sequenze, ma non vi diciamo di più), e invece l’artista di Burbank sceglie di percorrere un’altra strada, quella fatta di commozione e turbamento, ma anche di perfette scelte stilistiche, affidandosi ad uno dei suoi scenografi di fuducia, Rick Heinrichs (Dark Shadows, Big eyes, e non solo) ed alla coloratissima fotografia di Ben Davies, tra i più gettonati direttori del momento. Una palette vivida che rende Dreamland un vero sogno e un piacere per gli occhi, ma che sa regalare anche atmosfere tenebrose e malinconiche quando la camera di Burton utilizza la notte per i pensieri tormentati di Holt Farrier (Colin Farrell) e dei suoi figli, o quelli del piccolo Dumbo, anche lui – come i piccoli Milly e Joe – privato della propria mamma.

…giammai gli elefanti volar
If they knew all about you, They’d end up loving you too, cantano gli Arcade Fire, ma noi non abbiamo bisogno di saper nulla del cucciolo di elefante per amarlo, perché la creatura partorita dalla troupe capitanata da Hayley J. Williams e Richard Stammers è uno dei più toccanti esempi di creature digitali, e i suoi occhioni lucenti arrivano fino al nostro cuore e lo stringono forte nei tanti momenti suggestivi dell’opera. Dumbo è talmente adorabile da farci giustificare la furbesca natura melodrammatica del film di Burton, rendendola quasi un pregio. L’involucro lacrimoso della pellicola è paragonabile alle grandi orecchie del piccolo elefante, un difetto sfruttato a proprio vantaggio, perché quando Dumbo inizia a volare ci dimentichiamo di tutto il resto.
Ci dimentichiamo ad esempio dello script di Ehren Kruger, che di certo non ha mai stupito per fantasia, ma che qui sembra scordarsi volutamente dell’introspezione dei personaggi, lasciando le loro identità troppo abbozzate, nonostante il grande potenziale di alcuni di loro, come la Colette Marchant di Eva Green e il Max Medici di Danny De Vito, per un cast artistico peraltro indovinatissimo, in cui spicca il villain V.A. Vandemere, interpretato da Micheal Keaton, che forse è uno dei personaggi più approfonditi e che ci regala una favolosa perfomance, macchiettistica e quasi cartoonesca.

All’anima scheletrica dei protagonisti e delle loro relazioni sociali accostiamo anche quella delle tematiche, che il regista abbozza solamente senza calcare mano, lasciando ad esse il ruolo di metafora – ad esempio il volo inteso come liberarsi dalle catene – o di un più generale leitmotiv di fondo, come quello della ricerca della famiglia, purtroppo non ispessito dall’eccessiva coralità ma soprattutto dalla continua ricerca emozionale, a cui facevamo riferimento prima. Quella grazie a cui, però, a Tim Burton si perdona tutto.
Inutile cercare un’eccessiva profondità in questo Dumbo: basta accontentarsi di vederlo volare, per essere felici.