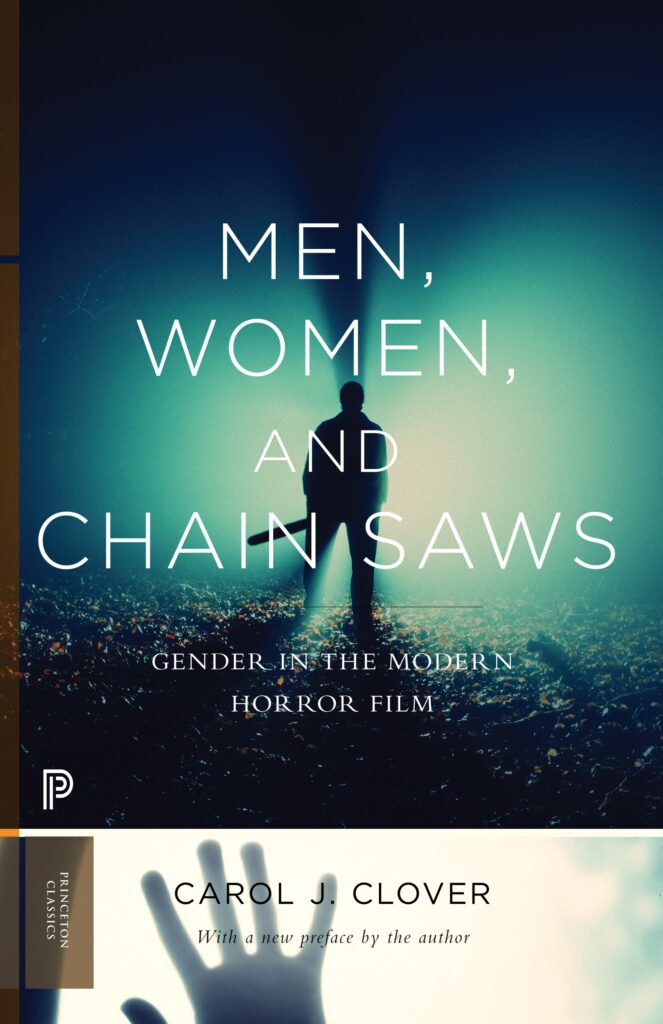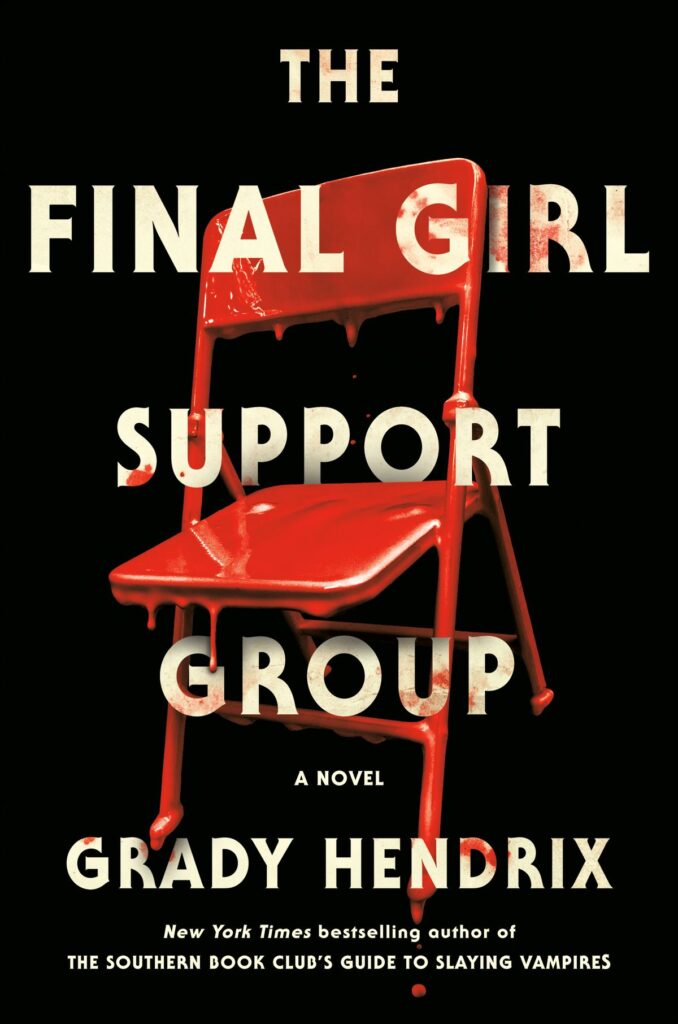Final girl e archetipi: breve introduzione a un trope degli slasher movie che ha ancora molto da dire
Tutte le storie sono complessi puzzle di archetipi. In particolare, quando si parla di letteratura di genere, ogni genere ha i suoi trope, rassicuranti figure narrative che indicano a chi fruisce l’opera dove si trova, cosa sta succedendo, in che tipo di mondo sta entrando. Se, per esempio, vi trovate in un luogo isolato – magari in mezzo a un bosco – e il più figo del gruppo ha appena suggerito di separarvi per sfuggire al serial killer mascherato armato di lame affilate, ci sono buone probabilità che siate in un horror – ancora più nello specifico, in uno slasher.
Caratteristiche degli slasher movie – di cui possiamo considerare un precursore persino il più famoso dei romanzi di Agatha Christie, E non rimase nessuno (conosciuto anche come Dieci piccoli indiani) – sono infatti la presenza di un assassino (molto spesso un uomo) che torna dopo anni a vendicare un torto subito nel passato. A farne le spese, di solito, è un gruppo di giovani, decimato finché a sopravvivere non resta un’unica ragazza: la final girl.
Di final girl nella storia degli slasher movie ne girano parecchie: si fregiano di questo titolo Sally Hardesty di Non aprite quella porta – la prima, Laurie Strode di Halloween – la più famosa, Sidney Prescott di Scream – la non più vergine, ma anche Dana Polk di Quella casa nel bosco – la metanarrativa, ed Elisa di A Classic Horror Story – la nuova. Seppur codificate almeno vent’anni più tardi, le final girl sono figure simbolo presenti nella narrativa horror già a partire dal 1974; sarà però la studiosa americana Carol J. Clover, nel 1992, a dare un titolo a queste ragazze, uniche sopravvissute di un evento catastrofico che distrugge il loro mondo (più o meno metaforicamente, come vedremo con il metahorror di Joss Whedon). Clover, medievalista all’Università della California, Berkeley, si dedica, agli inizi del 1990, allo studio degli slasher movie, pubblicando nel 1992 un saggio che resta, a trent’anni di distanza, un pilastro dei gender studies nel campo del cinema: Men, Women, and Chain Saws: Gender in the Modern Horror Film.
Nelle pagine del saggio di Clover – vincitore del Bram Stoker Award – la final girl viene delineata e le sue caratteristiche si fanno più chiare: la final girl è spesso una ragazza dal nome gender-neutral come Jess, Sidney, Sam, o Ziggy, intelligente, perspicace, è spesso la prima a dare l’allarme, a percepire che qualcosa non va ed è, almeno fino al 1996 con l’arrivo sugli schermi del primo film del franchise di Scream, l’unica ragazza vergine del gruppo. Nel mondo degli slasher movie, infatti, la final girl è l’equivalente della Manic pixie dream girl: la proiezione di uno sguardo maschile (perché sempre maschile è l’occhio dietro la telecamera) su come dovrebbe essere una ragazza – spoiler: virtuosa – per meritare di sopravvivere. Come scrive Clover, la final girl deve essere “feminine enough to act out in a gratifying way, a way unapproved for adult males, the terrors and masochistic pleasures of the underlying fantasy, but not so feminine to diturbe the structures of male competence and sexuality”. Nella sua transizione da povera vittima a eroina, la final girl si appropria di simboli fallici come coltelli e altre armi da taglio e permette allo spettatore di identificarsi in lei, seppur individuo di un genere diverso, e di provare quella paura che viene insegnato agli uomini a non mostrare.
Per sopravvivere la final girl deve diventare la beniamina dello spettatore e per fare ciò i suoi comportamenti devono rispettare una certa morale: chi beve, fuma, ha rapporti sessuali non può aspirare al ruolo; la final girl non balla, non si sballa, come da miglior tradizione la final girl è bella ma non sa di esserlo e cade dalle nuvole quando capisce di essere l’interesse romantico di uno dei suoi compagni di sventura. La final girl è, in sostanza, la fidanzatina d’America, quella ragazza che non è come tutte le altre ragazze che la società ci insegna a perseguire come ideale aspirazionale per essere piacevoli, meritevoli. Innocenza, amabilità, sofferenza, sono le tre virtù capitali della final girl, che sopravvive, sì, ma pagando un prezzo molto alto. Nel 2012 Drew Goddard – sceneggiatore di Cloverfield e della serie Netflix dedicata a Daredevil – fa il suo esordio alla regia con Quella casa nel bosco, scritto insieme a Joss Whedon. Nel film, Goddard e Whedon scompongono i cliché degli slasher movie e spiegano, attraverso le parole dei burattinai che manovrano le morti del solito gruppo pronto a passare un tranquillo weekend di paura nel bosco, che ogni gruppo da film horror e formato da almeno cinque elementi archetipici – la puttana, l’atleta, lo studioso, il buffone, la vergine – e che la morte della vergine è opzionale se è l’ultima a rimanere in vita; l’importante – viene sottolineato – è che abbia sofferto.
La sofferenza delle final girl è la stessa delle scream queen – altro trope delle narrazioni horror – ma con l’evolversi del genere gli elementi più misogini dell’archetipo – quella vaga minaccia di “sii una brava ragazza o farai una brutta fine” sono diventati un’arma affilata nelle mani di queste ragazze finali che affrontano il trauma e la sofferenza e – come Dana nel finale di Quella casa nel bosco – decidono di non aderire allo stereotipo, di decidere per sé, di non incarnare l’essenza di un essere innocente, puro, piacevole, ma di rivendicare e vendicare la propria sofferenza (per elaborare maggiormente il concetto dovrei fare spoiler sulla fine del film e invece credo, nel caso non l’abbiate mai visto, che dovreste farlo).
Non è un caso, forse, come fa notare Alex Abad-Santos in un articolo del 2015 per Vox che lo stesso concetto di rifiuto dello stereotipo della final girl/chosen one si ritrovi in una serie creata proprio da Whedon e a cui ha lavorato anche Goddard: Buffy Summers, la prescelta, la vampire-slayer, nell’ultima stagione decide di sovvertire le regole di un gioco in cui è sempre stata pedina: “In ogni generazione nasce una cacciatrice, perché un gruppo di uomini che sono morti migliaia di anni fa ha stabilito questa regola. […] D’ora in avanti, ogni ragazza nel mondo che potrebbe essere una cacciatrice, sarà una cacciatrice. Ogni ragazza che potrebbe avere il potere, avrà il potere” un discorso che riecheggia del destino delle final girl, uniche, sole, destinate a portare avanti un’eredità (anche di franchise) troppo pesante per le spalle di una sola ragazza.
Attraverso questa lente, quella della solitudine e della sorellanza, possiamo leggere l’ultimo romanzo di una delle penne più interessanti dell’horror contemporaneo: non ancora tradotto in Italia, The Final Girl Support Group, di Grady Hendrix, è una storia delle storie degli slasher movie, che rende protagoniste le final girl di sei dei più famosi franchise del genere (Non aprite quella porta, Scream, Venerdì 13, Halloween, Nightmare, Natale di sangue) in un gioco di rimandi metanarrativi che permette di vedere, di leggere, quello che succede dopo i titoli di coda. Le sei final girl di Grady Hendrix, che si riuniscono una volta al mese per una seduta di terapia, si sono liberate di quella piacevolezza cinematografica per vivere delle vite vere, per sposare le loro compagne, affrontare la dipendenza da sostanze, lottare ogni giorno contro i loro demoni, raccontare a chi legge la realtà dietro l’archetipo – cosa resta della vergine innocente quando il mondo cade a pezzi. Perché tutte le storie sono complessi puzzle di archetipi, ma non esistono nuove storie, se non si va oltre l’archetipo.