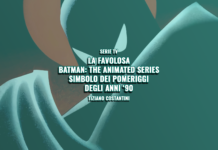Nella narrazione contemporanea della cultura pop l’evoluzione dell’eroe solitario ha preso differenti vie di trasposizione
Fa sicuramente un certo effetto vedere il modo in cui un autore come Clint Eastwood, arrivato alla veneranda e venerabile età di novantuno anni, ragioni sul proprio status e sulla propria icona così come ha fatto nell’ultimo film che dirige e interpreta, Cry Macho.
Dell’Uomo senza nome di leoniana memoria resta un cappello da cowboy e un taglio d’inquadratura sull’iconico sguardo nei primissimi istanti di girato. Tutto quello che segue, seppur altamente imperfetto e cigolante, è una lucida presa di coscienza sul tramonto di un mito, un ironico scorcio sulla caduta del modello, appunto quello del macho, dell’eroe solitario dalle poche parole e dalle significative azioni. Il personaggio di Eastwood si appisola ovunque appena ne ha modo, straparla imprecando a denti stretti come si confà alla sua età, decide addirittura di rimanere al di là di quel confine col Messico, nel placido farewell all’animo focoso della sua natura gringa.

Eroi complessi e nuove figure seriali
Eastwood questo percorso l’aveva già imboccato da tempo, ma ci è utile aver messo il focus su Cry Macho perché è un esempio lampante di come nel periodo storico in cui viviamo non ci sia più spazio per il sopravvivere di creature tutto d’un pezzo nella narrazione audiovisiva contemporanea. Restano parvenze di convinzioni granitiche e personalità apparentemente monodimensionali in alcuni personaggi, questo è certo.
A ben guardare sono però sparuti residui di un carattere filtrato e reimpastato. Ne possono essere esempio quelli del Max di Mad Max: Fury Road, che eppure intercetta uno dei fondamentali discorsi dell’oggi come il posto e il ruggito del femminile in special modo nel dopo #MeToo, oppure la macchina assassina di John Wick, la cui matrice è esile ma è comunque chiamata a confrontarsi con le ombre del passato e diversi compagni lungo il percorso.
Insomma, nell’epoca delle incertezze fuori e dentro lo schermo (dove si gioca una partita a parte sul ruolo del reale dell’immagine che prima o poi ci chiederà il conto) non possono che essere incerti anche i protagonisti delle storie che vengono raccontate. E il posto privilegiato al forgiare questo tipo di caleidoscopiche figure è sicuramente la TV 2.0, fucina dell’era dello streaming dove il pop la fa da padrona ed è un ottimo termometro del mondo che ci circonda.
La progressiva sfumatura nei caratteri tipici dei protagonisti che non devono chiedere niente a nessuno è però una fionda tesa da lontano, a partire dagli anni Novanta con in particolare le serie TV statunitensi che hanno sostanzialmente riscritto la narrazione classica. La moralità sfonda le porte e si fa materia ambigua, costantemente plasmabile e che si attacca addosso ai protagonisti di serie seminali come i Soprano, Mad Men, The Wire, Breaking Bad, come descritto e contornato benissimo da libri fondamentali quali Difficult Men di Bret Martin e Complex TV di Jason Mittell.

Un pistolero tramontato: The Mandalorian
Se in apertura di questo articolo abbiamo citato quello che in sostanza è un western tramontato, non si può non andare a guardare quello che ne è una sorta di lontano corrispettivo in casa Star Wars. Parliamo ovviamente del fenomeno The Mandalorian, che dal western succhia l’atmosfera soprattutto nella prima stagione, partendo con un eroe dal volto coperto, per lo più silenzioso e, in prima battuta, senza nome.
Ma il viaggio di quello che poco più in là scopriremo chiamarsi Din Djarin (Pedro Pascal) è solo per pochissimi frangenti un terreno da battere viaggiando da solo nei quattro angoli di quella galassia lontana lontana. L’intera narrazione di The Mandalorian converge infatti sul presto amatissimo Grogu, se preferite Baby Yoda, che oltre a rappresentare l’enorme McGuffin della serie fino a qui per lo più insoluto, è soprattutto l’immediato terminale di contatto per un eroe che si disvela un po’ alla volta e risulta essere tutt’altro che monolitico.
L’ottimo lavoro dello showrunner Jon Favreau non solo fa centro nel mantenere alto il focus sulla cuteness della piccola creatura, ma riscrive a modo suo la narrativa del gunslinger, del pistolero che ora ha un passato, un presente e verosimilmente un futuro grazie al rapporto paterno che instaura con Grogu. Le intere due stagioni ne sono un continuo esempio, ma sono dettagli chiarificatori di un’emotività acquisita, di umana responsabilizzazione quelli del leitmotiv della pallina/giocattolo (divenuto un tormentone) e soprattutto i momenti in cui Djarin arriva a togliersi l’elmo per mostrarsi alla creatura che ha al fianco, in pieno contrasto con il credo con il quale è cresciuto.

Se anche Boba Fett si toglie l’elmo
E se parliamo di volti coperti non possiamo non rimanere nei confini di Star Wars, che proprio all’interno della seconda stagione di The Mandalorian vede fare il gran ritorno del solitario per eccellenza, Boba Fett. È vero, nell’universo espanso quello di Boba Fett è certamente un personaggio estremamente approfondito, dall’infanzia alle peripezie come cacciatore di taglie, ma la sua icona è impressa a fuoco nell’immaginario collettivo grazie alla trilogia cinematografica classica, dove compare solamente per una manciata di minuti con i quali però è stato in grado di conquistare intere generazioni.
Non era altro che un elmo e un blaster, prima di finire mangiato vivo. Ora, prima ancora che esca la miniserie a lui dedicata, The Book of Boba Fett, è un personaggio che torna improvvisamente e non lo fa da solo, perché con lui c’è Fennec Shand. Significativamente, tra le prime cose che fa è mostrarsi con le fattezze di Temuera Morrison agli altri personaggi e al pubblico. I tempi da spietato assassino prezzolato sembrano essere passati anche per lui, non è affatto insensibile alle richieste d’aiuto del Mandaloriano (nonostante una certa ambiguità) e da figura prettamente negativa pare spostarsi maggiormente all’interno dei confini dell’antieroe.

La narrazione del trauma: The Falcon and The Winter Soldier
Se del nuovo destino riservato a Fett sapremo di più prossimamente, altre due popolarissime serie TV sotto l’egida Disney evidenziano la necessità impellente del confronto con il trauma. Ci riferiamo a The Falcon and The Winter Soldier e Hawkeye, entrambe sotto il gran cappello del Marvel Cinematic Universe (eh sì, di questi tempi molto passa da questi macrocosmi narrativi e sarebbe miope ignorarli) ed entrambe che scelgono la formula del buddy movie per sopperire le mancanze di personaggi spezzati, scossi, disabili.
La prima è quella che fa un discorso maggiormente centrato sul recupero da una serie di shock quasi irreparabili. Il blip di Thanos e lo snap di Iron Man, la perdita di metà della popolazione dell’universo, compresa la Terra, e poi la perdita di punti di riferimento come Tony Stark e Stever Rogers all’interno del gruppo di Avengers. Falcon (Anthony Mackie) e il Soldato d’inverno (Sebastian Stan) da una parte non sono forse personaggi abbastanza forti da rispondere al richiamo dell’appeal come eroi solitari, e quindi di un prodotto seriale singolo dedicato, ma dall’altra rispondono all’esigenza di ricucire le ferite di un trauma che pervade la coscienza collettiva e che fa eco a quella tristemente fatidica data dell’11 settembre 2001. Li si può quindi concepire solamente assieme, loro che sono sempre stati due comprimari del mitico Capitan America (il loro 11 settembre), nel sostenersi vicendevolmente nel percorso di recupero che è mentale ancor prima che fisico.

Hawkeye, di corpi feriti, anime fragili e l’impossibilità della figura solitaria
Un’onda per certi versi parallela a quella che invece riguarda Hawkeye, la serie che porta il nome dell’Occhio di falco di Clint Barton (Jeremy Renner) e che eppure vede condividere lo spazio con l’efficace spalla Kate Bishop (Hailee Steinfeld), in realtà quasi una protagonista a tutti gli effetti per attenzione e cura riservatole. Il caso di Hawkeye intercetta il nostro discorso perché è una storia che germoglia anch’essa dal trauma, ma soprattutto dalla necessità di andare a tamponare le emorragie scaturite dalla feroce esperienza di Occhio di falco come giustiziere spietato sotto il nome di Ronin.
Sotto queste vesti lo abbiamo conosciuto brevemente in Avengers: Endgame dopo che, quasi impazzito per il dolore dall’improvvisa sparizione della propria famiglia, decide di imboccare una via pericolosa e solitaria. Hawkeye, insomma, mostra gli spinosi depositi di una scelta concepita oramai come insostenibile, come un terreno disseminato solo da ulteriore dolore e dannazione e la cui unica risposta è l’accesso al confronto con l’altro. Clint Barton è un corpo ferito, parzialmente sordo, e porta i segni del dolore addosso. Inoltre è distante, restio, schivo, un po’ per carattere un po’ per evitare altri guai alla giovane Kate, ma l’unica soluzione passa proprio da lei, dall’accettare il raccontarle i momenti più difficili della propria esistenza, come lo è stato anche la perdita di Black Widow (ancora, il trauma), e cercare in questo la chiave di una riscoperta personale.
Queste due serie concedono più di un momento alla riflessione introspettiva, dedicando molto spazio a botta e risposta che sotto la superficie celano un nervo teso oramai da tempo e che si ramifica a evidenziare le fragilità di eroi che si sono fatti un po’ meno super. Per concludere, sembra quasi che alcuni prodotti seriali non possano più esimersi dal doversi scoprire come grandi sedute terapeutiche e psicoanalitiche, luoghi adibiti a esorcizzare (in modo più o meno efficace) le contraddizioni e fratture della contemporaneità. Un segno del progressivo mutare dei metodi di riflessione su figure eroiche che forse non rischiano nulla sul piano dell’integrità fisica, ma di certo mostrano tutte le crepe dell’essere umano.