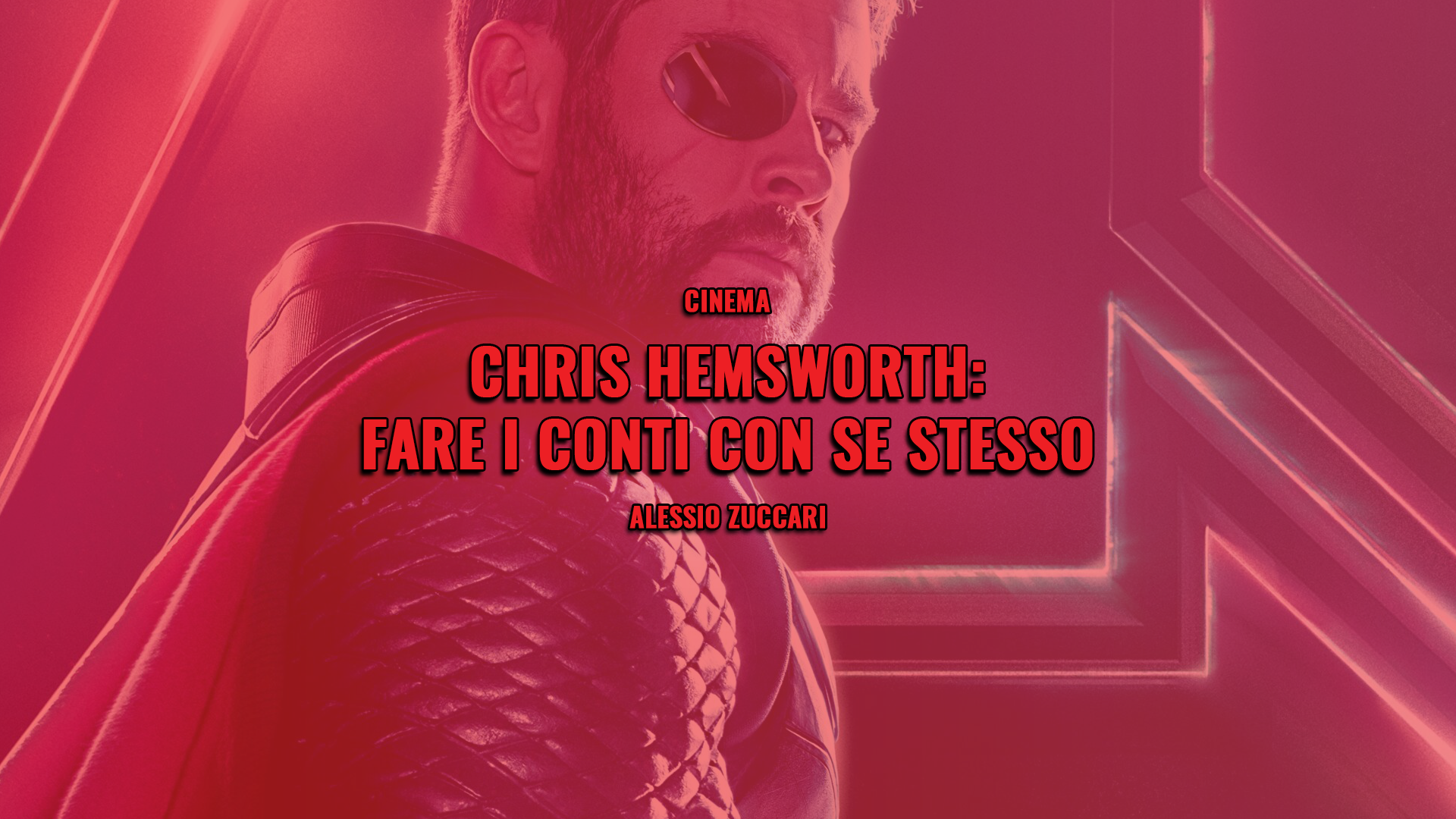Tutti lo conoscono come Thor, ma Chris Hemsworth ha alle spalle già una ricca carriera

n una recente intervista concessa a Vanity Fair dove si ripercorre a volo d’uccello parte della sua carriera, Chris Hemsworth si sofferma in particolare a parlare del suo rapporto con il personaggio di Thor. Riconosce come fin da subito capì che vestire i panni del dio del tuono norreno nel film del 2011 di Kenneth Branagh sarebbe stato il “big shot”, il grande propulsore della sua immagine e del suo lavoro. Allo stesso tempo è onesto nel fare autocritica quando ripensa a Thor: The Dark World (A. Taylor, 2013) e al poco cambio di passo impresso nel personaggio all’interno di un film di per sé già parecchio problematico.
Lascia anche intendere come fosse titubante all’idea di tornare nel ruolo in un film standalone, cosa che forse non sarebbe addirittura avvenuta se non ci fosse stato l’incontro con la visione di Taika Waititi. Thor: Ragnarok (2017) segna in effetti un netto scarto nella maniera in cui fino a quel momento era stato inteso il personaggio di Thor, trasformandolo da rigida figura statuaria in un qualcosa maggiormente fuori dai binari e più “imprevedibile”, come ammette lo stesso Hemsworth.
Ecco, partire dalla relazione che intercorre tra l’attore australiano e il personaggio che l’ha reso celebre al mondo intero è forse l’unica maniera di intendere il suo percorso artistico fino a questo momento. Non perché si voglia incatenare per forza l’uomo al personaggio, ma perché sarebbe ingenuo negare come nell’epoca che stiamo vivendo, fatta di un nuovo pantheon divistico legato a doppia mandata al pantheon supereroistico di casa Marvel Cinematic Universe, l’interpretare una figura chiave come quella di Thor sia un turning point all’interno di una carriera.

A livello di immaginario collettivo soprattutto, dove un volto e una specifica fisicità vengono propagati come marchio ben riconoscibile di una catena che vede nell’MCU un universo narrativo altamente remunerativo. E la fisicità di Chris Hemsworth in quest’ottica è un immediato biglietto da visita. Alto, bello, possente, il cui allenamento e preparazione atletica è spesso oggetto di argomento social, soprattutto quando associato alla preparazione per questo o per quell’altro ruolo. Un fisico da “belloccio”, un termine forse più spregiativo che altro e legato all’immaginario di tanto cinema muscolare e macho degli anni ’80 e ’90.
Insomma, un fisico talmente identificabile e stentoreo da arrivare prima di tutto il resto. Cosa che si fa pregio quando ti rende perfetto per calarti nei panni del figlio di Odino, ma rischia di impiegare poco per farsi arma a doppio taglio, gabbia stretta per un attore che voglia interpretare il proprio lavoro in una maniera che funzionalizzi il corpo in virtù della performance, e non il contrario (pensiamo all’uso plastico che ne fa, ad esempio, Christian Bale).
In una carriera decollata da poco più di dieci anni (il primo ruolo al cinema è nel 2009 con lo Star Trek di J.J. Abrams), Hemsworth di prove ne ha già collezionate molte e di diverse. Alcune meglio di altre offrono la chiave per intendere il percorso che l’attore sta tentando di delineare nel corso del tempo. Se con Rush (R. Howard, 2013) si ha la prima vera incursione nel campo di un cinema più ragionato nel drammatico e dove la fisicità è coperta, per lo più nascosta in favore del lavoro sul volto, è con l’incontro con l’arte di Michael Mann che si realizza un certo scatto.

Nel 2015 esce Blackhat ed è forse il film di Mann più divisivo di sempre. Semplicemente c’è chi lo ama e chi lo disprezza. Ma al netto dell’opinione sul risultato finale, è quanto mai interessante cercare di comprendere la scelta del ruolo di protagonista assegnato a un attore dal carisma recitativo messo in questione e reduce da esperienze per lo più da blockbuster. A ben guardare, la scelta di Mann (che non era sul grande schermo da Nemico pubblico del 2009) non fa altro che ricadere in piena continuità con la poetica del suo sforzo sulle immagini, che della bellezza dei corpi si sono sempre nutrite, che nel contatto fugace tra queste bellezze che aleggiano nei suoi film trova sempre la forza di reazione all’inevitabile. A Hemsworth è chiesto di essere lì, ridursi ai minimi termini su se stesso, non nascondersi mai e lasciare che sia la macchina da presa a levigarlo, collocarlo in quel mondo creato a sua immagine e somiglianza – aiuta, ancor di più, il farlo viaggiare negli spazi aperti che solo un cyber-thriller dal respiro internazionale può mettere a disposizione.
E se dalla collaborazione con il regista di Chicago quella che emerge è una via alternativa, e forse irripetibile, di intendere il connubio tra la propria presenza fisica e l’arte drammatica costruita a partire dall’inquadratura, il ritorno al lavoro con Ron Howard in Heart of the Sea è un po’ un buco nell’acqua. Ancora una volta Hemsworth prova a cimentarsi in qualcosa di differente e sperimentare addirittura perdendo drasticamente parte del suo peso corporeo, ma quel che ne esce fuori è un risultato rigido e compiuto a metà. Il film ci mette del suo, pallido tentativo di ripercorrere gli antefatti dietro la storia del celebre romanzo Moby Dick a cui però manca la verve, la tensione, l’abisso della disperazione che vuole raccontare. E il personaggio di Hemsworth rispecchia tutto questo, compresa una affaticata complicità con un’altra futura star del MCU, Tom Holland.

Se allora la via del percorso serio e serioso è fatta di alti e bassi, è nelle scelte che cavalcano toni diametralmente opposti che si rintraccia un certo tipo di valore aggiunto. Come abbiamo detto la sterzata definitiva arriva nel 2017 con il Thor: Ragnarok di Waititi, ma già il ruolo di secondo piano in un altro contestatissimo film come Ghostbusters di Paul Feig (2016) evidenzia una strada forse più interessante.
Se la fisicità prorompente dell’attore è difficilmente celabile, se la sua icona cinematografica è talmente legata ad essa da attivare meccanismi di associazione troppo forti e immediati, il primo passo non può essere altro che iniziare a questionare questa presenza scenica, metterla alla berlina, renderla oggetto di gioco e scherno. Lo fa e abbastanza bene il reboot al femminile degli acchiappafantasmi, ridicolizzando quello statuto e quindi disinnescando tutti i processi detti sopra. Hemsworth (che nel complesso qui ha un minutaggio abbastanza ridotto) si presta alla grande e pare essere anche molto a suo agio nella parte del segretario un po’ rimbambito, nei primi rintocchi della riflessione cinematografica sulla crisi della mascolinità che oggi è un tema.
Provano poi a farlo in parte anche in casa Marvel con l’avvento in Avengers: Endgame del Fat Thor, rovesciamento totale e negazione stessa dell’assunto alla base del percorso del dio, svilito e piuttosto ridicolizzato dove la sua mancanza di forma è, non senza problemi e ai limiti del body shaming, oggetto più di derisione che mezzo attraverso il quale creare ilarità. Ma ad utilizzare lo stratagemma è pure Men in Black: International (2019). Il film di F. Gary Gray di per sé non è particolarmente degno di nota, pigro in molte svolte e con le poche cose che avrebbe da dire dette quasi sempre male. Ma nella formula che vede un fiacco tentativo di empowerment femminile, trova in Hemsworth un ottimo comprimario da maschio prestante vittima della sua beltà, che da una parte rende l’attore libero di esprimersi quando deresponsabilizzato della carica drammatica e dall’altra non appesantito dalla necessità di negare in questo o quell’altro modo il proprio physique du role. Lo giostra, anzi, come rafforzativo della spinta ironica.

Un po’ quello che avviene anche in 7 sconosciuti a El Royale (D. Goddard, 2018) e nel più recente Spiderhead (J. Kosinski, 2022), dove affianco all’indole comica – che ci piacerebbe decisamente vedere più esplorata in futuro – viene messo anche in atto un palese ribaltamento antitetico tra l’immagine proposta del personaggio e il suo ruolo nel film. Nell’opera di Goddard è l’hippie mezzo sbroccato, non rachitico e consumato dalla droga ma anzi tanto fiero dei suoi muscoli in bella mostra sotto la camicia, mentre nel lavoro di Kosinski il genio mefistofelico che per una volta non assomiglia a Mark Zuckerberg o Tim Cook, ma piuttosto a una statua greca.
Nel mezzo di tutto questo ci sono certamente anche incursioni in impegni di carattere più squisitamente muscolare (inevitabile), come 12 Soldiers (N. Fuglsig, 2018), maldestro tentativo fuori tempo massimo di raccontare ancora una volta le imprese USA in Afghanistan nel post 11 settembre, oppure il semplice e onesto Tyler Rake (S. Hargrave, 2020) sul quale Netflix pare intenzionato a puntare ancora forte. Ma il cammino di Chris Hemsworth è ancora solo alle prime battute, con un avvenire ancora tutto da scrivere. Auguriamoci, e auguriamogli, che sia il più florido possibile, e magari con qualche scelta lavorativa più coscienziosa in grado di valorizzare un’indole espressa forse ancora solo a metà.