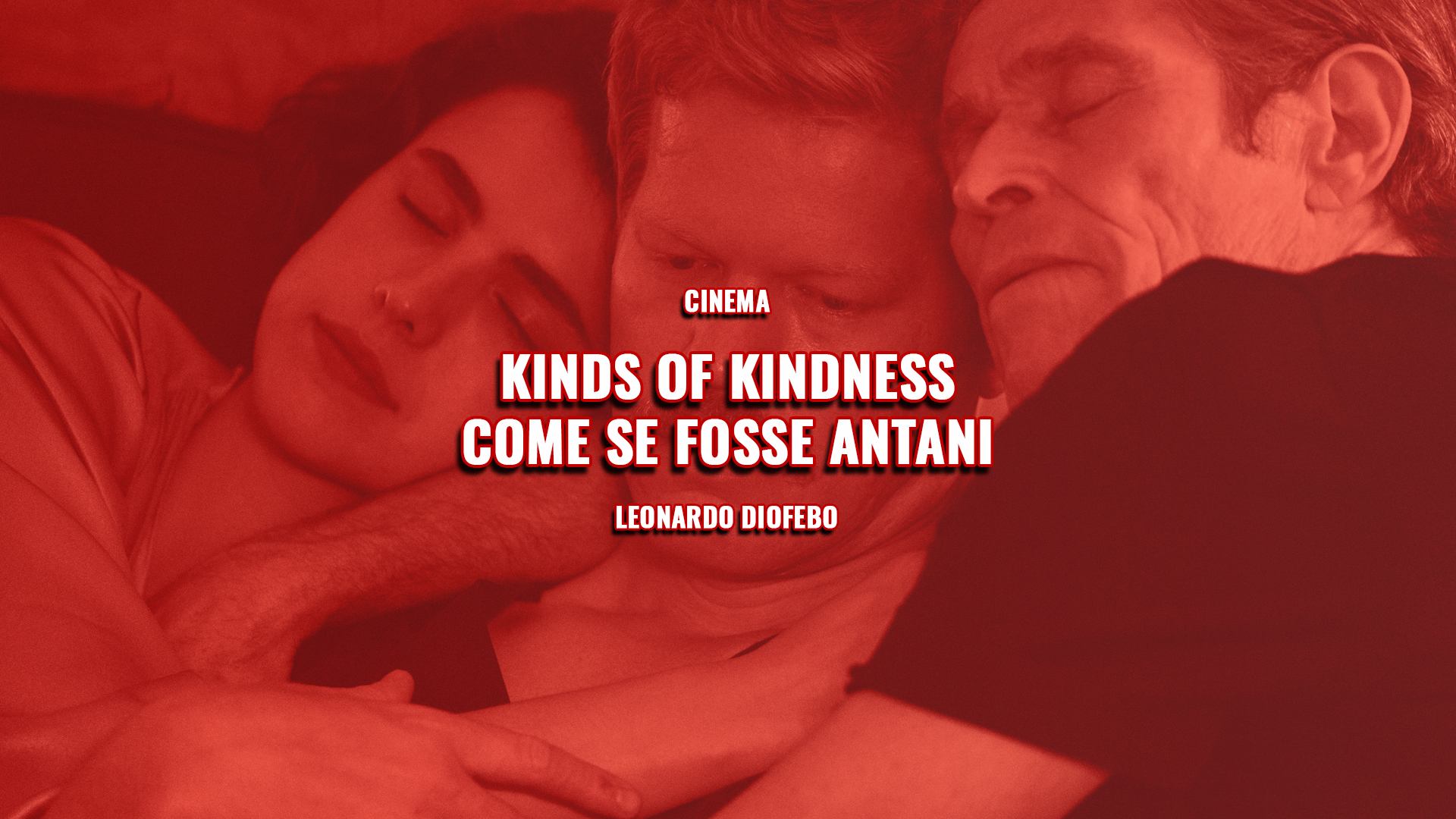“Il secondo album è sempre il più difficile nella carriera di un artista” ripeteva Michele Salvemini, in arte Caparezza.
In questo caso non si può parlare di “secondo” visto che l’ultima creatura, dopo le Povere, di Lanthimos è la nona nella sua filmografia, ma per il successo riscontrato con il grande pubblico, dopo aver trovato in Emma Stone la sua definitiva musa, era fondamentale mantenere un livello tale da poter catturare nuovamente gli occhi degli spettatori sempre più inebriati dalle movenze dinoccolate di una ballerina ebbra sul minuscolo palco concessole dal regista greco.
Ecco allora che arriva Kinds of Kindess. Un eterno ritorno di dolore nietzschiano che decide di sopraffarci con privazioni continue e torture dell’animo. Un’opera critica e criptica, dove l’amore è una metafora continua che cela il desiderio opprimente dei protagonisti di sopraffare il prossimo e affermare il proprio ego. Minuto dopo minuto i sensi di vuoto e le disarticolate narrazioni, suddivise in un crescendo di follia, isterismo e violenza, provano a colpire lo spettatore nello stomaco, provocandogli un senso di straniamento tale da porgli sempre più domande prive di una effettiva risposta.

La sua nuova opera si articola in tre atti, ma non ha alcun interesse nel mostrarci quello che è, ma solo quello che non è. Kinds of Kindess è un buco nero su pellicola che inghiotte i nostri sentimenti. La regia pulita e perfetta, come ci ha sempre abituati il cineasta ateniese, ci dona un piano dove non c’è spazio per alcuna sbavatura e l’occhio si compiace dell’estetica figlia del regista greco. Il contorno, però, non riesce a divincolarsi da una sceneggiatura che crea figure che godono nel realizzare un costante seppuku artistico davanti i nostri occhi. Il suicidio, reale e metaforico, non è né liberatorio, né punitivo, ma è la volontà di un deus ex machina che vuole punire forzatamente qualcuno, soprattutto gli innocenti. Lo spettacolo che ne deriva è barbaro e grottesco.
Con il primo atto Lanthimos ci porta in un mondo folle, dove il potente schiaccia il debole. Dove il ricco ingozza a suo piacimento il povero, quando e come vuole. Dove il controllo viene scambiato per amore. Dove il sentimento muore e l’identità viene disumanizzata sempre più.
Con il secondo atto ci ritroviamo in un palcoscenico dove reale e onirico sono separati da un fumoso confine che ci mostra un universo in bianco e nero. Il baratro di follia nel quale scende il protagonista inizia proprio dove il ricordo del suo passato giace, incapace di saper accettare il cambiamento della persona che un tempo amava. La libertà di chi gli sta affianco non è più contemplata e ciò che viene ritrovato da un cinereo Jesse Plemons deve essere eliminato per sempre, pur di far sopravvivere solamente il ricordo.
La rinascita del protagonista è data dalla morte. L’amore, anche qui malato e opprimente, strangola mente e cuore.

Con il terzo atto la morte, invece, è data dalla rinascita.
Il controllo diventa un totale isterismo che plagia la mente e smembra pezzo dopo pezzo i sentimenti, l’amore, il sesso e la vita degli attori. Lanthimos inizia a giocare sull’isterismo di una setta religiosa, il tema della purificazione dell’anima e la morbosa ricerca di un messia moderno capace di ridare lustro al nome di Lazzaro. Anche qui, però, tutti sono vittime e carnefici allo stesso tempo. L’altruismo nasconde l’egoismo morboso che caratterizza le azioni di tutte le maschere in gioco e gli unici che si salvano realmente da questo ciclo onirico di folli eventi sono i morti che hanno già scontato i propri peccati e possono riposare.
L’unico vero gesto di gentilezza è mostrato da un tovagliolo che toglie una macchia dalla camicia.
Se per molti versi questo Lanthimos ci ricorda qualcosa di già visto (anche dalle sue vecchie opere), quello che ci domandiamo una volta usciti dalla sala, è il perché l’ultima fatica del regista sia stata un’enorme opera stilistica ricca di metafore e provocazioni, ma priva di animo. Un esperimento che ci era già stato proposto con Dogtooth, ma che in questo caso corre il rischio di essere un inciampo dopo una scalata magnifica che meritava tutt’altra consacrazione.
Sapevamo già del suo animo spigoloso e privo di qualsiasi interesse verso botteghino e red carpet, eppure ci eravamo tanto illusi dopo il crescendo di emozioni passato da Il sacrificio del cervo sacro, a La favorita, fino al sopracitato Povere creature. In questa metempsicosi filmografica riuscire a ritrovare il bandolo della matassa sembra tutto fuorché possibile persino per un pubblico navigato e abituato alle storture del regista greco.

Kinds of Kindness è arzigogolato, complesso, privo di un reale centro. Un’opera che incuriosisce, ma non ci offre il pathos assaporato in passato. Nasce e muore nello stesso istante e ci dona solo tanti punti interrogativi. E se è vero che il cinema deve generare domande e dibattito, è anche vero che il piano sul quale la discussione deve nascere necessita di un punto di arrivo.
Lanthimos ci offre uno spettacolo crudo che disumanizza pian piano gli astanti, poveri tasselli di un puzzle privo di colori, generando un senso di deprivazione costante che percuote l’amore. Arriviamo preparati al crescendo sconquassato di eventi che ci turbano l’animo con gli atti finali di ogni capitolo, ma non capiamo il perché di tutta questa brutalità.
In un’opera che prova a mostrarci contemporaneamente l’orrorifico metaforico di Eggers, l’onirico di Lynch e la violenza critica di Garland, quello che ci rimane è un esercizio di stile ricco di sfumature affascinanti, metafore e incastri complessi e di libera interpretazione, ma che non attecchisce fino in fondo. Quello che ci resta è un embrione dell’amore malato e privo di gentilezza.
“Non c’è niente di più contagioso del male” ripeteva l’Eccellenza in Salò, ma qui il male finisce col perdersi per strada dopo un cammino tortuoso e Kinds of Kindness rimane bello, ma senz’anima come se fosse Antani.