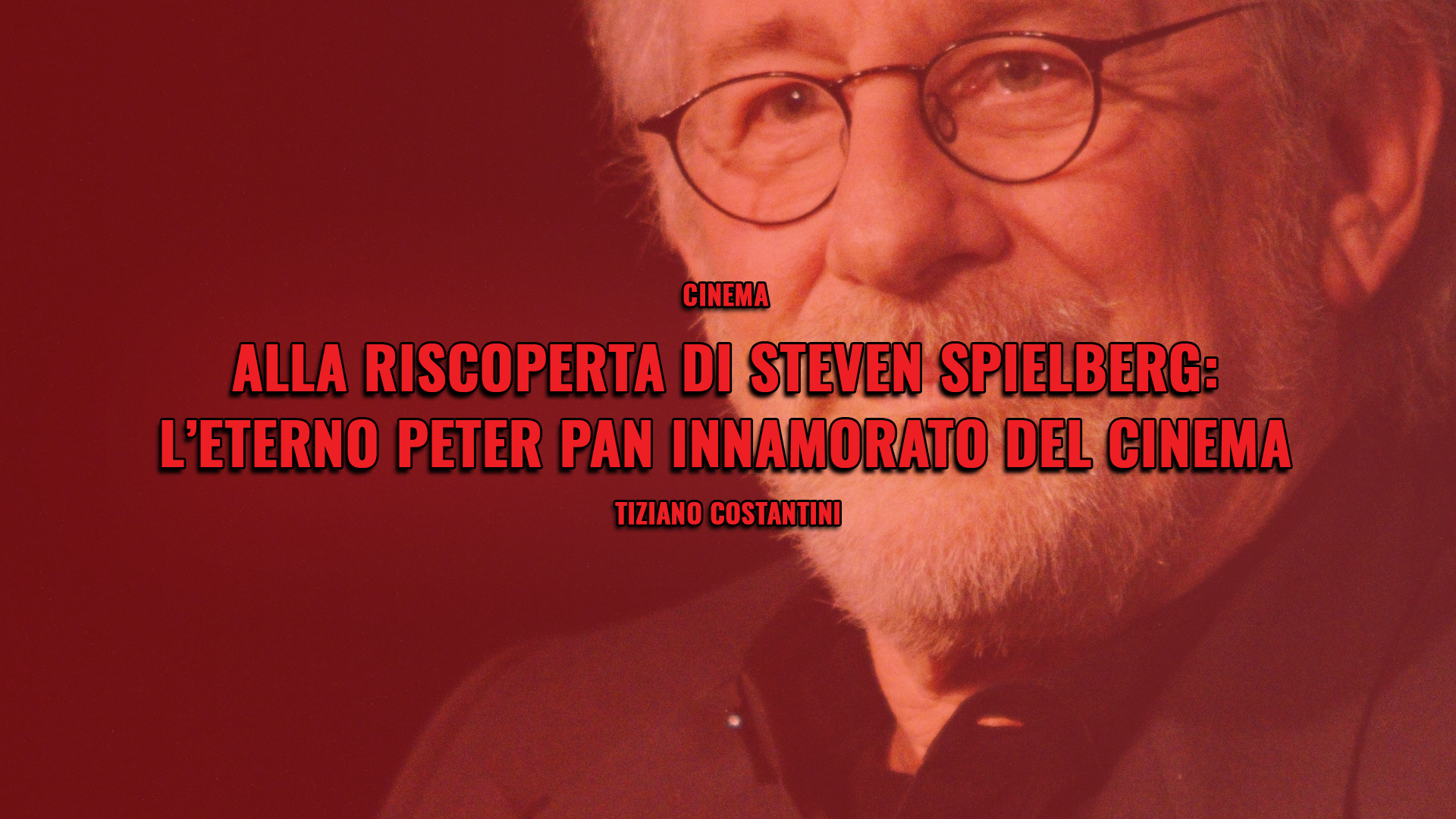Ecco chi è l’eclettico genio di Cincinnati
Oltre 70 anni fa, a Cincinnati in Ohio, nacque un uomo destinato a rivoluzionare la storia del cinema: Steven Spielberg.
Si tratta indubbiamente di uno dei personaggi più iconici ed influenti della Setttima arte, autore a tutto tondo di alcuni capisaldi della cinematografia e che da più di 50 anni mette mano ad una grandissima parte delle grandi produzioni hollywoodiane.
Negli anni ’70 cinque amici fondarono il cosiddetto Movie Brats. Oltre a Spielberg c’era Scorsese, F.F. Coppola, Lucas e De Palma. Cinque giovani registi, ragazzini con le spalle larghe pronti a farsi strada in un mondo complicato dove tuttavia, di lì a poco, avrebbero spadroneggiato per molto tempo. Cinque artisti di estrazione colta, figlia di un percorso di studi effettuato nelle migliori università.
Tra tutti loro Steven era il più giovane, un autentico enfant prodige con la passione per la pellicola e l’ambizione smisurata di diventare presto un fuoriclasse, mantenendo tuttavia sempre inalterati i suoi puri sentimenti verso il cinema.
Chi non conosce bene Spielberg, chi si limita a veder comparire il suo nome sotto la voce “produttore esecutivo” nella quasi totalità delle produzioni hollywoodiane potrebbe additarlo come una macchina per fare soldi, cosa di certo l’artista di Cincinnati non ha mai nascosto (anche perché è tra i primi 500 uomini più ricchi del mondo n.d.R.), ma dietro quella moltitudine quasi infinita di banconote brilla ancora l’amore ed il trasporto per il cinema.
Lo si intuisce perfettamente dal suo modo di approcciarsi alla regia, ancora oggi, a 72 anni, regalandoci masterpiece come The Post e Ready Player One, e probabilmente l’avrà capito anche chi non ama così tanto le grandi produzioni ed è un nostalgico del cinema italiano.
Durante i David di Donatello 2018 infatti il maestro Spielberg ha ricevuto il Premio alla Carriera, ed era visibilmente emozionato come fosse il primo riconoscimento ufficiale, anziché il 33esimo. Ogni premio per Spielberg è un grande onore, perché per chi ama il cinema come lui non esistono riconoscimenti minori, nonostante sia ovvio che un Oscar è sempre un Oscar, persino per chi ne ha vinti 4.
Ci ha raccontato del suo legame con l’Italia, il primo paese visitato al di fuori degli States, all’inizio degli anni ’70 quando venne a Roma per degli incontri stampa subito dopo aver girato Duel. Qui ha incontrato Fellini, o meglio Fellini ha voluto incontrare Spielberg dopo aver assistito alla proiezione del film, incuriosito dal giovane regista che dimostrò evidentemente da subito le sue abilità dietro la macchina da presa. Visitare Roma e guardarla per la prima volta con gli occhi di Fellini dev’essere stata un’emozione unica, che probabilmente in pochi hanno avuto l’onore di provare.
Ora, con più di 30 film da regista sul groppone, diviene piuttosto semplice per chiunque affermare che quell’enfant prodige ha cambiato pelle diventando in un’icona assoluta della cinematografia.
La sua impronta è riconoscibile sempre e comunque nonostante sia uno dei registi più eclettici del panorama mondiale, eccellendo sia in prodotti mainstream, in quei cosiddetti blockbuster che però Spielberg riesce a trasformare in qualcosa di autoriale, di completo, sia in quello che viene definito cinema impegnato, lasciandoci a dimostrazione di tutto ciò l’esempio più lampante proprio di recente, inanellando una combo di capolavori coi sopraccitati The Post e Ready Player One, usciti nelle nostre sale a circa un mese di distanza l’uno dall’altro.
È un hollywoodiano in tutto e per tutto Spielberg, ma perché la nuova Hollywood in un certo senso parte da lui e dai Movie Brats. A differenza dei suoi compagni di merende però – ad eccezione forse di Scorsese, quello più vicino a lui per la versatilità – il maestro Steven ha un rapporto puro e appassionato con la settimana arte, una relazione priva di narcisismo ed ossessioni, quelle che hanno fatto chinare il capo e corroso negli anni il cinema di molti grandi registi, come Tim Burton, il cui sigillo è diventato macchiettistico ed è caduto sotto il peso dei ricordi, o come Coppola che si è arreso troppo presto prendendo tra l’altro una deriva eccessivamente autoriale e prendendosi pure troppo sul serio.
Proprio quello che non ha fatto Spielberg, l’eterno fanciullino del Cinema, l’imperituro Peter Pan, che peraltro ci ha raccontato in modo egregio nel suo Hook – Capitan Uncino, col compianto Robin Williams. La sua spensieratezza, il suo esser in un certo senso sempre bambino e un nerd a tutti gli effetti lo dimostrano i suoi più grandi capolavori, senza citare l’ennesima volta RPO, che resta probabilmente l’emblema del suo cinema, ma andando indietro nel tempo non possiamo non citare E.T., A.I. Intelligenza Artificiale, Le avventure di Tin Tin, Il GGG, ma anche tutti quei prodotti che si assestano nel mezzo della linea immaginaria che divide il suo cinema d’intrattenimento da quello più impegnato, e in cui troviamo per esempio Lo Squalo (il suo primo capolavoro), gli Indiana Jones, ma persino un film come Minority Report.
Il passaggio da uno “schieramento” all’altro è avvenuto nel corso degli anni frequentemente e con una facilità disarmante, al punto che un occhio distratto potrebbe quasi legittimamente pensare che opere come Schindler’s List e Jurassic Park – entrambe del ’93 – non abbiano la medesima regia.
“Quasi” legittimamente, appunto. Perché l’occhio clinico ed attento invece noterà in tutti i suoi film tanti denominatori comuni, in primis la perfezione e l’accuratezza della tecnica, e poi tematiche che nel corso del tempo ha fatto sue, adattandole ad opere differenti tra loro.
La seconda guerra mondiale ed il nazismo, per esempio, che assumono toni gravi e pesanti nel citato Schindler’s List e che invece erano stati trattati in maniera differente e più leggera già molti anni prima, nel 1979 con 1941 – Allarme a Hollywood ma soprattutto nel 1981 con I predatori dell’Arca perduta. Tematiche che ritroviamo poi ancora una volta nel terzo Indiana Jones e ne L’impero del sole (1987), e infine in Salvate il soldato Ryan (1998), in modalità nuovamente diverse.
Da lì in poi il maestro Steven si prenderà una pausa da certi argomenti, uno stacco che dà la sensazione di emancipazione, di aver legittimato il suo contributo alla memoria, lui che nasce proprio nel ’46, a cavallo con la fine della guerra.
Da quel momento non c’è più spazio la commiserazione e il ricordo, ed il cinema di Spielberg riparte con una consapevolezza, di resurrezione e risveglio dal torpore, catapultando lo spettatore molto lontano, per poi tornare indietro. Un nuovo ciclo ed un percorso che parte da A.I. Intelligenza artificiale (2001) e il suo mondo post-apocalittico ambientato addirittura nel 2125, per avvicinarsi poi un anno dopo (2002) nel 2054 con Minority Report (tratto dal romanzo di Dick) e infine tornando nel post guerra mondiale, negli anni ’60, con Prova a prendermi (2002). Il tutto in circa due anni di intensa produzione, in cui straripa con violenza il significato che Spielberg dona a questo trittico di film, prima di prendersi una leggerissima pausa di un anno e “rilassarsi” un po’ con un’opera fantastica ma di certo più convenzionale, come The Terminal (2004).
Il futuro tratteggiato da Spielberg non è certo dei più rosei, ed anzi è pervaso da un forte pessimismo, al punto che lo stesso cineasta affermerà proprio nella recente apparizione ai nostri David che “per fortuna i registi non sono così abili” a prevedere ciò che sarà di noi. Il mondo post-apocalittico di A.I. è inquietante e diretto verso una sorta di autodistruzione, ma nonostante questo periodo rappresenti forse il momento più cupo e nichilista del cinema di Spielberg, c’è sempre un lato velatamente ottimista, tra le righe, che ci prende per mano e ci rassicura. C’è sempre una via di fuga anche nelle situazioni peggiori con una chiosa che in fondo strizza l’occhio alla bontà dell’animo umano, dove anche un truffatore come Frank Abbagnale Jr. non è una cattiva persona.
Ma al di là di tutto questo, è a livello tecnico che Spielberg ha dimostrato di essere uno dei migliori in assoluto. È per questo che opere come il recente The Post ci servono ad apprezzare i virtuosismi della sua regia, permettendoci di ammirare l’ingegnosità dell’utilizza della macchina da presa, messa sempre a disposizione della narrazione, in una perfetta commistione che diventa un plus assoluto. L’inquadratura di Spielberg, in ogni sequenza, è sempre la migliore ai fini dell’esaltazione del racconto stesso, e la spontaneità con cui realizza tutto ciò, rendendo quasi banali tecnicismi oltre il difficile non fa che stupirci ulteriormente. Perché sì, i film di Spielberg sono sempre molto complessi da realizzare. Non serve arrivare a RPO, emblema massimo ed assoluto della meraviglia della tecnica, per scoprire come riesca a rendere apparentemente semplici imprese talmente ardue in cui davvero pochi riuscirebbero a ottenere risultati appena decenti.
È qui che si posa l’autorialità del suo cinema, quella sensazione che ti fa dire “sì, è un film di Spielberg” a prescindere che lo schermo proietti Jurassic Park o Salvate il soldato Ryan.
Potremmo persino partire dalle banalità, come i jingle sempre presenti nelle sue opere, quel sottofondo musicale caratteristico che da Lo squalo in poi diviene un must, con le variazioni del caso, naturalmente.
Sempre citando Jaws e i contrassegni del cinema di Spielberg, è qui che prendono vita alcuni dei motivi ricorrenti nella sua filmografia, come ad esempio lo sfondo nero di apertura con il tema musicale in sottofondo: in tal senso questo è un film che fa scuola, per comprendere tante delle dinamiche appartenenti al suo modo di girare. Dovreste provare a rivedere i primi minuti de Lo Squalo per notare l’intro scura con il jingle, che cresce insieme alla tensione suscitata nello spettatore per quella presenza marina che il regista fa subito avvertire senza farla vedere, e poi il primo carrello laterale con una panoramica di un tranquillo falò sulla spiaggia, che ci rasserena per qualche secondo, lasciandoci scoprire l’ambientazione circostante e tutta una serie di movimenti della camera su cui non indugeremo oltre per non appesantire la lettura, ma che non sono mai casuali ed hanno molteplici significati, tra cui quello di far immediatamente entrare in contatto lo spettatore con i personaggi, favorendo l’assimilazione di tutti quei piccoli dettagli che convergeranno poi in una più fluida narrazione. Il dinamismo della sua macchina da presa, la capacità di adeguarsi all’andatura dei protagonisti ed al tempo stesso di dettare il ritmo quando necessario è sbalorditiva ed in piena armonia con tutta la sua filmografia.

Dal 1975 al 2018 cambiano gli strumenti, ma non il suo modo di girare, che anzi viene esaltato dagli avanzamenti tecnologici. Le inquadrature veloci e il montaggio serrato che passa repentinamente dalla serafica espressione di Meryl Streep al tonfo meccanico di una stampante di giornali, o – tornando indietro – la stessa elastica rapidità con cui disegna l’incontro tra Elliot ed E.T. nei campi di grano, mostrandoci il cambiamento d’espressione, o nei tanti tete a tete in Jurassic Park, o ancora in maniera più netta e persino convulsa in Ready Player One, saltando dal live action al magico mondo in CGI dell’OASIS; ecc, ecc…
Le semplici parole non riescono a descrivere la naturalezza e la leggiadria con cui Spielberg sa muovere la camera, riuscendo ad esaltare tutti gli aspetti dei suoi film, dal core del racconto, all’interpretazione degli attori, alla fotografia o la scenografia, e soprattutto il montaggio, che ne esce vincitore assoluto in questo danzante gioco di salti in cui il maestro si diverte e non poco.
Per la cura maniacale della tecnica si è detto per anni che Spielberg fosse un po’ l’erede naturale di Kubrick. La realtà è che non è vero. Non è vero assolutamente. Spielberg non è l’erede di nessuno, come nessuno riuscirà probabilmente ad essere l’erede di Spielberg, nonostante ci siano già numerosi registi delle nuove generazioni particolarmente abili e che vantano pure una piccola serie di capolavori. Ma in modo assoluto Steven Spielberg è e sarà sempre autentico, inarrivabile, perché diverso da tutti.
Il suo cinema è amato universalmente perché oltre a rappresentare la purezza e la raffinatezza della tecnica, oltre ad essere denso di contenuti interessanti, racchiude il significato più popolare e verace della Settimana Arte: intrattenere.
L’equilibrio con cui ci ha regalato film impegnati e prodotti più mainstream è organico e ponderato, frutto di un percorso comunque naturale nel quale Spielberg ha sempre realizzato l’opera che percepiva come la più adatta in quel particolare momento.
Qualcuno di recente ha temuto che il maestro Steven fosse arrivato al capolinea, ma i suoi ultimi lavoro ci hanno dato l’ennesima dimostrazione che il genio non invecchia col passare del tempo, e come il buon vino migliora con gli anni.
Per favore, Steven, non smettere mai di stupirci.