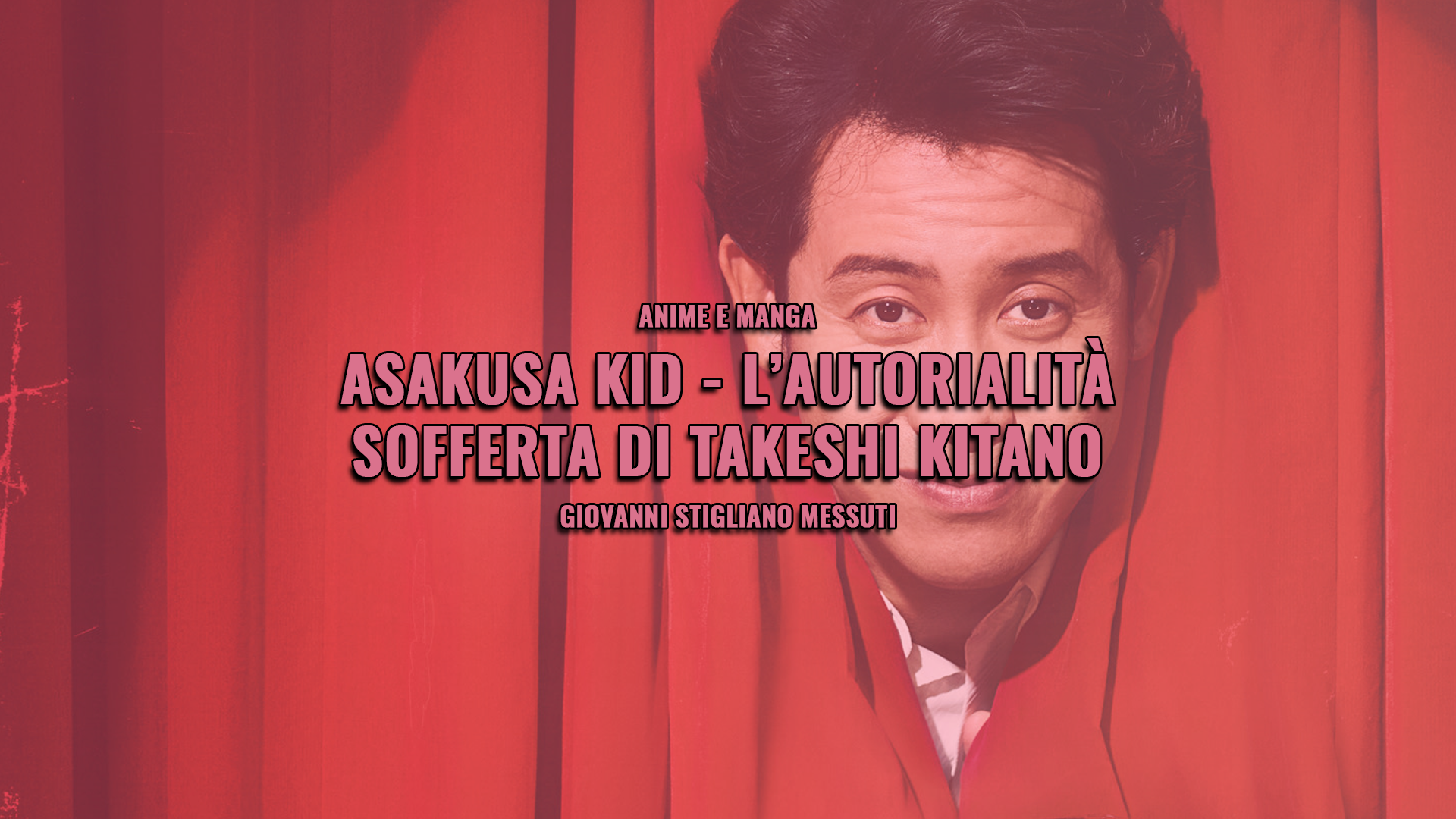Creatura controversa e incostante, ma non per questo meno degna di attenzione, la filmografia di Takeshi Kitano rappresenta uno dei prodotti culturali giapponesi più esportati e imitati all’estero, legata a doppio filo alle peculiari vicende di vita che hanno portato il “ragazzo di Asakusa” ad assurgere a icona totale della vita mediatica del suo paese d’origine, di cui ha sempre cercato di mettere in luce paure e contraddizioni.
Nel tentativo di raccontare gli esordi di questa incredibile parabola, dai teatri di varietà fino agli studi televisivi del servizio pubblico nazionale, il nuovo lungometraggio Netflix Asakusa Kid scade purtroppo in toni puramente celebrativi – non da ultimo per una questione di adattamento testuale – ma ha comunque il merito di aver riempito un vuoto rappresentativo per quanto riguarda la percezione della figura autoriale di Kitano da parte del pubblico occidentale. Di seguito proviamo a capire perché, attraverso un breve excursus sulla prima parte della sua carriera.

Kitano prima di Kitano – Manzai e televisione
Prima del successo internazionale di Sonatine (1993) a Cannes, difficilmente qualche addetto ai lavori si sarebbe azzardato a etichettare Takeshi Kitano come regista, e ancor meno tale definizione sarebbe sembrata appropriata in patria. La sua popolarità era infatti legata all’incalcolabile numero di varietà, quiz e programmi di manzai – una sorta di stand-up comedy a due – a cui aveva preso parte dai primi anni Settanta in poi con il sodale Kiyoshi Kaneko sulle maggiori emittenti giapponesi, imponendosi quale volto televisivo argutamente scorretto, in grado di far ragionare il pubblico con un umorismo cinico e irriverente, ma nondimeno incasellato in un’industria dell’intrattenimento intimamente bacchettona, che puntava a massimizzare lo share evitando di urtare la sensibilità degli spettatori.
Ferma restando la legittimità di questo approccio produttivo, che a dirla tutta fece anche la fortuna di Beat Takeshi – che spesso in disaccordo col collega cercava di far leva sugli argomenti tabù per spiazzare la concorrenza, più rispettosa dei paletti imposti dalla NHK –, col senno di poi non è difficile capire come il palcoscenico televisivo dovesse stare stretto a Kitano, il cui desiderio di crescita personale l’avrebbe portato a sciogliere i Two Beats a metà anni Ottanta per tentare la scalata nel mondo del cinema.

Tenendo conto della fama acquisita da Kitano come comico, potrebbe sembrare che l’impresa non fosse poi così ardua, dal momento che le conoscenze certo non dovevano mancargli, sia nel settore della produzione cinematografica propriamente detta che nei circoli della criminalità organizzata – un mondo, quello degli yakuza, che Kitano non ha mai nascosto di ammirare e col quale possiede legami acclarati dalla cronaca, anche giudiziaria. Il problema, semmai, stava nel tipo di ruoli che gli venivano proposti il più delle volte, e che agli inizi non poté fare a meno di accettare. Dieci anni di onorata carriera come intrattenitore, di cui la maggior parte passati sul piccolo schermo in qualità di superstar del manzai, erano un’eredità difficile da scrollarsi di dosso e che rischiava di limitare le sue possibilità di successo al solo genere comico, sicché a quel punto il tentativo di reinventarsi come attore cinematografico avrebbe finito per rivelarsi una mera estensione di quanto già sperimentato a teatro e in TV.
In questo senso, la possibilità di ricoprire una parte di primo piano nell’acclamato manifesto pacifista di Nagisa Ōshima Merry Christmas, Mr. Lawrence (1983), al fianco di una star globale del calibro di David Bowie, rappresentò per Kitano l’occasione da tempo attesa per dare una svolta alla propria carriera, venendo proiettato nell’orizzonte del cinema d’autore e di più largo consumo. Il personaggio dello spietato e psicolabile tenente Hara, contraltare ideale dell’apollineo e a suo modo “misericordioso” capitano Yonoi – un giovanissimo Ryūichi Sakamoto, qui al lavoro contemporaneamente sulla sua prima colonna sonora originale per il cinema –, che con un sorriso infantile sul volto seviziava i prigionieri di guerra obbligandone alcuni a compiere seppuku, proiettò un’immagine inedita del ragazzo di Asakusa, dimostrando come la sua fisionomia e coloritura verbale potessero adattarsi coerentemente anche a un soggetto non semplicemente “cattivo”, ma persino drammatico nella sua instabilità mentale e ambigua redenzione – si pensi alla scena finale in cui Hara si improvvisa monaco nella sua cella, come se avesse preso i voti più per paura di una punizione divina dopo la morte che per un genuino pentimento –, lasciando intendere la versatilità del suo talento anche al di fuori dell’ironia pura.

Dal successo attoriale alla prima regia
Di lì a poco, le proposte per ruoli più strettamente drammatici, provenienti soprattutto dal cinema di genere, non tardarono ad arrivare. Dopo aver vestito i panni di un padre separato che decide di lasciare il mondo dello spettacolo per prendersi cura del figlio malato di tumore in Kanashii kibun de jōku (1985), che contiene degli spunti abbastanza profetici su quelle che sarebbero state le considerazioni più autocritiche a cui Kitano sarebbe pervenuto a fine carriera, egli si impone quale nuovo volto dello yakuza eiga con Yasha (1985) e Anego (1988) interpretando l’antagonista per antonomasia, al punto da venire scelto dal produttore Shōzō Ichiyama per la parte principale nel nuovo film del maestro del gangster movie nipponico Kinji Fukasaku.

Ci sono notizie discordanti in merito alle motivazioni che avrebbero portato quest’ultimo ad abbandonare il progetto: quello che sappiamo per certo, invece, è che Kitano non si lasciò sfuggire questa seconda, irripetibile occasione, andando a colmare il vuoto lasciato dal maestro dietro la macchina da presa. Fu così che quello che avrebbe dovuto essere l’ennesimo tassello della già corposissima filmografia di Fukasaku finì per diventare il debutto registico di Beat Takeshi, che forte sia della direzione artistica della pellicola che del controllo sulla performance attoriale – con sé stesso a interpretare il personaggio principale – trasformò radicalmente la sceneggiatura messa a punto da Hisashi Nozawa. Abbandonati i toni prettamente poliziotteschi della stesura originale, cui secondo alcuni anche Fukasaku avrebbe voluto mettere mano per darle un taglio comico-grottesco, il Violent Cop (1989) di Kitano si configura come una discesa agli inferi più disincantata e umana rispetto a quanto solitamente invalso nel genere: facendo cadere la dicotomia tra forze dell’ordine e yakuza, tra vittima e carnefice, tra corruttori e corrotti, la storia del detective Azuma e del suo peculiare senso di giustizia, che lo porta a punire con inaudita violenza i criminali – o presunti tali – prima di consegnarli ai suoi superiori, si scontra con una realtà professionale e personale degradata, priva di codice d’onore e dove le vendette oblique – di cui cade preda la sorella ritardata di Azuma – si sostituiscono agli scontri a viso aperto, la cui esecuzione consta comunque di sparatorie confusionarie e goffe, in antitesi con l’immagine dei sicari precisi e silenziosi di altri film coevi.

Alla sua uscita in sala, Violent Cop ottenne un’accoglienza tiepida sia a livello di critica che di botteghino, probabilmente più per una questione di premesse disattese – non dimentichiamoci che il progetto era stato inizialmente affidato a Fukasaku innescando un gioco di aspettative autoriali a livello di pubblico, valido sia per gli estimatori del regista che per gli spettatori occasionali – che per un’effettiva mediocrità di esecuzione. Al contrario, all’epoca il film lasciò perplessi – e forse un anche un po’ turbati – per la personalissima visione cui Kitano era riuscito a dar corpo sullo schermo, e che tradiva una concezione della vita sostanzialmente cupa e disillusa, che non lasciava scampo a nessuna categoria sociale o umana, nella spiazzante consapevolezza di una fondamentale tendenza della nostra specie a fare del male agli altri nel nome del proprio tornaconto.
Nonostante il modesto esito, si può dunque dire che l’esordio al lungometraggio di Kitano riuscì appieno nel suo primo intento, ovvero quello di mettere fine alla sovrapposizione – sino ad allora perfetta – tra maschera comica e corpo-autore, dimostrando una volta per tutte che il ruolo di personalità televisiva nazionalpopolare – ruolo cui Kitano non ha comunque mai rinunciato – poteva conciliarsi con quello di artista stilisticamente iconoclasta e intellettualmente autonomo, disposto a mettere alla berlina la società che l’aveva portato alla fama pur di perseguire il suo ideale artistico con coerenza.

Cosa aspettarsi da Asakusa Kid?
Disponibile su Netflix da giovedì 9 dicembre, Asakusa Kid è l’adattamento cinematografico della biografia omonima di Kitano data alle stampe nel 1988, in cui egli racconta i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo sotto l’egida del maestro Senzaburō Fukami, impresario teatrale e proprietario del teatro di varietà Furansu-za, dove tra uno spogliarello e un rakugo anche al giovane Take-kun fu data la possibilità di farsi notare.

Affidato alla regia di Hitori Gekidan aka Shōgo Kawashima, uno dei talenti comici più in vista degli anni Novanta – tanto da essersi guadagnato il titolo di Beat Takeshi della sua generazione –, il film è purtroppo invalidato da un’impostazione in tutto e per tutto televisiva, nel peggior stile J-drama: la recitazione eccessivamente macchiettistica, la prevedibilità dei dialoghi, la luce diffusa in ogni ambiente e a ogni ora del giorno, la macchina da presa posta “a distanza di sicurezza” per inquadrare sempre e comunque a figura intera, nell’ottica di favorire una chiarezza mostrativa esasperante, sono stilemi che rendono Asakusa Kid un’opera terribilmente anonima, non fosse per il “fattore Kitano” a tenere in piedi la baracca e a far sì che qualche volenteroso arrivi a sorbirsi due ore di visione, giusto per avere qualche dettaglio in più sul luogo che diede i natali artistici al regista entrato nella leggenda
Anche da questo punto di vista, però, la pellicola risulta deludente, in quanto non riesce – o forse non vuole – a catturare la vivacità del sobborgo di Asakusa da cui Kitano poté trarre ispirazione per il suo stile: ancor oggi una delle aree più genuinamente popolari di Tokyo e frequentato da un’umanità incredibilmente varia, spesso appartenente a quel mondo sommerso – yakuza, prostitute, artisti di strada – che il discorso pubblico tenderebbe a estromettere dalla narrazione istituzionale, il quartiere è descritto asetticamente e con eccessivo pudore, sia che la scena si svolga all’interno del Furansu-za che per le strade nei dintorni. Non si può però escludere che sia stato lo stesso Kitano, che nell’ultima fase della carriera non si è risparmiato critiche al proprio modo di vivere e intendere l’arte, a calcare la mano affinché questo racconto delle origini fosse il più candido possibile, in quello che potrebbe rappresentare un’ennesima prova di riscrittura della propria autorialità. Un dubbio che, nonostante quanto detto sopra, è sufficiente per motivare la visione di questo imperfetto Asakusa Kid.