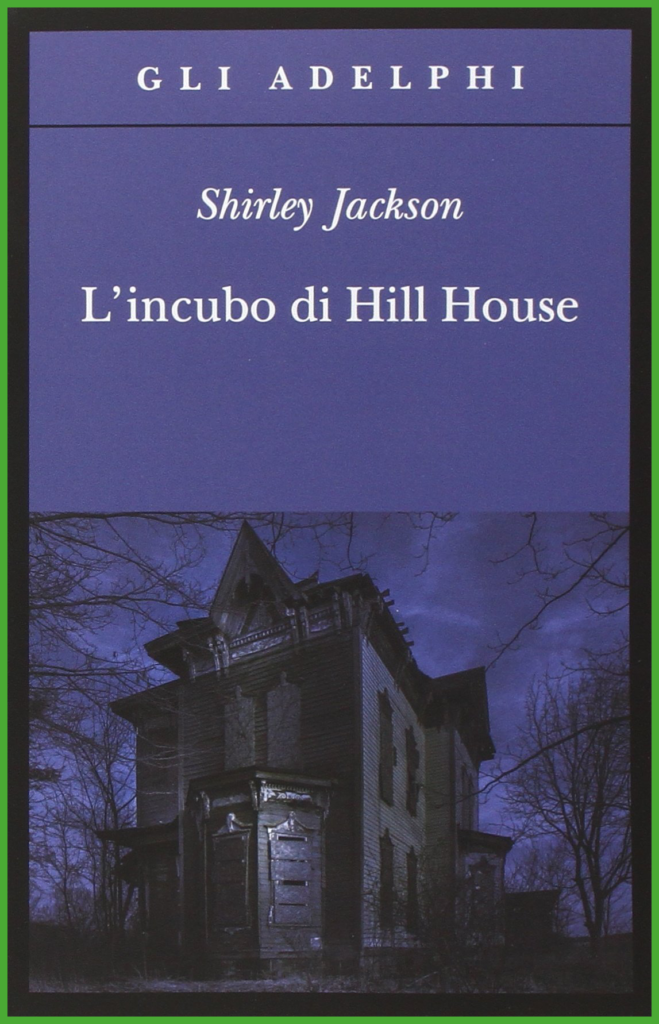er far coincidere le mie letture con l’imminente arrivo di Halloween, in ottobre mi sono dedicata a tre autrici che è possibile identificare come madre, regina e figlia del genere horror per quanto riguarda l’ambito letterario. Le protagoniste indiscusse del mio ottobre, quindi, sono state Shirley Jackson, Daphne du Maurier e Anne Rice. Tre autrici dissimili per molti versi ma per altri decisamente gemellate, tutte artefici di una narrativa horror che si distacca con particolare vigore dalla sua controparte maschile o che, comunque, regala ai lettori sensazioni raramente trovabili in altre opere annoverate allo stesso genere. Jackson, Maurier e Rice partono da un concetto specifico per poi diramarlo in tre universi letterari completamente diversi: perché il mostro deve necessariamente avere pelliccia, squame o artigli affilati? Perché la creatura più terrorizzante non può essere proprio l’essere umano?
Daphne du Maurier: l’horror dell’Io
Andando in ordine cronologico, partiamo con l’affrontare la prima delle tre autrici che è riuscita ad intrappolare nelle pagine dei suoi libri il demone dell’Io: Daphne du Maurier. Nata nel 1907 in Inghilterra, l’autrice di Rebecca, Jamaica Inn e Gli uccelli è considerata una penna sacra del genere horror, psicologico e gotico. A rendere ancor più iconici i suoi lavori è stato Alfred Hitchcock, regista noto per il suo occhio attentissimo all’universo femminile, il quale ha girato due lungometraggi tratti proprio dai libri di du Maurier, ovvero Rebecca – la prima moglie (1940) e Gli uccelli (1963), rimanendo legato alla all’autrice per tutta la vita.
La biografia di Daphne du Maurier è considerabile essa stessa un romanzo e anche di fattura stupendamente contemporanea. Nata in un contesto artistico, da due attori londinesi, l’autrice passa la maggior parte della giovinezza nel quartiere di Hampstead, sobborgo di intellettuali, artisti, musicisti e scrittori. Nutrita da un profondo, a tratti opprimente, affetto paterno e sobbarcata dalle aspettative di quest’ultimo, Daphne cresce con l’idea che suo padre avesse desiderato un figlio maschio al suo posto; così, in tenera età, sviluppa un alter ego maschile, chiamandolo Eric Avon, il quale la accompagnerà per tutta la sua vita come “the boy in the box”. Nelle sue dichiarazioni esce spesso il tema dell’identità: Daphne, infatti, sostiene in varie occasioni di sentirsi un’anima maschile intrappolata in un corpo femminile e, più in generale, di avvertire se stessa come qualcosa di diverso da un canonico sé:
“I was always pretending to be someone else… historical characters, all those I invented for myself…I act even to this day…It’s the old imagination working, a kind of make believe.”
Rebecca – La prima moglie
Il romanzo con cui intendo delineare la psicologia letteraria di Maurier è proprio Rebecca – La prima moglie. Scritto nel 1938, quando l’autrice aveva 31 anni, è sicuramente la sua opera più famosa, sollecitata dall’omonimo film hichcockiano. Nel romanzo, appartenente al genere gotico, più che propriamente horror, leggiamo di due protagoniste femminili: una senza nome e l’altra con un nome talmente ingombrate da prendersi il titolo del romanzo stesso. Queste due identità danzano in una trama elegantemente costruita, in cui nulla è lasciato alla superficialità dell’azione. La voce narrante priva di nome, una giovinetta ingenua e timida, si innamora perdutamente di Maximilian de Winter, proprietario dell’imponente tenuta di Manderlay; i due, incontratisi durante un soggiorno a Monte Carlo, si sposano frettolosamente e la nostra anonima protagonista assume finalmente un nome: la signora de Winter. Ma una signora de Winter esiste già. Si tratta di Rebecca, la prima moglie di Maximilian, morta un anno prima per annegamento.
È ben chiaro l’intento di Mourier. Il lettore si immerge nella mente di una ragazza priva di identità. La signora de Winter non ha passato, non ha aspetto, non ha famiglia e non ha neanche un nome proprio. Quando finalmente glie ne possiamo dare uno, ci rendiamo conto che esso è già stato assegnato ad un’altra esistenza, quella di Rebecca, una defunta che rivive nella mente della giovane sposina e nelle mura di Manderlay come un’inquietante presenza.
Le fondamenta dell’horror: Manderlay e Hill House
Du Maurier non è la sola ad usare l’espediente della casa infestata. Mentre Manderlay pare essere abitata solo da un opprimente ricordo, Hill House ha in tutto e per tutto l’aspetto di una dimora dominata dai fantasmi. Shirley Jackson (1916-1965) è l’autrice novecentesca che ha meglio saputo trasportare nel suo tempo il genere gotico, tipicamente vittoriano, regalandoci perle del brivido come La lotteria (1948), Abbiamo sempre vissuto nel castello (1962) e L’incubo di Hill House (1959). Quest’ultimo in particolare assume delle sfumature che ricordano quel Rebecca del ’38: anche qui la protagonista è una donna, Eleanor Vance, che si ritrova all’inizio del romanzo in una condizione di privazione dell’identità. Eleanor ha trent’anni e per tutta la sua vita ha accudito la madre malata; quando questa muore, la figlia si ritrova in un momento di stallo: convive con la sorella e suo marito, non ha un compagno, non ha un passato proprio, non ha una vita che possa definirsi sua. La lettera di un certo professor Montague, il quale la invita a passare l’estate in una casa infestata, sembra l’occasione perfetta per ricominciare da zero.
All’interno di Hill House avvengono strani fenomeni che qualcuno potrebbe definire paranormali, ma ogni volta che questi si presentano Eleanor e i suoi compagni (il rigido professore, Luke, l’egocentrico erede di Hill House, e Theodora, una ragazza estroversa e alla moda) non sembrano rimanere così traumatizzati dall’evento di per sé. La reazione che chiunque avrebbe di fronte ad un fantasma sarebbe quella di fuggire lontano, ma gli abitanti di Hill House restano e imprimono nella casa le loro paranoie, i loro sospetti e le loro invidie. Ma chi è il narratore della storia? Il romanzo è scritto in terza persona però Jackson ci rende chiarissimo quale sia il punto di vista, ovvero quello di Eleanor. Leggendo tra le righe, scopriamo in fretta che Eleanor è una donna piena di problematiche. Paranoica, ossessionata dal giudizio degli altri, tendente alla depressione, ella riversa nell’ambiente inquietante di Hill House tutte le sue oscurità e immediatamente capiamo che i demoni che la tormentano non sono tanto quelli della casa, ma quelli del suo stesso subconscio.
Hill House è una casa maledetta e oppressiva, con la quale, tuttavia, Eleanor instaura un insolito rapporto di solidarietà. La sua storia deprimente e carica di rancore è facilmente comprensibile dalla sua nuova ospite: Eleanor e Hill House sono, dunque, due facce di una stessa medaglia, incapaci di lasciarsi andare a vicenda, strette l’una all’altra da una profonda solitudine e da una condizione di inadeguatezza perennemente sotto l’occhio di tutti.
Sia Hill House che Manderlay hanno in comune un’interpretazione: entrambe sono dimore simboliche, prigioni che ricreano l’opprimente struttura sociale in cui le donne sono costrette a vivere e, allo stesso tempo, la loro stessa struttura mentale, che si richiude su di sé in una dimensione simbiotica con l’esterno, che non vuole farle fuggire. La signora de Winter non può lasciare Manderlay, perché lì abita l’uomo che ama e perché non ha una famiglia da cui tornare; Eleanor non può lasciare Hill House, perché essa rappresenta la sua prima boccata di libertà. Entrambe, sin dall’inizio dei romanzi, ascoltano i giudizi di chi le circonda, i quali dicono loro di andarsene, perché Manderlay e Hill House non sono luoghi adatti a loro. La signora de Winter è troppo giovane e ingenua per gestire una dimora prestigiosa come Manderlay, lei non sarà mai una moglie abbastanza brava, lei non sarà mai come Rebecca. Eleanor è troppo fragile per sostenere il peso psicologico di Hill House, è troppo impressionabile, non sarà mai coraggiosa come Theodora. Due protagoniste a cui viene in continuazione strappato l’Io e la fiducia in loro stesse.
Come si riesce a vivere fuori se non si è capito come vivere dentro?
L’elemento realmente spaventoso di questi due romanzi, allora, non è un mostro, ma la società stessa che riempie di demoni gli animi delle protagoniste. Il fantasma da esorcizzare non è fuori, ma dentro di loro, trascinato nella carne e nello spirito da un ossessivo bisogno di diventare qualcosa che non sono. E il punto realmente drammatico è: se non sono quello che la società vorrebbe che fossero, allora cosa sono davvero? A sconvolgere la psiche di Eleanor non sono i fantasmi che abitano Hill House (ammesso che essi esistano o che siano solo frutto della paranoia della protagonista) ma l’occhio delle persone con cui è costretta a convivere. Eppure Eleanor non può andarsene, perché sa che ovunque andrà troverà persone pronte a giudicarla inadatta e perché alla domanda di prima, a quanto pare, non ha trovato risposta. Come si riesce a vivere fuori se non si è capito come vivere dentro?
Le grandi tematiche di Jackson e Maurier, quindi, sono l’approvazione sociale di cui ogni donna è vittima e l’accettazione da parte del prossimo di una persona che soffre di disturbi mentali, ma anche la consapevolezza di sé e i disturbi mentali che nascono quando non si capisce quale sia la propria identità. Ciò che passa per debolezza e inadeguatezza è in realtà la condizione mentale di due donne reduci da traumi mai risolti. Jackson e Maurier domandano questo ai lettori: cos’è più spaventoso, i fantasmi o il giudizio del prossimo? Di cosa è bene preoccuparsi, delle presenze infestanti in una vecchia casa o del proprio ruolo all’interno di una ferrea società, che non ammette la debolezza, non comprende la complessità della mente ed esclude chi non rispecchia le aspettative degli altri? Il mostro è esterno o interno?
Un’allieva modello: Anne Rice e la figura del vampiro
Due romanzi che si contorcono graziosamente intorno al tema scottante della salute mentale danno largo ad un nuovo genere letterario, non più fatto di mostri, ma di presenze altrettanto feroci, di ombre opprimenti ed invisibili. Ferocia, ombra e invisibilità sono elementi che ricorrono spesso nell’immaginario dell’horror canonico e chi meglio della figura del vampiro sa riassumerli tutti e tre? Nel 1976 esce in America il primo romanzo delle Cronache dei vampiri di Anne Rice: Intervista col vampiro. Abbiamo fatto un salto temporale di 38 anni dalla pubblicazione di Rebecca – La prima moglie ma notiamo che Anne Rice ha ben recepito il messaggio delle sue predecessore.
Ci troviamo di fronte ad un’opera che ha dell’incredibile. Intervista col vampiro, dopo il Dracula di Bram Stoker, è l’opera che meglio afferma nell’immaginario comune l’identità del vampiro, una creatura di per sé ricca di simbolismi e profondamente metaforica. Così come i fantasmi di Hill House rappresentano i terrori più reconditi dell’essere umano e, allo stesso tempo, il penoso specchio di un’anima tormentata, anche il vampiro, inteso come lo intende Anne Rice, si tramuta in una condizione esistenziale con cui ogni essere umano è costretto a convivere. Quando pesa la morte? Quanto la morte dà senso alla vita? Questa è la domanda fondamentale che si pone Luis, il protagonista del primo romanzo delle Cronache del vampiro.
È il 1791. Luis è un uomo distrutto. Possiede una proprietà nei pressi di New Orleans e a tormentarlo è il suicidio di suo fratello. Privo di qualsiasi speranza nei confronti del suo futuro, anche Luis medita sulla propria morte, la desidera e la respinge come un tossicodipendente brama e aborra una droga. Eppure tutto è destinato a cambiare quando a Luis viene negata anche l’estrema scelta: egli non può morire, poiché è stato trasformato in un vampiro. Il topos della creatura immortale che agogna la morte è spesso messo in ombra dal più banale essere immortale che vive mille avventure, sentendosi potente come un Dio, inarrestabile e difficilmente incline agli umori di un’esistenza senza fine. Luis è un vampiro, un essere sovrannaturale, che tuttavia non smette mai di percepirsi come umano. Quel tormento dovuto ad una profonda tristezza e ad un perenne senso di perdita aprono una voragine nel suo petto che neanche la prospettiva di vivere una vita dissoluta e priva di conseguenze può cancellare.
Anne Rice costruisce, mattone dopo mattone, una saga letteraria in cui il centro non è il mostro, ma l’essere umano che vi si cela dietro. A sconvolgerci e farci provare la pelle d’oca durante la lettura non sono gli spargimenti di sangue e le vittime del vampiro, ma le tormentose angosce dell’uomo. Conditi da una profonda sensualità e da un erotismo che accompagna la disperazione, i romanzi di Anne Rice sono certamente frutto di una riflessione attenta riguardo il tema dell’identità.
La confusione psichica di un secolo
I mostri esistono da sempre nell’immaginario culturale dell’uomo e in ogni epoca hanno assunto caratteristiche diverse. Nell’antica Grecia le creature del terrore erano i morti dell’Ade, esseri larvali che languivano nel tormento; nel Rinascimento i mostri sono diventati i diversi, “l’altro” insinuato tra la gente: nascono così i primi vampiri, i primi lupi mannari e le prime streghe, intese come le intendiamo oggi, creature che si mescolano al popolo comune, tradendo ed uccidendo dall’interno. Il ‘900 è stato un periodo di profonda crisi identitaria. Ad aprire la parentesi è stato forse Freud e a tradurla in letteratura, come ci hanno insegnato un po’ tutte le professoresse e i professori di italiano del liceo, sono stati Italo Svevo, James Joyce e Virginia Woolf. Ma questa crisi identitaria quanto ha a che fare con il romanzo dell’orrore? Jackson, Maurier e Rice ci rispondono a gran voce e esprimono tutta la confusione psichica di un secolo in tre romanzi che hanno fatto la storia della letteratura.
Quando il genere umano viene messo di fronte alle due guerre mondiali e alla bomba atomica, i mostri in carne ed ossa iniziano a perdere il loro ascendente terrorizzante. Sono per lo più manichini, frutto delle menti giocose dei maestri del cinema. Ciò che si può rappresentare diventa il male minore. Il terrore di una nuova guerra, il peso dei morti, l’ombra minacciosa e silenziosa di un ordigno che in un nano secondo potrebbe cancellare mezza razza umana sono pericoli ben più tangibili dei fantasmi e delle streghe. Serve fare un passo oltre (o forse un passo indietro?) per sconvolgere gli animi, annichilire le certezze. Resta da esplorare la mente, vero e unico demone di ogni persona. L’indagine, quindi, non è più esclusivamente maschile, comunitaria ed eclatante, ma può tramutarsi in una lenta giostra guidata da donne, che parlano al singolo attraverso immaginari che hanno del surreale, ma che nascondono nelle loro pieghe una vivida connessione alla realtà.