Far Cry 6 è un caso paradigmatico dei problemi strutturali del videogioco blockbuster moderno
A meno che non viviate in una realtà parallela o in un mondo pre-internet, avrete sicuramente visto, sentito o almeno letto di Squid Game, la serie TV Netflix divenuta in poco tempo stella polare dell’intrattenimento mondiale. Nonostante la sua “importanza” mediatica, non sono riuscito a finirla, perché mi deprime (credetemi, a un certo punto parlerò di Far Cry 6). All’interno della serie, la metafora della condizione umana in una società capitalista è talmente evidente che risulta quasi parodistica, e una volta compreso il parallelo è stato molto difficile per me trovare altri stimoli che ne giustificassero la visione. Mentre il sottoscritto viveva in questo modo il rapporto con la serie, le vendite delle scarpe indossate dai personaggi della serie aumentavano del 145%, trasformando la serie in un nuovo, ennesimo caso studio de “l’effetto Netflix”, tenendo conto di quanto avvenuto con i prodotti mostrati in serie come La Regina degli Scacchi e la Casa di Carta. La lettura di questa notizia mi ha costretto a ritornare sul sempreverde dibattito sull’utilità di racconti, storie e finzioni “antisistema”, che però partecipano integralmente al sistema stesso.
Che credibilità può avere un’opera antisistema prodotta da chi si trova al vertice di quel sistema? Possiamo scindere artisti e produttori a partire dai testi con cui interagiamo? E soprattutto, come possono accogliere certe idee quelle masse che necessitano di questi racconti, se persino chi decide di dedicare la vita allo studio di questi fenomeni riesce difficilmente a districarne i messaggi? Per farla breve, ho riaffrontato uno di quegli elenchi di domande che nel corso della storia si sono poste persone molto più studiate di me, e la mia codardia si rinfranca del fatto che se loro non hanno trovato risposte, non devo trovarle neanch’io.
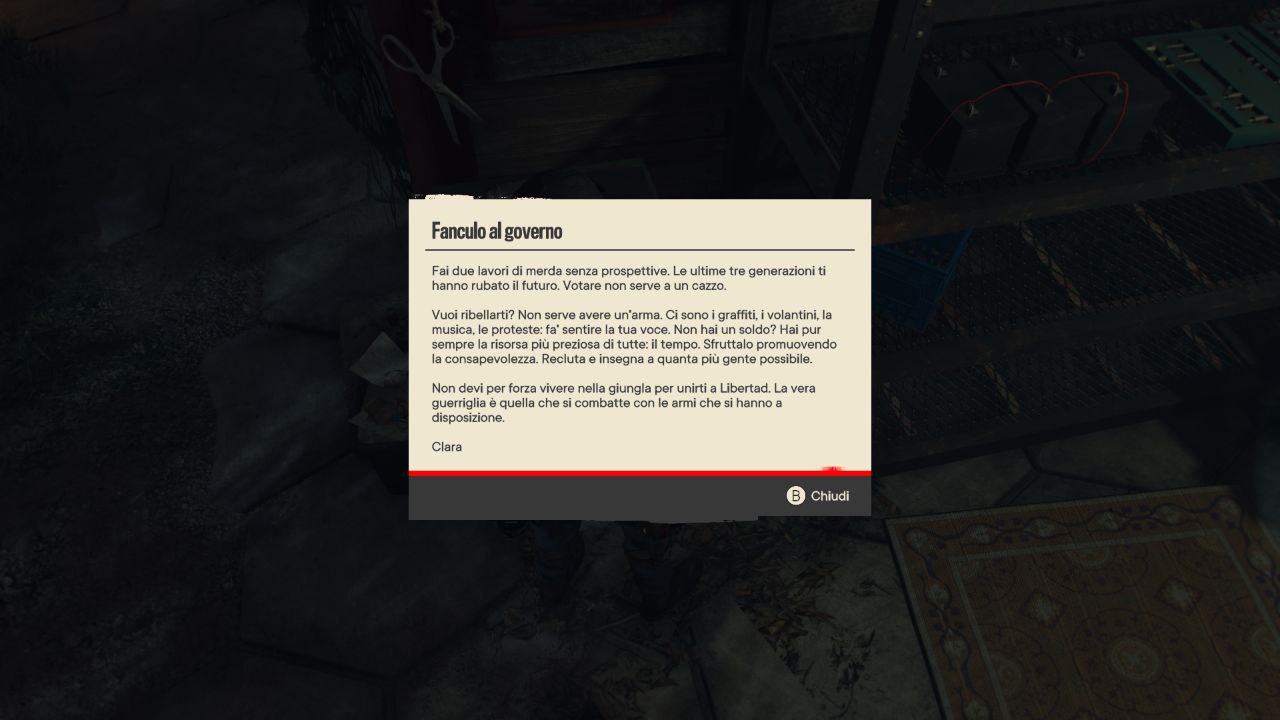
Quella stessa codardia che mi impedisce di dare una risposta definitiva mi lascia dunque in attesa di un evento che possa legittimare l’una o l’altra tendenza, a seconda del mio livello di nichilismo del mese. Una pellicola come Matrix viene così clamorosamente fraintesa da offrire uno dei simboli più famosi della misoginia globale?
“Aveva ragione Adorno, l’intrattenimento è Oppio dei Popoli!“; un modder usa il software di una grande corporazione per raccontare una storia di rivalsa o antisistema? “Dobbiamo riappropriarci dell’immaginario!”. Sarà per questa codardia che ciclicamente torno sui titoli Ubisoft, prodotti perfetti per non dare risposte e porre mille domande, in una sorta di atipica sindrome di Stoccolma videoludica.
Far Cry 6 è solo l’ultimo di una serie di tentativi da parte dell’azienda francese di parlare di resistenza, rivoluzione e conflitto sociale attraverso dei sistemi pensati per comunicare tutt’altro, e usando strutture in diretta contraddizione con quanto si desidera far emergere dai testi. Come recepire, ad esempio, il messaggio “anti Silicon Valley” e critico verso le aziende del Tech di Watch Dogs Legion, quando tramite l’accesso allo stesso gioco Ubisoft immagazzinava dati da rivendere? Chi ha scritto certe missioni sapeva di questo fatto? Dobbiamo distinguere creativo e produttore? È più importante il messaggio che emerge dal testo, o le conseguenze materiali della vendita del gioco? Ecco, vedete? Altre domande.

Con Far Cry 6, ho pensato finalmente di essere di fronte a un gioco con delle risposte, per quanto brutte. Infatti, sin dalle prime ore di gioco viene chiarito che Dani, il nome del nostro avatar, finirà per diventare una guerrigliera perché esserlo è la sua “indole”. In Far Cry 6 ribellarsi al sistema sembra essere un destino inscritto dentro di noi a livello genetico, e non una conseguenza delle condizioni materiali che viviamo. Alla fine del prologo, una delle comprimarie più importanti ci dice espressamente che non siamo fatti per lavorare in uno dei “loro centri commerciali”, che “il sogno americano non è per quelli come noi”, e che siamo nati per lottare per la libertà. In un’era come questa, dove muri tornano a essere innalzati e i cambiamenti climatici obbligano milioni di persone ad abbandonare controvoglia le loro case, messaggi simili rischiano di passare per paternalisti, quando non direttamente reazionari.
Eppure anche in Far Cry 6 le risposte hanno ceduto il passo alle domande. Infatti, ci sarebbe in realtà un’altra potenziale lettura delle prime ore di gioco, legata al fatto che queste frasi le pronunciano dei giovani che ancora non sanno cosa stanno per affrontare, e forse non è un caso che personaggi che hanno già vissuto (e vinto) una rivoluzione siano restii ad avviarne un’altra. Il problema è che sarebbe pure interessante discutere delle potenziali letture della sceneggiatura e delle interpretazioni dei dialoghi, ma tutto quanto viene soffocato, quando non direttamente contraddetto, dalla solita, assoluta e invadente intromissione del “gioco”.

Vi chiedo la cortesia di non chiedermi di descrivere cosa si fa in Far Cry 6: ammetto candidamente la mia irrilevanza rispetto al video, e vi rimando a un qualsiasi gameplay presente su YouTube. Quello che invece mi preme evidenziare e come lo si fa: a cazzo di cane. In Far Cry 6 non hanno infatti senso né la messa in scena, né il mission design. A volte siamo obbligati a muoverci in stealth e altre volte no, anche se le situazioni proposte sono sostanzialmente identiche; a volte i nemici arrivano a ondate, altre volte ce ne sono solo un pugno per proteggere roccaforti fondamentali; delle volte gli alleati ti aiutano nelle varie attività, restituendo una dimensione collettiva alla rivoluzione, altre volte (la maggior parte) siamo il più classico dei “One Man Army” contro l’intero esercito di Yara, l’isola immaginaria ispirata a Cuba dove Ubisoft ha ambientato le vicende del gioco.
A proposito di Cuba immaginaria: i costanti riferimenti a vicende storiche realmente accadute, che però non vengono mai esplicitati, permettono a chi conosce la storia di intuire le ideologie dietro le fazioni in gioco, lasciando lo spazio a chi vuole solo sparare di… Beh, sparare. Queste scelte sembrano suggerire che certe missioni, temi e concetti siano più tentativi di intercettare target specifici che non sinceri desideri creativi. Ricorrendo alla sua tradizionale capacità di dire tutto per non dire nulla, Far Cry 6 esprime così il suo unico, vero interesse: sparare.
Sparare agli animali, alle cose, alle persone, in ogni contesto e in ogni situazione. Per prenderne atto, basta analizzare la meno fraintendibile di tutte le sue forme di comunicazione: l’interfaccia. Grazie ad essa, Far Cry 6 si mostra definitivamente come un costante dialogo tra un lanciagranate e un AK47, tra un palazzo in esplosione e un elicottero in caduta libera.
Forse consapevole di queste dinamiche, lo studio ha optato per la più classica delle tecniche narrative videoludiche, con la quale giustificare l’agire del personaggio. Il ricorso a una formula di “bioshockiana” memoria alla fine è anche interessante come idea, ma la resa finale risulta quasi parodistica, a causa dell’immensa mole di contenuti, sempre sullo sfondo ma sempre rumorosi. Il desiderio, per quanto carente, di raccontare un popolo in rivolta, una rivoluzione credibile, una resistenza all’imperialismo occidentale, viene così soffocato dal rumore dei proiettili e dallo stimolante consumo dei contenuti offerti dall’azienda.
In La Voce narrante del padrone, Francesco Pacifico scrive: «Io ho la sensazione che il tipo di libro europeo e americano di cui sto parlando sia un’appendice – di nicchia, dei felici pochi, dei giusti, dei progressisti ma anche dei rivoluzionari – di quella stessa missione. Il tipo di libro che una certa parte della scena letteraria occidentale sta facendo è una nuova forma di quell’idealismo americano e di messianismo europeo dove chi parla si autoaccredita, si proclama giusto, si smarca da altre parti – deteriori – dell’impero. È come se i libri di cui parla Taylor dicessero: “ora la missione di educare il mondo non ce l’hanno più quegli altri, fidatevi di noi, che guardiamo quel che siamo con lucidità”, ossia che occupiamo le posizioni giuste».

C’è una scena di Far Cry 6 dove Castillo, il cattivo di turno, rinfaccia a una giornalista americana il fatto che al consumatore americano non importi nulla di come viene prodotta la cura per il cancro (team centrale del What if del gioco), di come l’intero Occidente si basi sullo sfruttamento dei più deboli. Abbiamo giusto il tempo di tracciare un parallelo con chi raccoglie i pomodori delle nostre salse, che ci troviamo a inseguire una mangusta impazzita in giro per un villaggio, sparando a destra e manca pur di ottenere il tesoro promesso.
Ecco, io penso che il videogioco “blockbuster” occidentale non solo partecipa con gioia a quell’autoindulgente processo di condanna e al contempo di riposizionamento tra i giusti che citavo prima, ma mi pare non abbia neanche il coraggio di farlo fino in fondo, perché se narrativamente sembriamo subire i “contraccolpi” del sistema che diciamo di combattere, ludicamente noi siamo il sistema: padroni assoluti di spazio, tempo, vite. Far Cry 6 ci ricorda che il come viene detto qualcosa forma la vera sostanza del cosa viene detto, e riconferma che, come spesso accade con le grandi produzioni dell’industria culturale, è nelle sue più evidenti contraddizioni che risiede il suo valore più alto, per quanto celato.








