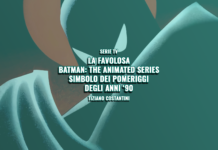Gli ultimi giorni di Tolomeo Grey è la nuova miniserie su AppleTv+ che indaga il labirinto della mente di un uomo affetto da demenza senile
he profondo terrore quello che sanno incutere i labirinti della mente. Che corsa lungo la vertigine può essere quella dietro alle fila di una vita che scorre via, un po’ più in là, un po’ più dietro la collina del tempo. “Nel labirinto della mente” era anche il sottotitolo italiano di Stay, claustrofobico film del 2005 per la regia di Marc Foster, che indagava le allucinazioni tra il giallo e il verdognolo di un Ryan Gosling che qualcosa lo stava per perdere per sempre, dove le memorie si facevano incerte e mescolate a un’ultima fantasia.
Dopotutto i ricordi, l’atto stesso del ricordare, qualificano un’intera esistenza. Ne sostanziano il valore, spesso ne traggono le ragioni del chi siamo oggi, di come ci approcciamo al presente che è solo un cavillo sospeso nel mezzo tra le convinzioni di ieri e le aspirazioni del domani. E quindi che terrore il pensare di poter perdere tutto e rimanere con un pugno di mosche in mano. Puf. Quel pomeriggio irradiato dalla luce morente di un sole autunnale, quelle immagini veicolate dai processi sinaptici e archiviate come sensazione perfetta in una stanza del cranio che a un certo punto se ne vanno, si staccano dalla corteccia cerebrale e si sciupano in chissà quali meandri. Evaporano e non si possono più afferrare. Che terrore.
Che paura dover convivere con la consapevolezza dell’esistenza di subdole malattie neurodegenerative come l’Alzheimer, morbo che rosicchia la vita un poco alla volta portandosi appresso quei perché, quei per come, quei chi sono. Chissà che groviglio di sensazioni indecifrabili deve essere il mondo di Tolomeo Grey, uomo di 93 anni affetto da demenza senile che deve districare i nodi di un’esistenza che gli sta mettendo di fronte nuove prove da superare. Gli dà anima e corpo Samuel L. Jackson nella nuova miniserie su AppleTV+ Gli ultimi giorni di Tolomeo Grey, adattata dallo scrittore Walter Mosley a partire dal suo omonimo romanzo del 2010.
Tolomeo, Ptolemy in originale, una creatura in apparenza scorbutica e pure scostante, prigioniera nel proprio castello di ricordi che ogni giorno lascia cadere in terra un mattone in più. Circondato nella sua casa di Atlanta da oggetti accumulati alla rinfusa in salotto, in cucina, nella camera da letto. Piccole montagne di questo e quell’altro che forse conservano la memoria di un tempo che per Tolomeo sembra fermo, congelato (l’orologio lo mette in frigorifero) e ora più che mai indistricabile. Gli oggetti e i luoghi la memoria la conservano, sempre, ma richiedono in cambio il dazio di una mente pronta a interpretare i segni, a collegare i tasselli, a creare il senso come fa la piccola Marion (Gabrielle Sanz) dello splendido Petite Maman di Celine Sciamma.

A Tolomeo questo privilegio pare oramai celato per sempre. Il suo intermediario con il mondo esterno a quelle mura che non abbandona mai da solo è Reggie (Omar Benson Miller), che a inizio serie muore all’improvviso. Tra una peripezia e l’altra in casa del papa Grey finisce la giovanissima Robyn (Dominique Fishback), alla quale spetta il gravoso compito di entrare in lunghezza d’onda con un uomo la cui frequenza è un flusso impazzito e talvolta inafferrabile. Di certo non è semplice stare al fianco di queste persone. Non è facile nella convivenza quotidiana, così come non lo è soprattutto nel viverne il progressivo decadimento interiore, l’abbandono del contatto con la realtà di cui sono vittime inconsapevoli.
Sul grande schermo chi ne ha parlato di recente nella maniera più sincera e aperta è stato senza alcun dubbio un altro meraviglioso film come The Father di Florian Zeller, regista al suo esordio cinematografico che adatta la sua omonima pièce teatrale del 2012. Un’opera per diversi versi lancinante quella di Zeller, che affonda nelle oscurità di una mente decadente restando addosso alla figura del ‘padre’, un Anthony Hopkins disorientato e disorientante all’interno del piccolo mondo della sua abitazione che muta a vista d’occhio al pari dei volti che paiono entrare e scambiarsi di posto di continuo.

Una performance sublime che a Hopkins è valsa il suo secondo Oscar, traghettata dalla paura all’arroganza, dalla sfacciataggine a un pianto primordiale. Un film dove gli spazi hanno rilevanza fondamentale, dove la casa è l’unica struttura alla quale aggrapparsi e che si fa subdola con le sue tavole apparecchiate che scompaiono o le poltrone prima occupate e poi no, dalle quali magari osserva quella figlia (Olivia Colman) che ha il cuore spezzato e alla quale spetta una scelta dolorosissima.
Sono uomini perduti quelli di Zeller e Mosley, partoriti dalla carta di un copione o di un romanzo ma affiancati da migliaia di altri uomini e donne in carne e ossa che cercano di rammendare i brandelli svolazzanti di un’ultima fugace apparizione, di un ultimo istante di lucidità per potersi riconoscere ancora come un “Io” che sa dire “Questo sono”. Per il resto rimane un’umanità vulnerabile, nuda a se stessa, rimessa alla grazia di un mondo che non sa comprendere più e dal quale viene tiepidamente investita con un tenue raggio di luce che filtra dalle tapparelle della finestra.