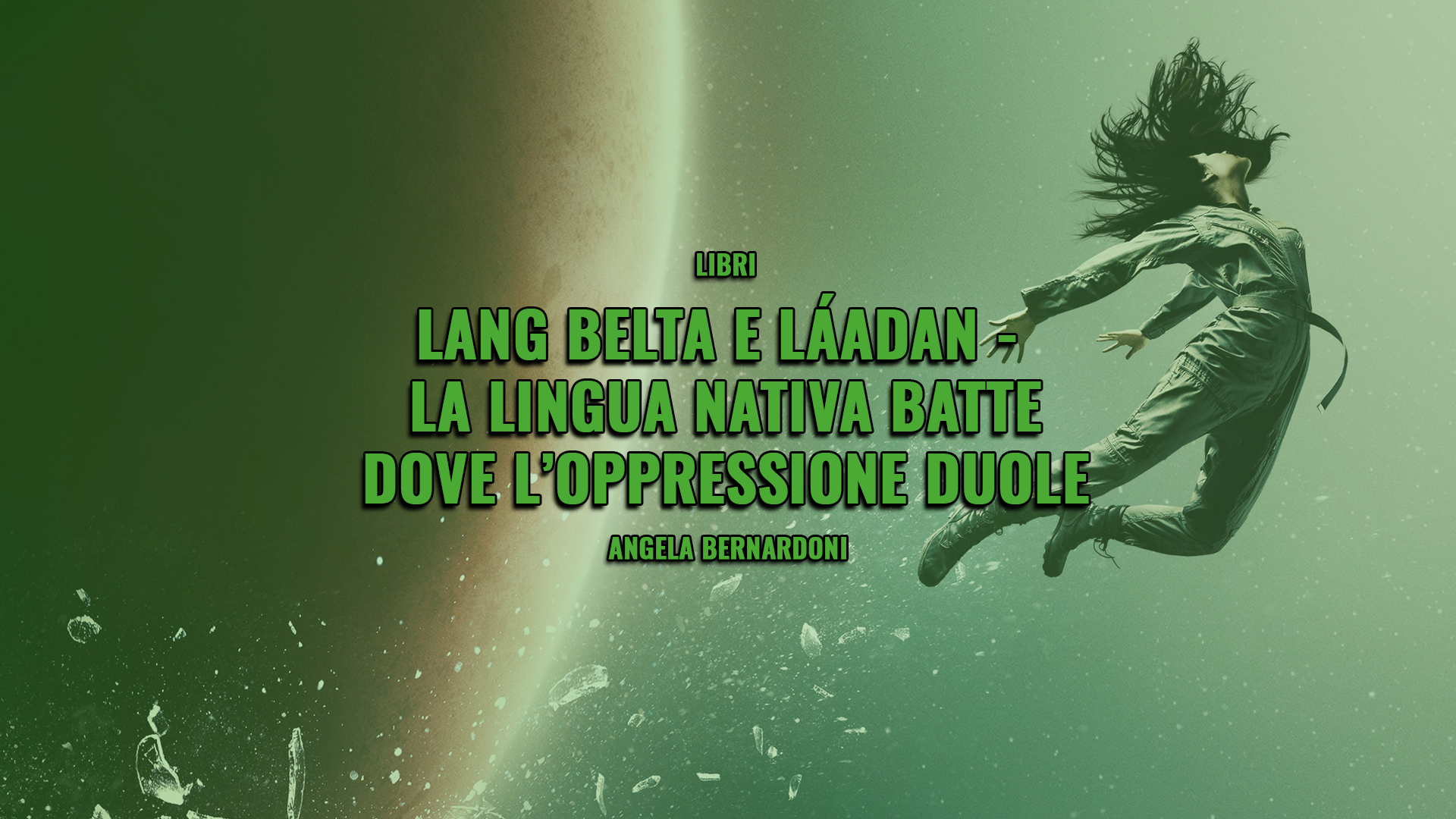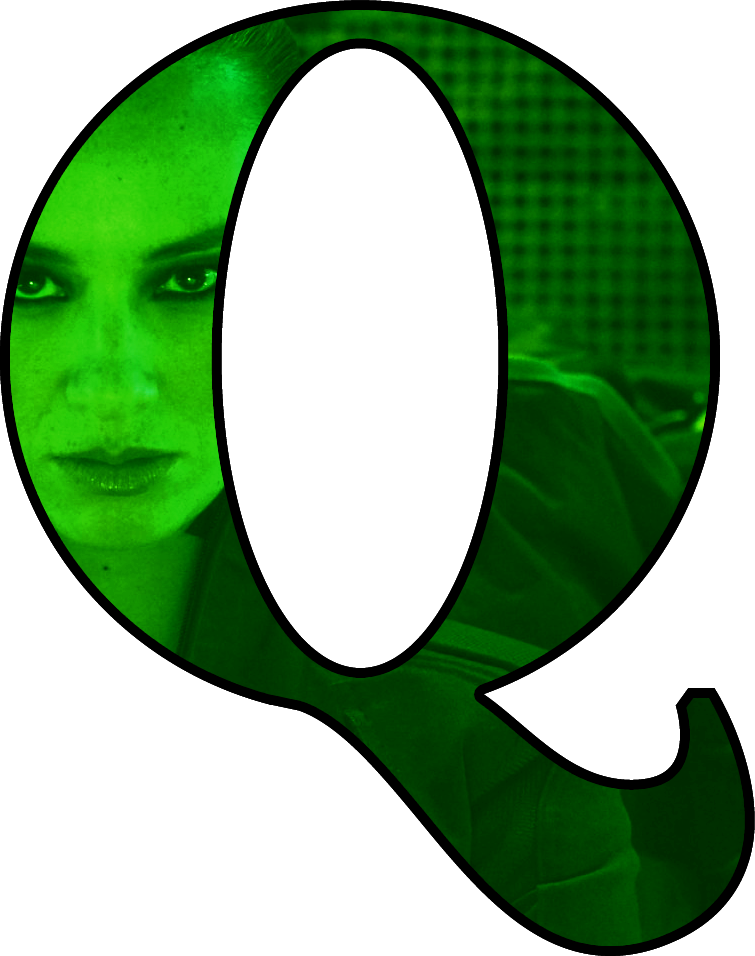Oye beratna unte sesana mi, to showxa lang belta ke?
uesto, come potrete immaginare dall’incipit creolo, è un articolo che parla di lingue immaginate, inventate, create a tavolino – lingue artificiali, secondo wikipedia Italia, conlang (constructed languages) in inglese. Spingendo oltre il vostro sforzo immaginativo, vi verrà da pensare a Tolkien e le sue lingue elfiche, al Klingon di Star Trek, al Dothraki, a quel Dracarys che infiniti addusse lutti agli essossiani. Non posso dirvi di no; quelli che trovate qua sopra sono tutti esempi di conlang – così come il Galach in Dune, o il Mando’a creato da Karen Traviss per The Mandalorian – ma visto che sono esempi che vi sono sicuramente venuti in mente, possiamo passare oltre e concentrarci – in questo vasto mondo di linguistica aliena – su uno specifico tipo di conlang, che nasce dal pidgin e si evolve in creolo, che nasce dall’oppressione ed esplode nella ribellione.
La frase che avete letto all’inizio di questo articolo è in Lang Belta, il linguaggio creolo che si parla, nell’universo di The Expanse, nella Belt, ovvero la cintura di asteroidi e planetoidi che circonda i pianeti interni – Marte e Terra – e che da questi due pianeti è stata colonizzata e sfruttata grazie a persone in cerca di lavoro migrate in questi ambienti di vita poveri di comfort (basilari, come luce, aria, acqua) ma ricchi di materie prime da estrarre (e inviare a Terra e Marte, of course). Il linguaggio parlato dai belters è l’evoluzione di un pidgin formato da parole e grammatiche di lingue terrestri – una miscela di Inglese, Cinese, lingue romanze come il Francese, Tedesco, Persiano, Ebraico, e Zulu, rivela il creatore della Lang Belta, Nick Farmer – che questa manodopera dei colonizzatori ha portato con loro nello spazio. Le parole delle lingue madri di questi expat in cerca di lavoro si sono mischiate tra loro in una lingua franca che dopo aver sviluppato una propria basilare grammatica ha iniziato a essere parlata, dalle nuove generazioni di abitanti dello spazio esterno, come lingua nativa.
La Lang Belt si è così evoluta in una lingua creola in grado di rappresentare l’identità e i sentimenti del popolo che la parla. Beltalowda è il termine che identifica gli abitanti della Belt come gruppo, come classe oppressa – infatti per un belta, la peggior onta è essere definito un welwala, traditore amico dei terrestri. Così come il creolo haitiano nasce come lingua delle persone in schiavitù nelle colonie francesi delle isole caraibiche, la Lang Belt diventa uno strumento di riconoscimento all’interno delle non dichiarate ma effettive colonie terrestri e marziane che gravitano ai bordi del sistema solare. Nella serie che traspone i romanzi, conclusasi quest’anno su Amazon Prime, la lingua parlata dai belters è fortemente presente e sebbene gran parte delle personagge e dei personaggi ne usino una forma in cui si alternano parole e strutture belta con altre dell’inglese standard parlato su Terra e Marte, il ricorso alla Lang Belta è più forte nei momenti in cui è necessario far divampare quel sentimento di beltalowda, di appartenenza, di senso di comunità.
Del resto, una definizione di cui si è persa l’origine nel tempo – ma che sembra essere stata data per la prima volta negli anni ‘40 del secolo scorso dal linguista Max Weinreich – recita, nella versione britannica a opera di Charles Randolph Quirk, che una lingua è un dialetto con un esercito e una bandiera ma, mi sento di aggiungere, in questo caso la lingua diventa anche una vera e propria dichiarazione di guerra.
Nel romanzo di Ursula K. Le Guin I reietti dell’altro pianeta, i secessionisti del pianeta-luna Anarres creano per la loro nuova, anarchica società, una lingua che ne rispecchi i valori. Rifiutando la lingua del loro pianeta-luna di origine, Urras, le adepte e gli adepti di Odo sviluppano il Pravico, una lingua in cui non esistono pronomi possessivi – al posto di: “Questo è il mio e quello è il tuo”, in pravico si diceva: “Io uso questo, tu usi quello” – perché non esiste il concetto stesso di proprietà (allo stesso modo il pravico non ha termini possessivi per l’atto sessuale [e] non aveva senso per un uomo dire che aveva “avuto” o “posseduto” una donna. La parola più vicina come significato a “fottere” […] era un termine preciso: voleva dire violentare).
La lingua definisce concetti e apre uno spazio di resistenza interiore e, come scrive la professoressa Caterina Marrone nel suo saggio Le lingue utopiche riguardo la Neolingua orwelliana, se le strutture linguistiche condizionano la mente e imprigionano l’intelletto nei loro schemi, la manipolazione della lingua potrà servire ad assicurare il controllo dei cervelli. Una persona che, parlando, non avrà le parole per definire un’azione, un concetto o un’emozione, si convincerà in breve tempo che quell’azione, concetto o emozione non ha spazio e non deve essere espressa, né pensata. Al contrario della distopia di 1984, però, la Lang Belta e il Pravico creano parole, creano forme di comunicazione. Trovare nuove forme per esprimere dissenso, anziché distruggere e sopprimere strutture, trasformando interi campi semantici in cumuli di macerie, nei casi da noi presi in esame sembra essere una strategia messa in atto dalle minoranze nel tentativo di sottrarsi alla soverchiante violenza dei colonizzatori.
Le donne del futuro distopico che ci presenta Suzette Haden Elgin nel suo romanzo del 1984 Lingua nativa – linguiste da generazioni, allevate fin dalla nascita all’apprendimento di lingue aliene necessarie per la continuazione del sistema capitalistico a livello universale – useranno proprio una nuova lingua, il Láadan – la lingua delle donne – per comunicare tra di loro senza interferenze da parte dei padri (letteralmente) padroni che le opprimono. Poiché la comunicazione definisce il tipo di relazione, parlare una lingua condivisa, sconosciuta al nemico, dona una almeno momentanea libertà per sottrazione, uno spazio in cui affermare la propria identità escludendo l’altro, il padrone, lo sfruttatore. Come per la Lang Belta, anche il processo che porta il Láadan a passare dal pidgin alla lingua creola, per poi diventare una lingua nativa non è immediato e ricorda, anzi, un atto di fede nelle generazioni del futuro, in grado di portare avanti la rivoluzione iniziata dalle loro antenate.
Questo perché una lingua viva non è mai finita, una lingua viva si evolve con la società e con i pensieri di chi la parla; concetto quanto mai discusso in questo nostro momento storico di nuove forme di inclusione linguistica delle complessità della società, osteggiata da chi, in certi casi, preferirebbe una lingua morta a una lingua in grado di adattarsi a nuove visioni, a chi vorrebbe negare il valore identitario, comunitario, politico delle parole che usiamo, a chi preferisce affidarsi al Grande Fratello per ridurre la lingua all’osso, piuttosto che vederla mutare.
Tuttavia – ci viene ancora una volta in soccorso Ursula K. Le Guin, stavolta con una citazione da La mano sinistra de buio – osteggiare una cosa non fa che affermarla. Concetto che a certi linguisti più o meno improvvisati, sembra sfuggire ancora oggi.