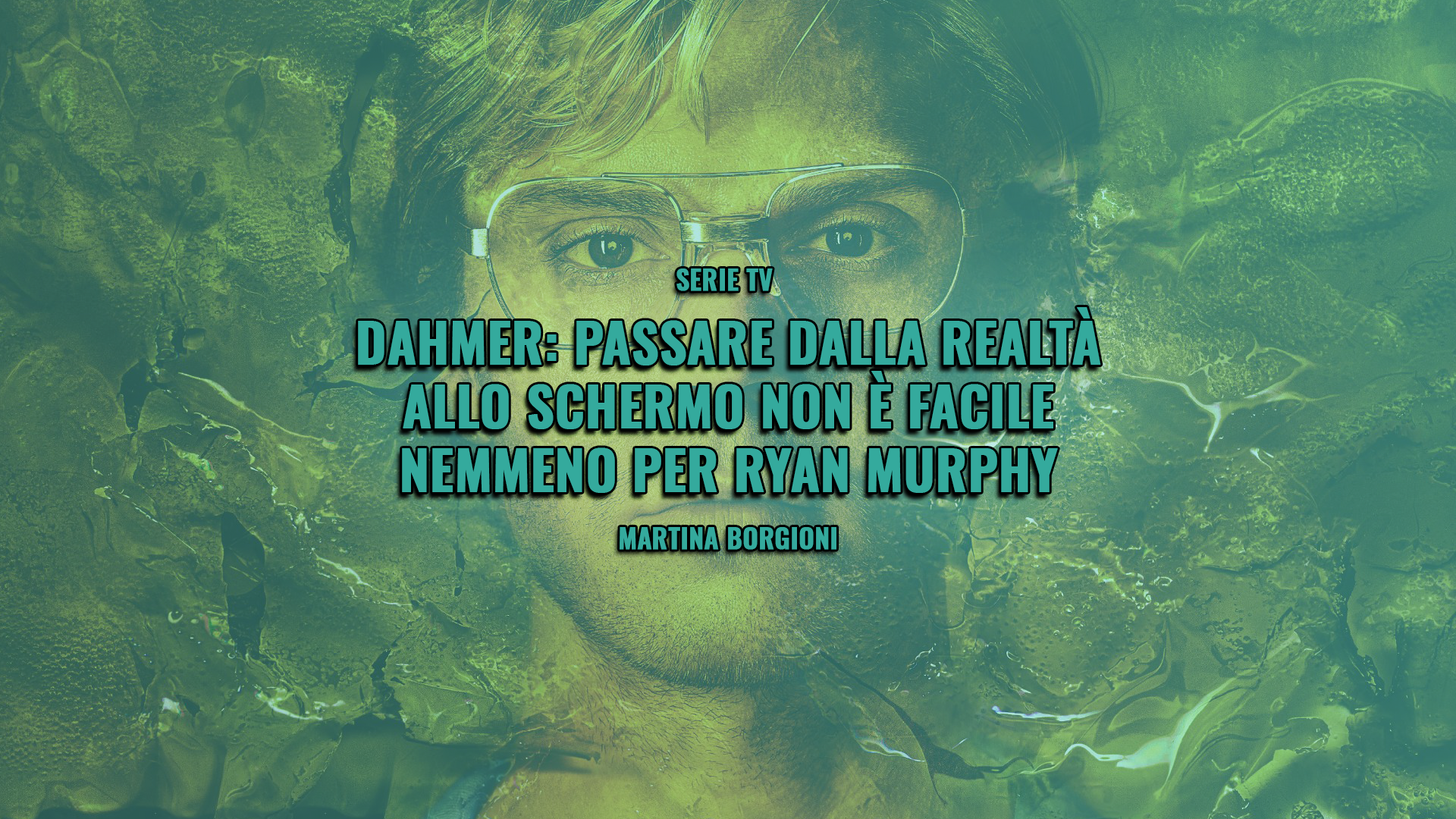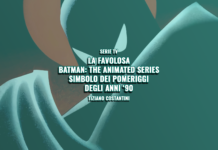Jeffrey Dahmer di Ryan Murphy diventa scandalo e rivoluzione, sfiorando il confine dell’indecenza e ispirando i più accaniti fan del genere
erlustrando il vostro catalogo streaming, vi sarete certamente imbattuti nella nuova serie originale Netflix: Mostro – La storia di Jeffrey Dahmer. La miniserie è un’indagine nella vita e nelle vittime di Jeffrey Dahmer, uno dei più scabrosi serial killer degli Stati Uniti, attivo tra il 1978 e il 1991. Il progetto televisivo ha creato immediatamente scalpore tra il pubblico, suscitando l’ira e il disgusto di moltissimi spettatori, tra cui i parenti delle vittime dello stesso Dahmer, ma anche l’ammirazione tra i più amanti del genere, creando così una spaccatura importante. Tra le due schiere, io mi ritrovo tra le fila di coloro che hanno trovato quest’ultima opera di Ryan Murphy e Ian Brennan (menti dietro serie come Glee, Hollywood e Ratched) eccessiva, priva di un vero e proprio focus ma, allo stesso tempo, rivoluzionaria.
Evan Peters è Jeffrey Dahmer
Mostro – La storia di Jeffrey Dahmer vuole ripercorrere, passo dopo passo, la vita dell’assassino, restituendo al pubblico un quadro più o meno chiaro di chi fosse Dahmer, di chi fossero le sue vittime e in cosa consistette l’ambiente sociale in cui quest’uomo è cresciuto e ha ucciso. Ad interpretare l’omicida è Evan Peters, attore dalla luminosa carriera per quanto riguarda l’interpretazione di personaggi ambigui, violenti e mentalmente instabili. Calato in una performance del tutto familiare, Peters ci regala una buona performance (sebbene trita, per quanto riguarda i trascorsi dell’attore), che ha dei tratti controversi. Molti di noi conoscono Peters anche per il suo fascino innegabile, per il suo sguardo che buca la cinepresa; i suoi ruoli più iconici, anche se nei panni del “cattivo”, sono sempre ammantati di seduzione e macabro romanticismo. Per ora nulla di male, essendo questi ruoli di finzione: ma cosa accade quando il tuo viso deve prestarsi ad un assassino realmente esistito? Le cose forse cambiano. Alcuni online si sono lamentati dell’eccessivo ascendente fascinoso di Peters. Una mancanza di tatto che spinge molti spettatori a nutrire nei confronti del protagonista della seria qualcosa di diverso dal ripudio e dalla rabbia.
Mi ritrovo ad andare contro questa polemica. Evan Peters è un attore feticcio di Ryan Murphy: un buon interprete e somigliante fisiognomicamente a Jeffrey Dahmer. Mettere al rogo il povero Evan per essere semplicemente un attore carismatico mi sembra eccessivo. Oppure è possibile che il pubblico se la stia prendendo con l’elemento sbagliato? Perché la serie ha destato tanto scandalo? Forse non è colpa di Evan Peters, ma della struttura narrativa stessa del prodotto e del suo occhio registico, che tende a spettacolarizzare con un po’ troppa enfasi le pratiche del protagonista e roanaticizzare il serial killer.

Lo “show don’t tell” di Ryan Murphy portato all’ossesso
Nel primo episodio ci viene immediatamente presentato il personaggio di Jeff. Entriamo nel suo rancido mondo e ne assaporiamo uno spaccato terrificante, che inquieta e lascia sotto shock: uno “show don’t tell” portato all’ossesso. Trattare di un serial killer tramite la televisione è un’impresa ardua e, sicuramente, che il primo sguardo sia impressionante è una cosa positiva. Inquietudine, angoscia, odio, rabbia, ribrezzo sono fortissime emozioni che si ripropongono, episodio dopo episodio, fino a generare una sorta di nausea. Affiancate a scene che ci propongono la genesi del serial killer, i suoi tormenti interiori e le sue nevrosi, ci sono tantissime altre scene che propongono l’operato di Dahmer come un teatro degli orrori, senza risparmiare nulla alla vista dello spettatore. Sfido i più duri di stomaco a reggere alcune scene agghiaccianti dell’episodio primo, secondo e decimo.
Negli ultimi due episodi ci viene raccontata frettolosamente la storia che invece io avrei voluto sentire per tutto il corso della serie: il processo, la reazione del popolo americano, il “post” delle famiglie delle vittime, la denuncia della cialtroneria della polizia americana, il pregiudizio della polizia nei confronti dei quartieri abitati da persone nere, asiatiche, omosessuali e, quindi, marginalizzate. Il concetto di “rimozione” in contrasto con quello di “memoria”. Dando moltissimo (forse troppo?) spazio alla personalità disturbata di Dahmer e al suo percorso da omicida, si tende a tralasciare aspetti molto interessanti del suo caso; un caso, ricordiamolo, famoso anche per l’enorme impatto che ha avuto sulla gente.
- Leggi anche: 10 indimenticabili serial killer del cinema
Le storie sono fatte per chi resta
Raccontare approfonditamente la storia di un serial killer vuole dire affrontare le conseguenze che le sue azioni provocano nella società. Il caso Dahmer ha raggiunto una vastissima notorietà anche per il terribile riflesso che ha fornito del popolo americano. Formulare dieci lunghissime puntate e parlare solo nelle ultime due di queste conseguenze è fallace. Murphy ci ha abituato al suo sguardo disturbante e alla sua passione per la truculenza. Sappiamo quanto ami sviscerare i suoi protagonisti sotto una lente estetica e d’immagine. Ma qui fa un passo falso di troppo, creando quasi un gioco morboso tra l’occhio del pubblico e lo schermo del televisore, continuamente inondato di immagini violente e disturbanti. È necessario mostrarci, con dovizia di particolari, tutte le azioni del protagonista, con l’aggravante di essere realmente successe? È necessario farlo ora, in un momento storico in cui molti parenti delle vittime sono ancora vivi e in possesso di un televisore? Si sarebbe potuta compiere una narrazione altrettanto forte ma con una minore spettacolarizzazione del dolore?
Se è vero che le storie sono fatte per chi resta, questa storia è fatta per chi se n’è andato. Dahmer e le sue vittime sono morte, ma qui rivivono senza nessun ammortizzatore. Le famiglie, i poliziotti responsabili in parte della carneficina effettuata da Dahmer, il modo in cui i genitori dell’assassino hanno affrontato la situazione, il processo, le testimonianze, la completa negazione da parte dello Stato del ricordo delle vittime e la brutale follia di centinaia di persone che hanno adorato Dahmer come una rock star: tutto questo è il succo che la serie avrebbe dovuto spremere. C’è da dire che l’attenzione avuta nella ricostruzione dei fatti è incredibile e che questa serie segna un punto di non ritorno per chi, in futuro, vorrà approcciarsi al genere del true crime. Eppure il confine tra ciò che “si può far vedere” e ciò che è meglio levigare è molto sottile, in queste circostanze. Non sono certa che Murphy lo abbia rispettato.

Miniserie o sequestro di persona?
Un grande problema della serie è anche la sua eccessiva lunghezza. Abbiamo accennato che la storia di Dahmer è contenuta all’interno di una miniserie, eppure io di “mini” non c’è proprio nulla. Dieci puntate da un’ora ciascuna compongono il titolo Netflix, rendendolo un’effettiva serie TV dal ritmo e dai contenuti estenuanti. Il metodo estetico del progetto è estremamente simile a quello della miniserie del 2019 When they see us, che racconta la vera storia di cinque adolescenti neri di Harlem ingiustamente accusati di un attacco violento nei confronti di una ragazza bianca a Central Park. Il taglio documentaristico della serie si racchiude in quatto episodi magistralmente realizzati, ricchi di particolari e capaci di scuotere nel profondo. Quattro ore per raccontare un fatto estremamente complesso, pieno di implicazioni politiche, sociali e culturali. A Ryan Murphy glie ne servono dieci e il risultato è dieci volte più vuoto.
Quando ho letto “miniserie” accanto al titolo in catalogo, mi sono buttata nell’impresa, sapendo che avrei visto un contenuto forte, ma consapevole che la durata più contenuta avrebbe aiutato a renderlo anche più fruibile. Invece mi sono imbarcata in queste dieci ore che mi hanno più volte costretto ad interrompere e far passare un po’ di tempo prima di riprendere la visione. Ormai è difficilissimo trovare serie TV che durino meno delle dieci puntate, così come è difficile andare al cinema ed uscire dalla sala prima che siano passate due ore e mezza. Anche quelle che dovevano essere un compromesso, le miniserie, appunto, sono state inghiottite da questo nuovo linguaggio cinematografico che si basa sulla intellettualissima metodologia chiamata “allungamento del brodo”.
Riflessione e virtuosismo possono convivere?
Di film che parlano di efferati assassini ne abbiamo visti tantissimi. Di getto mi vengono in mente Seven, Il silenzio degli innocenti, Psycho. Anche di miniserie che trattano temi simili ce ne sono tante, come la già citata When they see us. Tutti questi prodotti funzionano perché offrono una visione fulminea, agghiacciante e critica di aspetti violenti della nostra realtà. Ci mettiamo il giusto tempo a guardarli e ne impieghiamo moltissimo per rifletterci sopra. E “rifletterci sopra” non significa sognarsi gli spargimenti di sangue o dire a noi stessi “che mostro era quella persona”, ma calare quel fatto o quell’individuo nella società, analizzarlo da un punto di vista totale. In questa trasposizione si perde molto tempo a fornire la spettacolarizzazione dell’omicidio, che serve a ben poco e, a lungo andare, stomaca. Tanti punti interrogativi rimangono irrisolti, una volta finita la serie. E una serie documentaristica di dieci ore non può permettersi di lasciare così tante lacune.
Quando si guarda un documentario, anche se ammantato dagli effetti speciali di un thriller, è come leggere un articolo giornalistico scritto da una penna particolarmente estrosa. I virtuosismi della scrittura sono permessi e apprezzati; divagazioni, metafore, parentesi si leggono ben volentieri; ma il senso dell’articolo deve essere focalizzato. La sua funzione informativa è primaria e non può essere oscurata dalla vana presunzione dello scrittore di voler descrivere nei minimi particolari il fatto di cronaca. Ne esce cosa? Un dipinto insanguinato? Il ritratto materiale di una mente disturbata? Il morboso desiderio del male che ognuno di noi serba dentro di sé? Forse l’opera di Murphy vuole assomigliare ad una catarsi da teatro greco, oppure vuole essere l’ennesima eccentrica scommessa che si traduce nel più grazioso vuoto cosmico. Credo che la verità stia nel mezzo. Il morbo l’aveva afflitto nella patinatissima Hollywood ed ora torna a colpire, in minor misura, certo, ma facendomi ancora una volta storcere il naso. Negli anni abbiamo imparato a riconoscere Murphy come un genio della messa in scena visiva: azzecca i colori, le luci, il set, gli attori e tutto quello che sfavilla negli occhi di chi ama il cinema da grande spettacolo. Un pizzico in meno di tutto questo e una manciata in più di reale approfondimento, che vada oltre le sinfonie dell’estetismo ad ogni costo, avrebbero reso Mostro – La storia di Jeffrey Dahmer un gioiello del true crime.