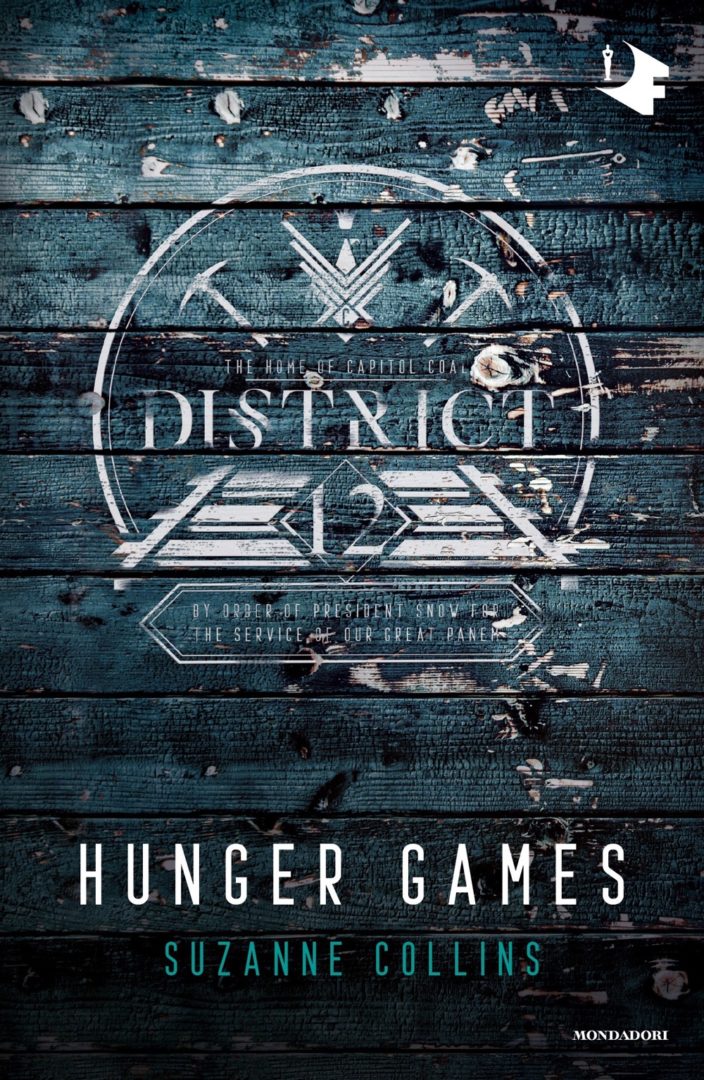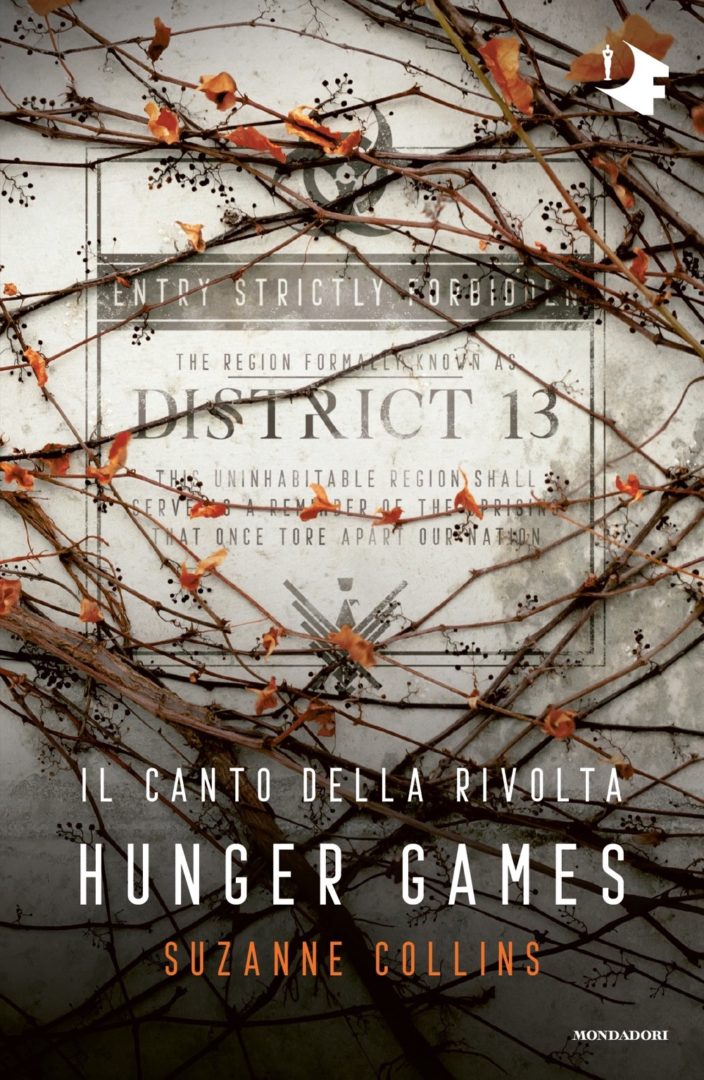Hunger Games: la ragazza di fuoco che liberò le librerie dai vampiri
Vi ricordate cosa andava di moda nel 2009? Probabilmente sì, o forse volete solo dimenticare.
Dieci anni fa un’orda di adolescenti cercava di elaborare la fine della storia di Bella Swan e Edward Cullen rivivendo al cinema le loro avventure, gli scaffali delle librerie erano pieni di emuli della Twilight Saga e gli editori si guardavano intorno famelici alla ricerca di un nuovo mostro della settimana da edulcorare e romanticizzare (ci ha provato nel 2010 Isaac Marion con Warm Bodies, un tentativo fortunatamente naufragato di rendere gli zombie amabili e sexy).
I romanzi per giovani adulti – o young adult – sono nati, come la musica rock e la definizione stessa di adolescenza, a partire dal secondo dopoguerra. Non più bambini, non ancora adulti, i teenager sono diventati immediatamente una fascia di possibili acquirenti da affascinare e avviluppare nelle spire del target marketing, una fonte di guadagno sicura, un gruppo influenzabile decenni prima della nascita degli influencer di professione.
Nonostante i primi romanzi ad attirare l’attenzione dei neonati adolescenti non fossero stati scritti espressamente per loro – stiamo parlando de Il giovane Holden di J.D. Salinger e de Il signore delle mosche di William Golding -, il disagio giovanile del primo e le dinamiche violente del secondo sarebbero diventate con il passare dei decenni un terreno fertile per questo genere, che gode oggi di buonissima salute e continua a intercettare l’interesse di giovani e non più giovani, senza arretrare davanti a tematiche forti come la malattia (Colpa delle stelle e tutto il filone della sick-lit hanno aiutato Hunger Games et similia a scardinare la supremazia horror-romance in libreria), l’identità di genere (Tuo, Simon), il razzismo (The hate U give).
Ma torniamo al 2009, quando i lettori italiani, a meno di un anno di distanza dall’uscita statunitense, si trovano tra le mani il primo volume di una trilogia che unisce premesse già diventate topos grazie ai lavori di Golding e Shirley Jackson a un approccio che sfrutta il romance senza metterlo al centro della vicenda: Hunger Games è un romanzo che non lascia indifferenti i lettori: che sia per urlare allo scandalo del plagio, o per anestetizzare nel palliativo della relazione tra Peeta e Katniss l’astinenza da vampiri innamorati, tutti ne parlano, e continuano a parlarne dieci anni e un sequel in arrivo dopo.
Non troppo tempo fa Oscar Fantastica ha presentato una nuova edizione della trilogia: tre copertine che omaggiano i luoghi di Panem in cui si consuma la ribellione degli abitanti dei distretti, un progetto grafico ben curato per un’edizione da rileggere prima di mettere in mostra sugli scaffali.
Sfogliare di nuovo le pagine di Hunger Games, infatti, mostra che il mondo di Suzanne Collins è invecchiato come un buon vino, acquistando un’intensità che può essere apprezzata solo dopo un lungo riposo. Rileggere Hunger Games dopo dieci anni, non più travolti dalla frenesia di scoprire cosa succederà nella pagina seguente, permette di soffermarsi sui personaggi, più che sulle azioni, su ciò che non viene detto, ma solo percepito da un lettore attento.
Hunger Games: abituarsi alla fine
Partiamo dalla nostra eroina, Katniss Everdeen. Dimenticatevi il modello fidanzata del vampiro, perché davanti a noi abbiamo un ben più umano esempio di protagonista non amabile: addio goffezza, così utile per rendere un personaggio femminile immediatamente adorabile e bisognoso di protezione; Katniss è una cacciatrice provetta, che si muove nel bosco producendo meno rumore del fruscio del vento, uccide con precisione e meticolosità le sue prede, nutre e sostiene la sua famiglia. Katniss non sorride senza un buon motivo, non considera ogni individuo di sesso maschile rientri tra le sue conoscenze un possibile partner sentimentale, Katniss è la madre di una nuova generazione di eroine complesse ancora prima di essere forti che non amano a vanvera, che sbagliano, e che dal 2009 a oggi hanno invaso, con risultati più o meno riusciti, le pagine di romanzi e fumetti, puntate di serie tv e schermi del cinema.
L’effettiva riuscita o meno di protagoniste dai tratti caratteriali forti è legata all’arco di crescita di questi personaggi: Suzanne Collins è riuscita a bilanciare la solidità di Katniss con una maturazione caratteriale credibile che non snatura mai la sua essenza, anche grazie al protagonista maschile di Hunger Games.
Peeta Mellark è tanto lontano dal cliché del Gary Sue quanto Katniss lo è dalle Mary Sue di ogni tempo: il ragazzo del pane è – inizialmente – una figura maschile emotivamente e fisicamente debole, che non può contare su nessuna delle abilità di sopravvivenza della sua amata e ha, tra le frecce al suo arco, attività come la cucina, compresa la decorazione di torte. La donna cacciatrice e l’uomo a casa a cucinare è forse un ribaltamento dei ruoli un po’ troppo semplicistico per gridare all’innovazione e alla sovversione delle imposizioni culturali del genere, ma nel mondo di Hunger Games questa inversione funziona molto bene, perché inserita su una dinamica di coppia ben modellata e sempre contestualizzata dal passato dei protagonisti.
Se all’inizio del loro percorso Katniss si dimostra ai limiti dell’anaffettività, con una mancanza di fiducia nei confronti della madre e un trauma mai superato per la morte del padre, la vicinanza di Peeta – così diverso dallo stereotipo dell’eroe salvatore, così altro da Gale, che bacia Katniss senza chiederle il permesso, lui che le sta sempre accanto senza chiederle più di quello che lei vuole dargli, perché questo è amore – permetterà a Katniss di riscoprire il desiderio di curare e prendersi cura delle persone che ama, rischiando tutto – anche la sua vita – per tenerle al sicuro.
A dire il vero io volevo solo stare bene
In un dialogo tra Peeta e Gale, alla fine del terzo capitolo della saga, l’amico di infanzia di Katniss identifica nel desiderio di sopravvivere la scintilla di ogni azione della ragazza: “tra noi due, Katniss sceglierà quello che ritiene indispensabile alla sua sopravvivenza.”
Una frase crudele, non del tutto vera, ma non interamente falsa: Katniss è una sopravvissuta, e lo è da molto prima della vittoria agli Hunger Games. Dopo la morte del padre e la depressione della madre, sarà lei a farsi carico di ciò che resta della sua famiglia, espandendo gradualmente il cerchio alla famiglia di Gale, al suo mentore Haymitch, finendo per diventare un simbolo per ogni cittadino dei distretti, ribellandosi in ultima istanza anche alla distopia dentro la distopia del Distretto 13 e della presidentessa Coin, che la vorrebbe influencer della rivoluzione; un bel faccino silenzioso che appoggi la ribellione, un’eroina muta, telegenica, accondiscendente.
Ancora una volta Katniss si rifiuta di diventare un oggetto tra le mani del potere, ancora una volta la ribellione di Katniss valica in confini della mera sopravvivenza, come il letto di fiori per Rue, come le bacche alla fine dei settantaquattresimi Hunger Games, come l’umanità dimostrata nei confronti del suo team di truccatori, nel distretto 13. Ben sopra la sopravvivenza, c’è la giustizia, e per Katniss Everdeen fare la cosa giusta è ancora più importante di sopravvivere.
Veramente vivo in tempi bui
A differenza di molti dei suoi emuli nati sulla scia del successo delle distopie adolescenziali, la politica in Hunger Games non si limita a essere uno strumento per far muovere gli eventi, ma è protagonista al pari degli sfortunati amanti del distretto 12. Suzanne Collins si ispira, tra gli altri, agli antichi romani per forgiare la sua personalissima visione di Panem et Circenses, in cui la morte diventa spettacolo e i tributi, gladiatori del futuro, combattono mentre i ricchi si rimpinzano di cibo fino a vomitare e i poveri aspettano invano gli aiuti umanitari dalla città.
In Hunger Games, così come in Battle Royale di Koushun Takami, alle nuove generazioni viene rubato il futuro in nome degli errori commessi dai padri, con una doppia minaccia: se da una parte lo stato richiede annualmente un tributo in sangue, dall’altro gli Stati Uniti descritti da Suzanne Collins sono a malapena sopravvissuti a guerre e disastri ambientali, una prospettiva non molto lontana dalla nostra attualità.
Il futuro rubato degli abitanti dei distretti, la paura di amare, di avere una famiglia, di avere dei figli che un giorno potrebbero restare schiacciati tra gli ingranaggi del meccanismo perverso dei giochi, la disparità tra chi ha vinto e ottiene più di quello che gli potrà mai servire e chi non ha niente, l’individualismo degli abitanti della capitale, così affascinati dai giochi e così poco interessati a quello che succede fuori dall’arena, nel mondo vero al di là delle loro case; rileggere Hunger Games dieci anni dopo, con la paura del futuro, con la frustrazione di chi si sente ancora relegato tra i giovani adulti, non ancora in grado di abbandonare quello young che anche la cartafreccia di Trenitalia ha allungato fino ai trent’anni, è un’esperienza riflessiva ancora prima che di intrattenimento, una lettura che dalla distopia sfuma nell’horror psicologico per una generazione che vive sempre e da sempre nell’incertezza, come se la vita fosse tutta come l’interminabile momento che precede l’estrazione dei nomi dei tributi, il giorno della Mietitura.