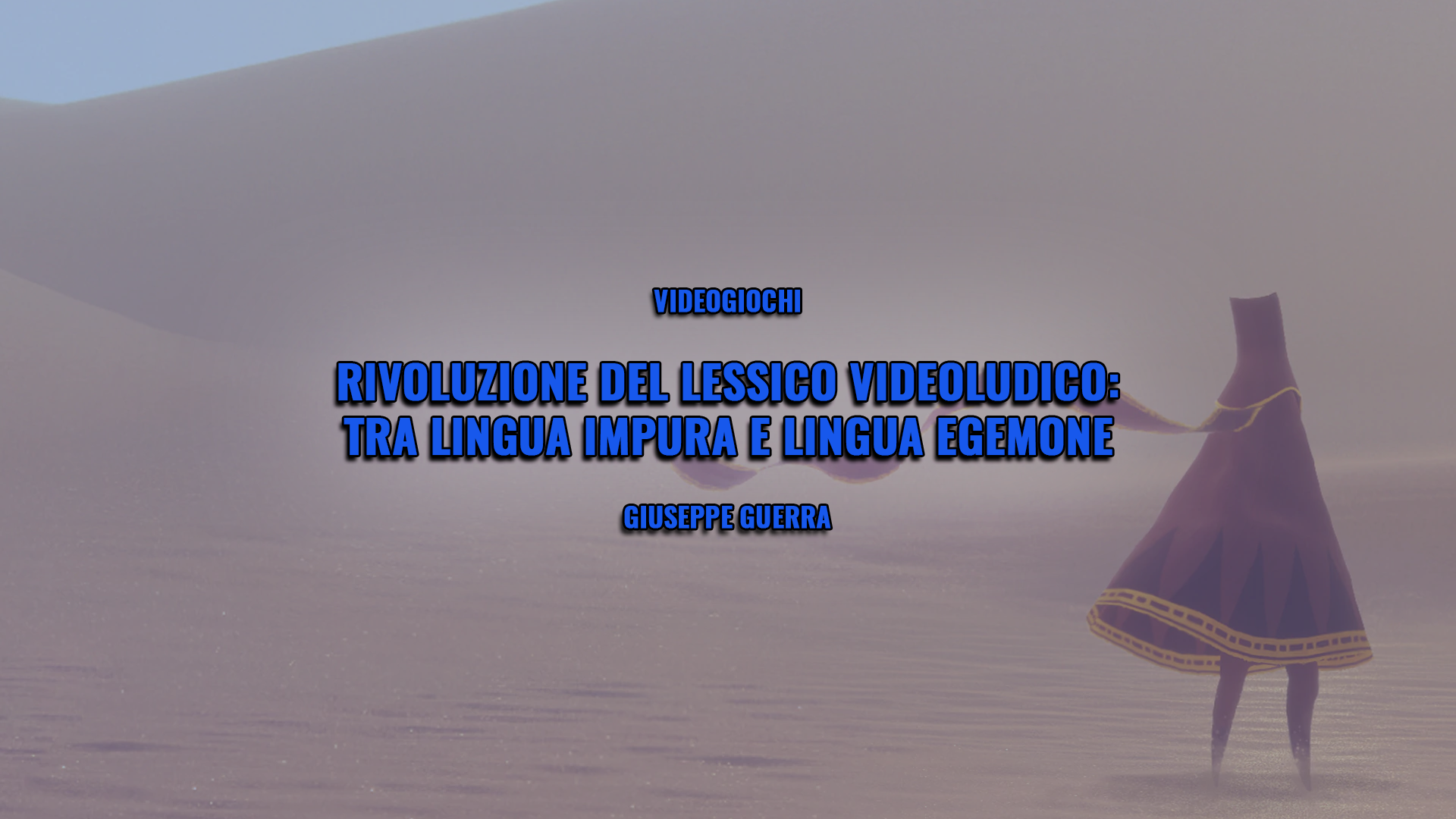Una riflessione sulla difendibilità degli anglicismi nel gergo di videogiochi e realtà limitrofe

ndare in game con altri player a killare un mob per droppare loot. Farmare gold per upgradare il gear. Fare una sub a una streamer. Sono frasi che forse ad alcuni potranno sembrare ridicole o persino dannose, e ad altri normali ed innocue. Del primo avviso dev’essere il Ministero della Cultura francese, che sul Journal Officiel ha pubblicato alcune alternative nella langue de Molière agli anglicismi videoludici. Così il cloud gaming diventa jeu vidéo en nuage, il free-to-play esige jeu vidéo en accès gratuit, il game as a service si trasforma nel jeu vidéo à la demande. I dipendenti del governo sono così vincolati, nella stesura di documenti ufficiali, all’uso di queste forme alternative.
L’iniziativa francese ha presto fatto il giro della rete, finendo avvolta in un clima di diffusa ilarità. I soliti titoli beffanti e sensazionalistici non hanno certo aiutato, e così l’intera vicenda è stata vissuta dal pubblico come l’ennesima stravaganza di una Francia che insiste ad appollaiarsi sul trespolo tarlato dell’orgoglio nazionale, avanzando una lotta risibilmente donchisciottesca contro quelle intrusioni straniere che guastano la purezza della lingua francese. Sembrerebbe dunque trattarsi di una questione molto semplice, un mero attrito generazionale tra una classe dirigente un po’ attempata e un mondo giovanile determinato a difendere in punta di stocco quel lessico anglicizzato in cui si identifica.
Da un punto di vista linguistico il problema è in realtà molto complesso, e non ho la pretesa di esaurirne qui le sterminate possibilità. Spero però di riuscire ad incrinare quella lettura superficiale e stimolare riflessioni che muovano da un’altra prospettiva, nonché a difendere l’opportunità di interrogarsi sul significato politico delle parole che usiamo. Del resto, se lo fanno le finzioni che amiamo, perché non dovremmo farlo noi?
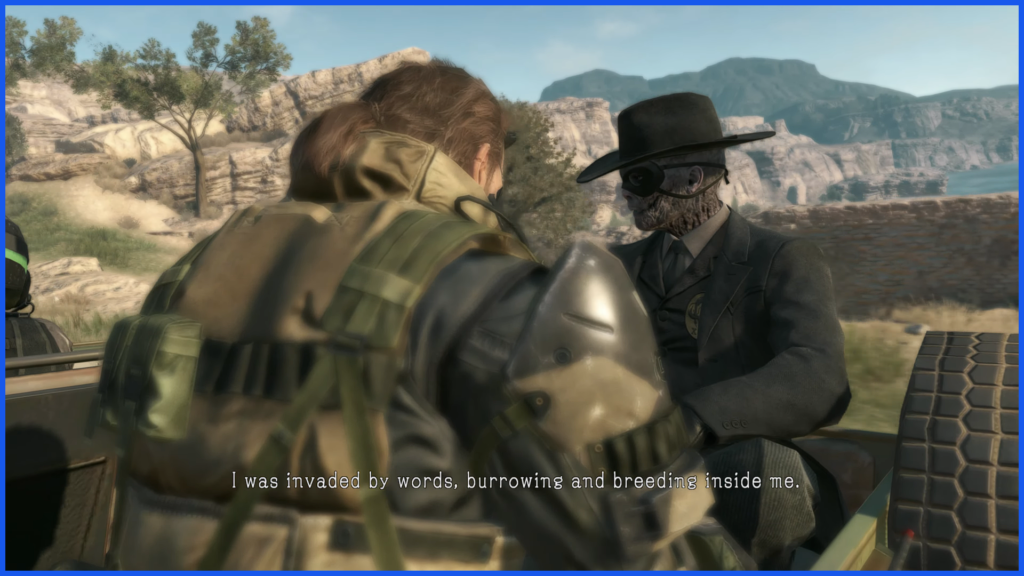
La lingua impura
Un prestito linguistico è il passaggio di una forma da una lingua ad un’altra in seguito ad un loro contatto. Qui ci interessano nello specifico i prestiti lessicali, vale a dire quei prestiti che riguardano una parola o una locuzione, e non, per esempio, costrutti e norme grammaticali. Gamer è un prestito, ma lo sono anche cinema, casseruola, sport, e così via. Il nostro lessico quotidiano, anche quello che saremmo forse inclini a considerare “puro” italiano, è in realtà costellato di forestierismi, e questo avviene per una ragione molto precisa: la lingua pura non esiste, e i prestiti sono ben lungi dal costituire un pericolo a priori.
Al contrario, è proprio attraverso i prestiti, tra gli altri fenomeni di neoformazione, che una lingua può arricchire il proprio patrimonio lessicale. Né si tratta di una consapevolezza neonata. Già Machiavelli, nel Discorso o dialogo intorno alla nostra lingua, scriveva: “Non si può trovare una lingua che parli ogni cosa per sé senza haverne accattato da altri”, e “qualunque volta viene o nuove dottrine in una Città o nuove arti, è necessario che vi venghino nuovi vocaboli, et nati in quella lingua donde quelle dottrine o quelle arti son venute.”

Potrebbe dunque sembrare naturale, e persino desiderabile, che i videogiochi portino con sé nella lingua italiana parole (per esempio) inglesi o giapponesi. E in parte è davvero sia naturale che desiderabile. Nessun linguista crede realmente in una sorta di autarchia linguistica, priva di contaminazioni esterne agli usi nazionali: sarebbe una impossibilità. E certamente non ci credono i linguisti della Crusca o dell’Académie française. Non si deve dunque pensare che una proposta selettiva sui prestiti sia per forza di cose orientata alla soppressione di parole come musou, combo o grindare.
Quando si parla contro i forestierismi lo si fa, solitamente, sulla base di una suddivisione degli stessi. Non tutti i prestiti infatti sono uguali. Esistono i calchi semantici (quando una parola italiana assume un nuovo significato tratto da una lingua straniera), i calchi strutturali (che usano combinazioni prima inesistenti di parole della lingua d’arrivo), i prestiti adattati (che si sono adeguati al sistema fonomorfologico della lingua ricevente, e sono riconoscibili come d’origine straniera solo ricostruendone l’etimologia) e i prestiti integrali, quelli che mantengono la loro forma originaria e hanno dunque caratteristiche estranee all’italiano, per quanto ne venga generalmente adattata la fonetica. Sulla base di queste ed altre distinzioni è possibile applicare dei criteri di accettabilità, come quelli proposti dal linguista Bruno Migliorini, secondo cui, ad esempio, sarebbe stato opportuno accettare quei prestiti privi di un referente italiano (prestiti di necessità).
Non è quindi strano che un linguista, nella piena consapevolezza della normale “impurità” delle lingue, scelga di fare una selezione che non sia informata da un mero gusto personale, o dall’eufonia dell’abitudine, bensì da distinzioni basate sulla forma, sugli esiti, sulle modalità di trasmissione. In effetti, persino la “Commissione per l’italianità della lingua” dell’Accademia d’Italia, che tra il ’41 e il ’43 si dedicò ad un’opera di promozione di parole italiane, in sostituzione di forestierismi sgraditi, fece uso di diversi filtri lessicografici. Alcune parole e locuzioni venivano così del tutto sostituite (bigliettaio al posto di guichetier), altre lievemente modificate (valzer anziché walzer), mentre alcune erano accettate senza variazioni, in quanto giudicate non sostituibili.
Nonostante le pretese di quella fase autarchica ci paiano a buon diritto ridicole, se non inquietanti visto il loro sfondo totalitario, al punto che contribuiscono a gettare un’ombra ingiusta sugli odierni tentativi di selettività, è interessante notare come alcune di quelle proposte siano invece riuscite a legittimarsi nell’uso, restando in voga fino ad oggi. Così da una parte riteniamo comica l’idea di chiamare lo yogurt “latte bulgaro”, e dall’altra nessuno troverebbe buffo chiamare “regista” un metteur en scène.

La lingua egemone
Quanto la crociata fascista contro le “parole ostrogote” ha da insegnarci non è che la selezione dei prestiti è in sé espressione di uno sciocco ed autoritario dirigismo linguistico. Non ci dice neanche che è bene lasciare la lingua libera, perché tanto alla fine fa quello che vuole. Al contrario, ci ricorda che la lingua non è di quegli enti cui si possa attribuire una volontà. È una radiografia dell’epoca, della cultura, della società che la parla. La lingua è un fatto intrinsecamente politico, e dunque i problemi linguistici non possono che essere a loro volta problemi politici, vale a dire problemi di classe. Del resto se un prestito è conseguenza del contatto tra due lingue, lo sarà anche dal contatto tra due popoli. Questo apre la possibilità di ragionare non solo sul prestito in sé, ma anche sulle modalità della sua trasmissione.
La trasmissione può evidenziare rapporti di tre tipi. Osserviamo un rapporto di sostrato quando alcune caratteristiche della lingua parlata da una popolazione, cui ne viene imposta un’altra, riemergono nella lingua dominante. Abbiamo un rapporto di superstrato quando la lingua dell’invasore influenza alcuni degli usi linguistici dei popoli che subiscono l’invasione. Ed infine, un rapporto di adstrato descrive l’influenza che viene a crearsi tra popoli confinanti, che esercitano reciprocamente sulla lingua dell’altro un prestigio equiparabile.
Questa distinzione tra le modalità di trasmissione dei prestiti presenta nuovi problemi. È facile, per esempio, che una diversa valutazione storico-politica porti più studiosi ad attribuire rapporti diversi allo stesso fenomeno. Da un lato è chiaro che un’azione politica violenta non necessariamente risulta in una distruzione o un appiattimento del patrimonio linguistico del popolo che la subisce, ma dall’altro dovremmo anche essere portati a chiederci se un sistema di subalternità culturale abbia come prerequisito un’azione bellica, se la logica dell’egemonia abbia una base puramente nazionale, di scontro tra popoli, e se non sia il rapporto di adstrato, in apparenza innocuo, ad essere in realtà il più insidioso.
Il problema si apre, e rivela la sua complessità, nel momento in cui iniziamo a ragionare in termini di lotta di classe e di egemonia culturale, anziché restare all’ombra della superficiale paura per le imposizioni statali. Ad esempio, il tentativo di autarchia fascista non è da rifiutare solo per la sua goffezza, ma prima di tutto per il carattere classista ed imperialista del suo totalitarismo. Il fine non era la fioritura della lingua popolare, ma il controllo del popolo anche attraverso la lingua di regime e la repressione di quei gruppi linguistici di diversa madrelingua. Si pensi all’italianizzazione forzata delle zone a maggioranza alloglotta.
Insomma, il fascismo nascondeva, dietro la difesa della lingua, il tentativo di sottometterla e uniformarla. Se però quei fenomeni di prevaricazione linguistica sono giudicabili negativamente, in quanto lesivi dell’identità e della cultura dei popoli, come dovremmo giudicare il tentativo, da parte di quegli stessi popoli, di tutelare la propria identità, e dunque la propria eredità linguistica? Di fronte al riconoscimento di un’egemonia, sarebbe ridicolo equiparare le due spinte in base al semplice fatto che entrambe avrebbero una legittimazione istituzionale o una motivazione patriottica. E sappiamo tutti bene come le questioni nazionali non siano scindibili dalle questioni di classe.
Secondo Gramsci la borghesia, la classe capitalista che detiene il controllo dei mezzi di produzione e delle istituzioni statali, mantiene il potere non solo tramite i tradizionali strumenti di coercizione bellica (manifestandosi come fascismo) o economica, ma anche se non soprattutto con la produzione culturale. La cultura egemone è così la cultura dei capitali dominanti, vale a dire quella la cui produzione culturale riesce a trasformare la propria ideologia in un sistema di credenze condivise tale da mantenere il controllo.
Questo conflitto si esprime inevitabilmente anche nel contatto tra le lingue, al punto che è secondo me legittimo chiedersi se i rapporti di adstrato tra economie capitaliste non siano più rari di quello che pensiamo, e se non rappresentino spesso un conflitto impari non ancora, per ideologia, pienamente riconosciuto. Vale a dire se spesso l’adstrato, la lingua che ne influenza un’altra di eguale prestigio, non celi il superstrato di un’egemonia culturale i cui valori abbiamo interiorizzati al punto da non riuscire neanche più a riconoscerla. Anzi, difendiamo la cultura (e dunque la lingua) egemone in quanto sentiamo che ci definisce: il capitale ci ha insegnato che la sua supremazia non è un’iniquità, ma fa parte di uno status quo che neanche immaginiamo di mettere in discussione.
Perché è importante riconoscere la natura politica del problema? Perché i problemi politici non ammettono imparzialità: esigono che si scelga da che parte stare, che si prenda una posizione. La soverchiante pervasività della lingua inglese non è scindibile dalle condizioni politiche ed economiche che ne hanno reso possibile il predominio: il colonialismo, certo, ma anche una cultura capitalistica anglocentrica. C’è il forestierismo innocuo, senz’altro, ma c’è anche un innegabile appiattimento culturale, che segue l’egemonia dei capitali atlantici sul mondo dell’intrattenimento.
Di fatto in queste condizioni anche le lingue di Paesi come Francia e Italia, quindi potenze in grado di avere a propria volta posizioni di egemonia (si pensi al rapporto tra l’italiano e le altre lingue d’Italia), soffrono nei confronti della lingua inglese una condizione di subalternità. Secondo Michael Cronin questa condizione può avere solo due possibili sbocchi: la traduzione-assimilazione, in cui la lingua minoritaria subisce un assorbimento a vantaggio della lingua egemone, e la traduzione-diversificazione, in cui la lingua minoritaria riesce a resistere a quella egemone. È quest’ultima la precondizione perché i prestiti riescano ad essere un elemento di arricchimento della lingua che li riceve, in quanto vengono ricevuti e rielaborati senza sottrarre spazio al lessico preesistente, ma nutrendolo invece di nuove possibilità espressive.
È qui che posso ricondurre il discorso nell’ambito videoludico, un ambito nel quale indubbiamente i capitali statunitensi (tra gli altri) rivestono un ruolo egemonico rispetto a quelli di popoli che hanno minori strumenti di produzione culturale, e dunque minore prestigio, in rapporto al mondo globalizzato. Il problema dei prestiti linguistici nel lessico videoludico è un’estensione di una più ampia egemonia, che passa anche, per esempio, dai social network, dagli influencer e dai servizi di streaming.

Chi mai ci salverà?
Da dove può dunque venire quella rivoluzione, o almeno quella lotta, tesa ad arginare l’assimilazione? Indubbiamente dai traduttori, visto che perché ci sia un contatto tra due lingue deve anche esserci, per forza di cose, qualcuno che le parli entrambe. Ma cosa significa traduttore in questo contesto? Non mi riferisco necessariamente alla figura professionale, per quanto sicuramente questa rivesta la sua importanza, ma a tutti quanti controllano, chi più e chi meno, l’esito del contatto tra le lingue. Quindi il giornalismo di settore, le associazioni che si occupano delle competizioni videosportive, i divulgatori ed intrattenitori videoludici e, infine, ogni singolo parlante, che nel proprio piccolo può eleggersi obiettore.
Il ruolo determinante non può però che essere quello delle istituzioni preposte alla cura e alla conservazione del patrimonio culturale nazionale: il Ministero della cultura. E lo è per una ragione molto semplice: dispone degli strumenti per avere un’influenza culturale, e in quanto dicastero della repubblica gode anche, almeno in linea teorica, della legittimazione democratica ad agire nel nome del popolo e nel suo interesse. Visto infatti che, come abbiamo visto, il problema dei prestiti è un problema politico, non si può trattarlo come una responsabilità individuale, né ci si può aspettare che capitali privati agiscano nell’interesse pubblico.
A questo punto il rimprovero che, credo, si può portare ad iniziative come quella del governo francese, non è già di combattere contro i mulini a vento, o di arroccarsi su un purismo anacronistico e conservatore, ma di non aver compreso appieno (o di non essere interessati a comprendere) il problema dell’egemonia culturale da una prospettiva di lotta di classe, e di non star disponendo strumenti adeguati a filtrarla.
Se cioè il problema è il capitale, con la sua forza omologatrice, e quindi la disparità tra lingue che vengono a contatto a detrimento dell’una o dell’altra, non si può esigere di risolverlo o di arginarlo senza ragionare marxianamente, per quanto importanti e difendibili siano le rivendicazioni nazionali in questa logica, e per quanta trasversalità e stratificazione ci siano nella considerazione di questi problemi. Al di là della critica marxista, chiunque abbia a cuore la diversità delle culture e delle lingue, la grandezza del mondo e tutte le storie che non ha mai ascoltato, non può non guardare con preoccupazione ad un’industria videoludica che sovrascrive, almeno in parte, le lingue che ricevono le sue produzioni.
Penso al “reazionario di vecchio stampo” che portava il nome di John Ronald Reuel Tolkien, con le cui parole voglio chiudere questo contributo: “Il Col. Knox dice che un ottavo della popolazione mondiale parla ‘inglese’, e quello è il più grande gruppo linguistico. Se è vero, è una vergogna – dico io. Possa la maledizione di Babele colpire tutte le loro lingue finché potranno dire solo ‘baa baa’. Tanto avrebbe lo stesso significato. Penso che dovrò rifiutarmi di parlare altro che Antico Merciano. Ma in tutta serietà: trovo questo cosmopolitismo americano davvero terrificante.”