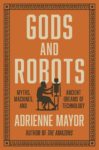Una storia di sesso, robot e amore che inizia nell’antica Grecia, più di venti secoli fa
La famosa rule 34 di internet afferma che se qualcosa esiste, allora ne esiste anche una versione porno. Nulla sembra sfuggire all’ineluttabilità di questa regola: supereroi, elfi, puffi e pony; se cercate – neanche troppo bene -, vi ritroverete a fissare negli occhi, o in altri parti del corpo più o meno pixelate, abissi che non avreste mai voluto incontrare.
A questa tendenza eroticizzante non sono certo sfuggiti, nel corso della loro vita, robot, androidi, macchine più o meno senzienti, e con il passare degli anni quella che sembrava una perversione si è trasformata in un campo di ricerca e in un ambito di lavoro. Nel magico mondo dell’internet, infatti, è possibile trovare paper scientifici (seppur anonimi) che analizzano più ore di sesso orale di quante una persona normale ne pratichi in tutta la sua vita, con lo scopo di mettere il machine learning al servizio del robosex.
I sex robot, bambole gonfiabili 2.0, sembrano essere un fenomeno del nuovo secolo, guardato con curiosità, osteggiato, dibattuto, ma in realtà hanno una storia molto più lunga, una storia che, come gran parte della nostra civiltà, arriva dall’antica Grecia.
Nonostante il termine robot derivi dal ceco robota – lavoro forzato – e sia stato coniato quasi un secolo fa dal drammaturgo Karel Čapek, per risalire al primo prototipo di essere senziente antropomorfo artificiale dobbiamo avventurarci nel mito ellenico.
E del resto è proprio una parola dall’etimo greco quella che descrive l’attrazione sessuale nei confronti di bambole, manichini e statue. Di agalmatofilia soffre uno dei personaggi di Central Station, romanzo corale di Lavie Tidhar pubblicato da Acheron Books: l’hacker climatico Stolly, che cerca nella vampira di dati Carmel la sua Musa, finirà per amarla così tanto da renderla monumento perpetuo nell’immobilità di una tempesta.
Nel suo saggio Gods and Robots, che speriamo di vedere presto pubblicato in Italia, la storica e ricercatrice Adrienne Mayor ricostruisce la storia dei robot nascosti tra le pieghe del mito greco, che pullula di esseri made, not born (creati, non nati), molti dei quali, nel pieno spirito sessuomane del padre degli dei, Zeus, hanno a che fare con pratiche erotiche o amorose, come nel caso di Pandora, la prima donna mortale, non nata, bensì forgiata dal Dio Efesto per sedurre il fratello di Prometeo, o di Talo, automa di bronzo e sangue che si dice proteggesse l’isola di Creta.
Uno degli episodi più famosi e più significativi, a questo proposito, è quello che vede lo scultore Pigmalione innamorarsi così profondamente della statua da lui scolpita nell’avorio da arrivare a pregare Afrodite di concedere la vita alla sua opera. Nella versione di Ovidio, la Dea dell’amore e della bellezza esaudisce il desiderio dell’uomo, e la coppia si sposerà e concepirà una figlia. Il desiderio di Pigmalione scaturisce dall’illusione che nessuna donna reale possa essere tanto perfetta quanto la sua creazione, muta, remissiva, accondiscendente.
Anche quando la magia di Afrodite farà muovere il corpo del simulacro di ragazza amato dallo scultore, resta da chiedersi quale sia il grado di consapevolezza della ragazza nei confronti della sua esistenza e della sua sessualità. Una domanda di etica che farà sicuramente sbuffare i lettori, ma si tratta di un quesito che è stato più volte sollevato durante l’ascesa della moda dei sex robot, nonché un tema toccato, più o meno marginalmente, da gran parte delle opere dedicate a robot, cyborg, e replicanti.
Nella prima stagione della serie britannica Humans – uno dei migliori prodotti televisivi sul tema – il synth Niska, sex worker non per scelta, uccide un cliente abusivo dopo che questo ha lasciato intendere una preferenza per esperienze al limite della pedofilia. Niska, come gli altri protagonisti della serie, è un essere umano sintetico dotato di coscienza – alcuni direbbero anima – e di un forte senso della giustizia.
Su ciò che è giusto o sbagliato e sull’importanza del machine learning nello sviluppo di un’intelligenza artificiale si sofferma, troppo brevemente, anche lo scrittore Ian McEwan nel suo ultimo romanzo, non ancora tradotto in italiano, Machines Like Me. Ambientato in un’Inghilterra ucronica che, grazie al mancato suicidio di Alan Turing, è progredita tecnologicamente a un ritmo molto più sostenuto di quello della nostra realtà, negli anni ‘80 i robot da compagnia e i sex robot sono diventati realtà, con tutti i problemi che una simile integrazione nel nostro tessuto sociale può portare con sé.
Come spiegare a un’intelligenza artificiale la differenza tra una bugia bianca, a fin di bene, se quel bene è così netto e distinto, per lei, dal male che la bugia stessa rappresenta? Possiamo dire che un robot provi amore, se viene programmato dal suo proprietario per esprimere quel sentimento?
Come molto spesso succede in ambito tecnosofico, un tentativo di risposta era arrivato dal Giappone quasi vent’anni fa, ad opera del gruppo di mangaka raccolto sotto il nome di CLAMP. Chobits è un seinen con una punta di ecchi che indaga la relazione tra umano e artificiale per mezzo dei persocom, evoluzione antropomorfa dei personal computer.
La protagonista, Chii, svilupperà nell’arco degli otto volumi che compongono la serie una personalità sempre più spiccata, e sebbene intriso di buoni sentimenti, amore puro e ricerca della felicità come molte delle opere delle CLAMP, tra queste pagine troviamo forti e attuali riflessioni sulla tendenza umana a preferire la compagnia di un individuo programmabile e programmato per essere accomodante e accondiscendente nei confronti del padrone, rispetto all’interazione tra simili. Nel caso di Chobits, la rosea soluzione prevede la nascita di un sentimento amoroso così forte da superare ogni tipo di impedimento, compresa l’impossibilità di fare sesso con l’oggetto del desiderio.
Il sex robot, la macchina creata per il sesso diventa persona amata e si spoglia della sua funzione primaria.
Ma che cos’è l’amore? E come possiamo pensare di insegnarlo ai sex robot, se non ne abbiamo per primi un’idea definita e cristallina? Sempre McEwan, che non propone una visione per niente ottimista della convivenza tra uomini e macchine, troppo concentrato forse sul suo ombelico per considerare il punto di vista di chi ne è sprovvisto, giunge alla conclusione che “loro [gli automi] non possono capirci, perché non ci capiamo neanche noi. I loro programmi di apprendimento non possono contenerci. Se noi non conosciamo le nostre stesse menti, come possiamo progettare le loro, e aspettarci che siamo felici accanto a noi?”
Una riflessione meno banale di quanto possa sembrare, che ci riporta per l’ennesima volta nella culla della civiltà, in un luogo conosciuto come l’ombelico del mondo, sede di una delle iscrizioni più famose al mondo, quel conosci te stesso che troviamo anche in Matrix e che diventa, in una società sempre più transumanista e ibrida, un assunto vitale per non perdere coscienza della propria umanità, soprattutto se questo è quello che vogliamo insegnare alle nostre macchine.