Studi Virtuali, la rubrica periodica dedicata ai game studies italiani, ha vita giovane, e sinora è stata dedicata all’analisi di alcuni dei testi più meritevoli ed interessanti del panorama nostrano.
Dopo un po’ di mesi di rodaggio, abbiamo deciso di accorpare nuovi tipi di contenuti che coinvolgessero in maniera più attiva personalità legate ai game studies.
In questo caso, il nostro Claudio Cugliandro ha fatto una piacevole chiacchierata con Enrico Gandolfi, assistant professor presso la Kent State University dell’Ohio, per avere un’opinione diretta sul panorama videoludico legato alla ricerca e all’analisi del medium. Chiaramente viene fuori anche una disamina sull’Italia che, nell’ottica dei game studies, appare indietro rispetto agli altri paesi occidentali, quali la Francia o gli Stati Uniti, per fare qualche esempio.
L’obiettivo della rubrica è quello di dare spazio a un lato del medium videoludico spesso poco considerato, ovvero i risvolti che può avere in termini culturali e sociali.
Sperando che questa nuova scia sia di vostro gradimento, e che possa fornirvi nuovi spunti di riflessione sulla vostra passione più grande quale il videogioco, vi auguriamo una buona lettura.
Lorena Rao – curatrice della rubrica Studi Virtuali

Ciao Enrico, e grazie per aver accettato di rispondere a qualche domanda sul tuo lavoro e sulle tue idee! Stay Nerd cerca di dare spazio alla cultura videoludica in ogni suo aspetto, e di certo i tuoi studi rientrano con decisione all’interno di questo mondo.
Innanzitutto, vorresti dirci di cosa ti occupi, e in che modo questo tuo lavoro si interseca e incontra il mondo videoludico e dell’intrattenimento?
Sono attualmente assistant professor in educational technology alla Kent State University, Ohio. I miei interessi di ricerca sono alquanto multidisciplinari, dal ruolo della realtà virtuale/aumentata nei processi educativi alle gaming audience e relativi processi identitari e sociali. In sintesi, vedo il videogioco come costrutto complesso, un crocevia definito da diverse variabili in perenne dialogo. A latere, ho diretto studi su piattaforme mediali affini al settore, per esempio Twitch.tv e Steam, e sul come utilizzare gli algoritmi di gioco a fini formativi. Ultimamente mi sto occupando di accessibilità e principi di UDL (universal design learning) attraverso esperienze interattive. Una panoramica del mio lavoro è accessibile qui:
https://www.researchgate.net/profile/Enrico_Gandolfi
Per il pubblico di appassionati, almeno in Italia, spesso mancano punti di riferimento mainstream o di grande tradizione per i game studies, eppure esistono realtà come Ludologica o Conscious Gaming. Come si sta evolvendo il settore, secondo te? La ricerca scientifica e culturale sul videogioco sta crescendo di pari passo con l’ingrandirsi dell’industria videoludica?
Parto dalla tua ultima domanda: sì, assolutamente, i game studies si stanno espandendo in tutto il mondo, i finanziamenti aumentano, il panorama accademico prospera – in modo forse turbolento ma vivo. L’intrattenimento digitale rappresenta un incubatore di fenomeni talmente variegati che una sola presa accademica risulta insufficiente, e quanto fatto dal lato scientifico viene sempre più apprezzato e utilizzato.
Il caso italiano ci porta a discorso ben diverso. Ludologica e altre collane affini sono esempi incoraggianti, ma come noti il panorama italiano dei game studies è ancora indietro. Non perché manchino nomi – abbiamo studiosi e ricercatori eccellenti – quanto per una carenza dell’infrastruttura universitaria stessa e un ritardo cronico nell’adeguarsi con la propria realtà di riferimento. Non a caso, tantissimi game scholar italiani lavorano all’estero. Manca poi un supporto produttivo che potrebbe trainare un simile sviluppo – non siamo ancora a quello stadio, ma ci arriveremo.
Ora, ci sono segnali incoraggianti, meravigliosamente ostinati. Abbiamo GAME, un’ottima rivista scientifica di stampo italiano e vocazione internazionale, e la recente nascita del capitolo italiano di DiGRA, la maggiore associazione accademica di studi sul videogioco. La speranza è che questo porterà a un’autonomia istituzionale dei game studies italiani, anche grazie alle nuove leve che, volente o nolente, avranno il medium nel loro DNA. Nel mentre, si cerca di fare quanto possibile. Penso tuttavia che, in generale, dobbiamo lasciare la nostra torre d’avorio e adottare una lente maggiormente basata sulla ricerca, tentando al contempo un dialogo con il pubblico at large. Al contempo, il giornalismo specializzato italiano dovrebbe gettare un occhio, o anche tre, su quello che avviene nei game studies italiani e internazionali.

In una tua recente ricerca (in collaborazione con Robert Clements), pubblicata sul Journal of Virtual Worlds Research, hai analizzato il tema della Embodied Cognition (traducibile all’incirca con autocoscienza di rappresentazione), definibile come l’utilizzo di più sensi per arricchire immersione e comprensione in un dato contesto, in relazione alle esperienze digitali e virtuali. Quanto è importante, secondo te, che questo genere di ricerche raggiungano non solo gli scienziati e gli studiosi, ma anche il pubblico e le aziende di sviluppo?
Cruciale. E ti posso assicurare che lo studio di cui parli ha destato interesse in sedi che spero presto di poter comunicare. Il gap tra ricerca e divulgazione è un dato di fatto, e per quanto una distanza sia inevitabile, abbiamo bisogno di maggiori sforzi per rendere maggiormente accessibile la prima e più profonda e articolata la seconda. Soprattutto in Italia questo divario risulta rilevante comportando discorsi stagnanti e, se mi permetti, noiosi. L’impressione è di inventare sempre e di nuovo la ruota, mentre non c’è interesse ad approfondire tematiche complesse, dal gender bias alla dinamiche di sviluppo. Un’ulteriore sfida è educare il lettore medio ad andare oltre analisi superficiali e a pretendere sostanza. Deeplay.it era (uso purtroppo il passato) un ottimo esempio di come queste due anime potessero coesistere.
I videogiochi devono essere visti come fenomeni socio-culturali a tutto tondo. In altri termini, non possiamo limitarci ai loro aspetti artistici/formali, ma dobbiamo andare oltre – sporcarci le mani, vedere al di là della nostra passione e del nostro campanilismo. Solo così possiamo smettere di considerarli gli ultimi arrivati e iniziare ad affrontarli quali processi che hanno un concreto impatto sul nostro vivere. Spesso i primi reazionari in tal senso siamo noi, cullati dalle nostre nostalgiche sicurezze.
Quanto pensi, invece, che sia ancora più importante raggiungere un’accettazione collettiva del mezzo videoludico come strumento educativo? E in che contesti pensi sia più efficace?
Penso sia fondamentale perché, in questo modo, si affronta il gap generazionale che spesso limita e indebolisce la percezione del settore stesso. Giocare è il processo educativo con cui impariamo a fallire, a immedesimarci, a ipotizzare. Per diversi ricercatori è la prima esperienza formativa degna di essere considerata tale. L’aspetto computazionale ne cambia i connotati ma non il portato complessivo. Non penso esistano contesti ideali o da evitare. Sono convinto che sia la strategia, il metodo, a fare la differenza. Ho visto e analizzato bambini di 5 anni e adulti di oltre 70 apprendere attraverso i videogiochi.
L’intrattenimento digitale ha il potenziale per farsi ponte tra epoche, basandosi su una grammatica comune con il supporto di una tecnologia sempre più accessibile. La sfida è capire come dialogare con diverse prospettive, e scovare le meccaniche ludiche più pertinenti. Aggiungo che questo significa interrogarci su modi e tecniche per superare l’ansia quantitativa tipica della gamification (punti, trofei, e così via) con un approccio intrinseco, basato sull’esperienza ludica stessa, che pretende diversificazione e personalizzazione. Studi e ricerche suggeriscono un simile passaggio, ma è ancora raro vedere sforzi in questa direzione sul fronte educativo.

Uno dei temi più discussi al mondo, in questo momento, è quello dell’informazione digitale e della comunicazione orizzontale che sta prendendo il posto di quella verticale. Credi che delle strutture ludiche e interattive possano aiutare il giornalismo del nuovo secolo a raggiungere processi comunicativi diversi? In sostanza, si può fare giornalismo con i videogiochi, secondo te?
Si e no. Si è spesso parlato di newsgames, e senz’altro le audience attuali sono maggiormente interattive nel negoziare i significati del medium, i suoi confini e le relative pratiche significative. Penso alle comunità di appassionati che reagiscono alle strategie del publisher di riferimento, ottenendo risultati importanti (si veda AC: Odyssey o Anthem), e ai prodotti che sempre più si fanno critica sociale, seguendo l’esempio italiano di MolleIndustria. Per esempio, in un mio studio ho analizzato come lo sviluppo aperto (si pensi a Kickstarter, fasi di open beta, e così via) può essere portatore di istanze partecipative e trasparenza, affinando la sinergia tra mittente e destinatario, fonte e ricezione, fatto e informazione.
Ho tuttavia paura di un possibile determinismo tecnologico – i videogiochi ci rendono maggiormente autonomi, ma diversi bias rimangono, e non credo che le routine produttive e le aspettative di consumo consentano un giornalismo videoludico, non ancora per lo meno. Non a caso i primi game studies si sono dedicati a questioni formali, non volendo interessarsi al concreto portato politico e sociale del medium in quanto tale.
Bisogna poi ricordare che per quanto i videogiochi alternativi (serious games, games for change. eccetera) abbiano una tradizione consolidata, rimangono una nicchia che non ha ancora fatto breccia nel grande pubblico. Sono sovradimensionati tra gli addetti ai lavori, e il giocatore medio non li conosce, non ancora – per questo un’alleanza tra ricerca e divulgazione è importante, se non essenziale. E tuttavia, il farsi servizio del videogioco stesso potrebbe aiutare una simile causa, rendendo standard esperienze ludiche “usa e getta”. Poi per carità, l’escapismo è sacrosanto e deve esserci, il punto è diversificare l’offerta e “attaccare” nuovi orizzonti espressivi.
Dato che viviamo in un’epoca di astio nei confronti dei “professoroni”, parlaci un po’ dell’Enrico “gamer”: quali sono i giochi che apprezzi di più? Che rapporto hai mantenuto con l’hobby, in questi anni? Studiare, lavorare e fare ricerca sulle esperienze digitali e virtuali te le ha rese meno interessanti, nel tempo?
Ottima domanda. Sono un gamer come tanti. Cresciuto con Centurion e X-Com. Infatuato di XenoGears, Dungeon Keeper, e Baldur’s Gate. Innamorato di Zelda: A link to the Past e Final Fantasy 6 (e anche il 7, suvvia!). Formato grazie a The Game Machine, K e Zeta. Ho sempre giocato senza limiti o preconcetti, e approdare ai game studies è stato un meraviglioso imprevisto, che non ha affievolito la mia passione, al contrario. Ora gioco con i miei figli – soprattutto la maggiore – a giochi come Zelda: The Breath of The Wild e Pokémon Go. Nei miei momenti di pausa Overwatch è un appuntamento fisso (Reinhardt o Orisa, ma anche Bastion). I videogiochi rimangono la mia passione principale, e da ricercatore offrono talmente tanti snodi e spunti che è impossibile stancarsi, esserne appagati. Si pensi allo streaming, al lato spettacolare di giochi come Fortnite e Apex Legends – sono un pessimo giocatore di battle royale, ma adoro guardarli.
Da gamer, devo ammetterlo, trovo tuttavia deprimente questo ancorarsi al passato – questa nostalgia che l’industria creativa odierna ben comprende offrendoci remake su remake, riferimenti su riferimenti che girano a vuoto. Come accennavo, è una ninna nanna capace di nutrire un intero business con un bisogno identitario prima di nicchia e ora mainstream. Ancora una volta, non sto affermando che questi trend debbano sparire, mi sto solo interrogando sulla loro eccessiva importanza.
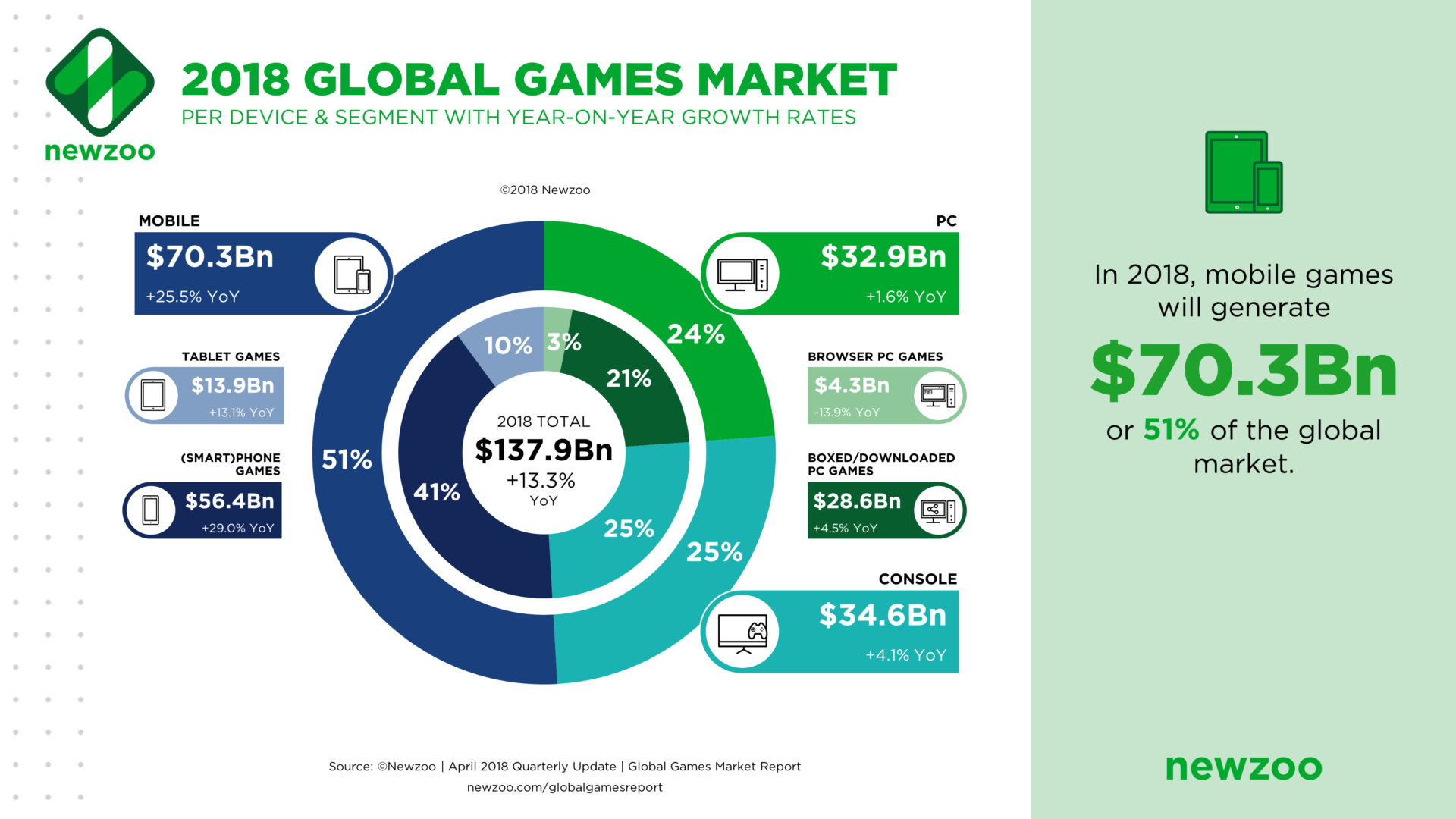
I numeri dell’industria videoludica continuano a crescere, ma ogni giorno si sentono sempre più racconti e storie su licenziamenti, stress e depressione all’interno degli studi di sviluppo, orari impensabili di lavoro e crisi finanziarie. Come vedi dal tuo punto di vista l’attuale situazione economica e culturale del videogioco?
Il settore sta attraversando cambiamenti cruciali, che in parte si possono riassumere nel passaggio paradigmatico da gioco come prodotto a gioco come servizio. Stiamo assistendo a una presa di coscienza dell’industria come dei giocatori, dove tuttavia lo sviluppo tecnologico ed economico del medium non è ancora allineato a strumenti socio-culturali in grado di inquadrarlo. Ecco quindi condizioni di lavoro disumane, movimenti come quello del Gamergate, tossicità in diverse community online, e così via. Sono tuttavia ottimista – intendo questo momento come una sorta di battesimo, una tempesta che porterà a un equilibrio nuovo e spero migliore, maggiormente “diverso” e rispettoso. Il videogioco si sta facendo di tutti, e per quanto ci siano resistenze l’esito risulta scontato. Si pensi ai tentativi dei game developer di tutelarsi e fare quadrato, o alle prese di posizione contro discriminazione e bias anche da parte di publisher di rilievo.
Che consigli daresti a chi vuole fare ricerca videoludica? Quali sono le realtà da seguire, i percorsi preferibili e gli sbocchi professionali migliori?
Ottima domanda, a cui devo rispondere con realismo. Ora come ora la ricerca in Italia stenta, e i game studies non sono ancora una disciplina consolidata nel bel paese. Mancano il know-how e le risorse per imbastire seri percorsi di ricerca. Ci sono ovviamente eccezioni (che preferisco evitare di citare per correttezza, nulla che una rapida ricerca online non possa trovare). Personalmente, il mio consiglio è intraprendere un dottorato all’estero e nel caso tornare più forti di prima. Stati Uniti, Canada e altri paesi europei (soprattutto quelli nordici) offrono diverse occasioni per game scholar in erba. Ripeto, in Italia ci sono eccellenze, il problema risiede in un sistema complessivo che stenta ad innovarsi e ad aprirsi ai giovani, soprattutto dopo aver finito un seppur eccellente dottorato. Infine, il lato produttivo non viene in soccorso nel nostro paese, mentre all’estero la ricerca accademica viene supportata da compagnie come Ubisoft e Microsoft.
Grazie mille per la tua partecipazione e disponibilità.
Grazie a voi!








