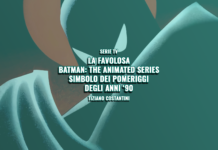Una regia eccezionale e un modo nuovo di mostrare la cucina sul piccolo schermo: questo è The Bear. Ma è davvero così perfetto?
n effetti dopo un paio di puntate potreste chiedervelo: a cosa è dovuto l’incredibile successo di The Bear?
Improvvisamente tutti sembrano parlare di questa serie TV di FX andata in onda negli States nel giugno scorso, ma arrivata in Italia su Disney+ – nel catalogo Star Original – soltanto ad ottobre, la cui trama di base non appare niente di trascendentale o sconvolgente. Jeremy Allen White veste i panni impataccati di Carmen “Carmy” Berzatto, un giovane pluripremiato chef di New York che, dopo l’improvviso suicidio del fratello Michael (addirittura Jon Bernthal) torna a Chicago per rilevare la sua paninoteca, l’Original Beef, uno storico locale del luogo in cui però regna caos e anarchia, e con una situazione economica disastrosa.

Carmy può “contare” su un team eterogeneo e un bel po’ sperimentale, costituito dal tuttofare (non sempre bene) Richie (Ebon Moss-Bachrach), migliore amico di Michael che anche per il nostro protagonista è una sorta di cugino; il panettiere Marcus (Lionel Boyce), che diventerà un pasticcere; la scontrosa Tina (Liza Colón-Zayas), l’addetto alle salse Ebraheim (Edwin Lee Gibson) e un nuovo innesto assunto da Carmy, la sous chef Sydney (Ayo Edebiri).
Una squadra che in cucina non sempre funziona ma senza dubbio sa farlo sulla scena, sia singolarmente che coralmente, supportata dallo chef Jeremy Allen che al suo primo vero ruolo protagonista fa centro.
Come nasce quindi il successo di The Bear? Le motivazioni che hanno attirato e incuriosito il pubblico sono riscontrabili in più fattori. Abbiamo visto negli ultimi anni quanto il mondo della cucina sia cresciuto a livello televisivo, rendendo l’arte dei fornelli un fenomeno mondiale, proposto sul piccolo schermo in varie salse, che tuttavia raramente avevamo visto fuori dal contesto di un cooking show, e ancor più sporadicamente in un serial puro in cui la ristorazione diventa la cornice di un quadro più complesso.
I problemi e le fragilità dei personaggi emergono dietro i fornelli, e soprattutto il disagio e il dramma del suo protagonista, lacerato da un dolore che avvertiamo costantemente e che uscirà fuori poi in un lungo monologo sul finale.
La gestione delle puntate è intelligente, con una suddivisione in 7 episodi da circa 25 minuti ciascuno più un finale di circa 40, e ognuno di questi spicca per un eccellente lavoro di regia illuminata (Joanna Calo) che procede in maniera perfettamente sinergica con una fotografia altrettanto certosina.
A colpire è anche il realismo delle scene, la frenesia e i problemi che accadono nelle cucine dei locali, soprattutto se in condizioni economiche non eccezionali, che ci restituiscono una visione anti-patinata di un mondo troppo spesso dipinto come quello dei sogni.
Certo, in The Bear a volte si calca troppo la mano esagerando un po’, ma è un espediente atto a farci capire che non c’è perfezione, soltanto amore per il proprio lavoro.

Imperfetti come tutti e anche, purtroppo, come il team alla testa di The Bear, perché al di là della già incensata regia di Joanna Calo, c’è la scrittura con cui la stessa cineasta ha supportato il lavoro dell’ideatore Christopher Storer, e dove purtroppo il difetto dell’esasperazione si ripercuote un po’, appesantendo la struttura narrativa. Il racconto di una routine caotica e sempre uguale a se stessa nell’arco di otto episodi, con le urla a spadroneggiare, alla lunga rischia di annoiare e allora serve di nuovo un guizzo registico per riportarci sull’attenti.
Resta senza dubbio un ottimo prodotto, che sa di innovazione e come colpire lo spettatore, sebbene non abbia trovato quella perfezione assoluta che ha portato molti colleghi a definirlo come un prodotto impeccabile. Ma se mi chiedete se vale la pena vederlo, la risposta è certamente “sì, chef!”.