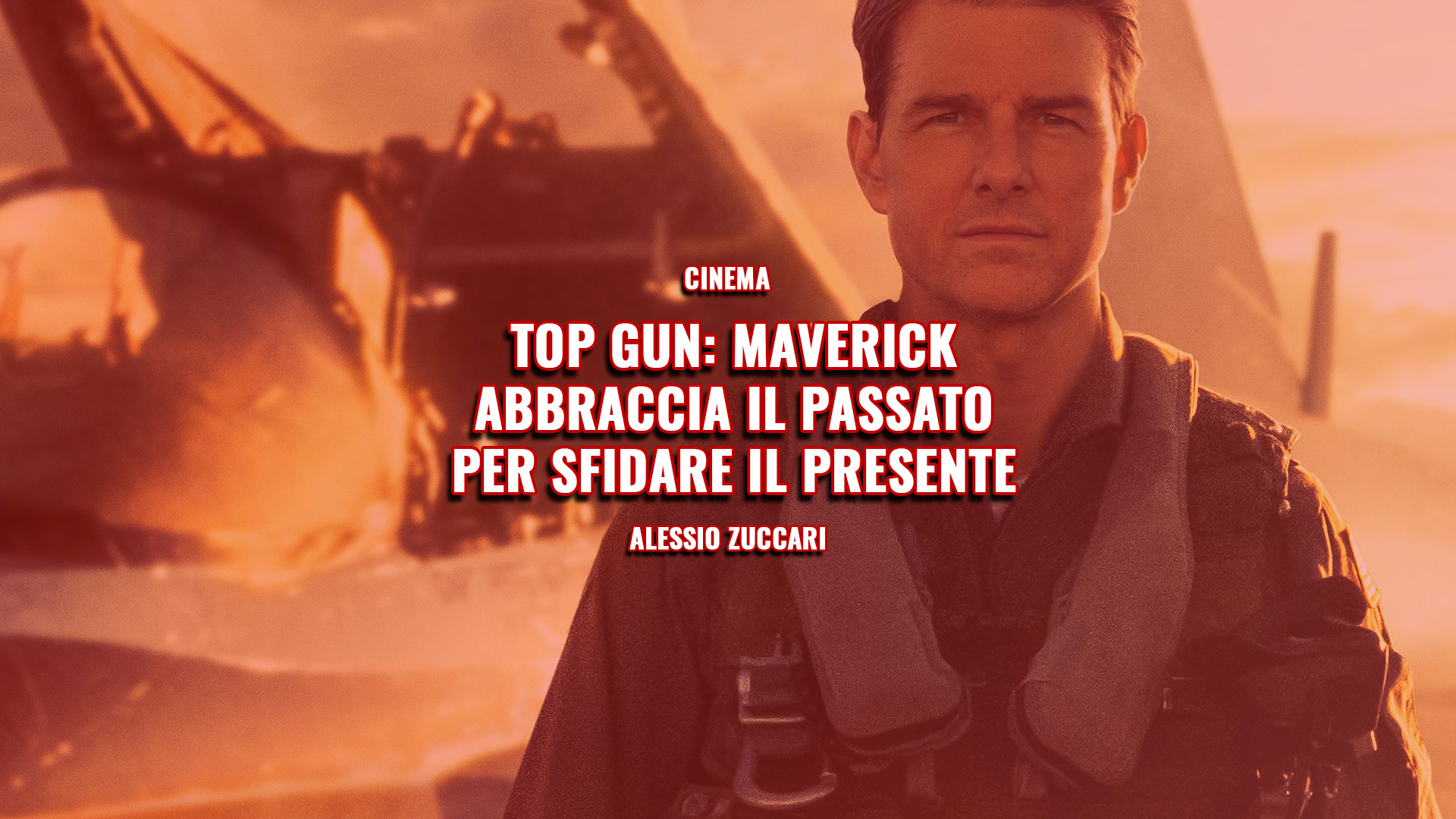Dopo più di trent’anni Tom Cruise torna a bordo dei caccia in Top Gun: Maverick
op Gun più che un film fu un racconto mitopoietico. Una moto che sfreccia al tramonto, un aereo che taglia i cieli, un amore tra due bellezze da copertina, una colonna sonora che pare racchiudere dentro una giovinezza eterna. E un intero decennio, quegli anni Ottanta cristallizzati nella frenesia di un mondo pronto ad accelerare in maniera vertiginosa, pronto ad affacciarsi a un futurismo miniaturizzato e digitale.
Ma lì, nel 1986 del Top Gun di Tony Scott, c’era ancora tutto il tangibile della cosa umana, delle sue pulsioni e dei suoi sudori. C’era Tom Cruise con il suo Pete “Maverick” Mitchell, rampollo della Hollywood a venire che consacrò probabilmente uno status a misura di gigantografia dove il nome è quasi elemento accessorio, ridondante sul volto di un’icona in grado di esplicarsi da sé. Forse per questo nei titoli di testa di Top Gun: Maverick il suo, di nome, non compare al fianco di tutti gli altri. Non ne ha bisogno. Perché già campeggia nel titolo di un film che non poteva farsi altrimenti se non tratteggiato a sua immagine e somiglianza, in naturale prosecuzione di un cordone lungo più di trent’anni e che non s’è mai spezzato, anzi tutt’altro.
- Leggi anche: Tom Cruise: l’uomo oltre l’impossibile

Un Cruise che in diverse interviste s’è detto dubbioso nel corso del tempo sulla possibilità di tornare a indossare i panni del suo Maverick, nonostante le continue strizzatine d’occhio da parte del mega produttore Jerry Bruckheimer, ma che di fatto Maverick lo è diventato per davvero con il passare degli anni. Sempre più stuntman, sempre più pilota, sempre più al centro dell’azione con l’obiettivo, ancora tra il mito e il marketing, di puntare al cosmo.
Quando l’ammiraglio Cole di Ed Harris avverte Maverick che la sua specie è prossima all’estinzione viene quindi da chiedersi a quale specie stia facendo realmente riferimento. Quella umana, a cui tutti noi apparteniamo, oppure quella un-po’-più-umana, quasi superomistica, a cui il Cruise – Maverick pare essere asceso? Dilemma proprio dei tempi del cinecomic che viviamo, tra una strutturazione nuova di zecca dello star system contemporaneo e uno sguardo più che accorto al regime di una tecnica ogni giorno un po’ più invisibile e subdola. Dilemma che affronta grossolanamente anche Vin Diesel con il suo Toretto nel franchise di Fast and Furious, dove si autoelegge a divinità muscolosa, superforte, super fedele a famiglia e a una croce che stringe in petto perché sotto sotto vorrebbe farla sua.
Una riflessione a grana grossa che poco o nulla ha a che vedere col modo in cui Top Gun: Maverick abbraccia la questione a partire dal riverbero, dall’eco interna che il primo capitolo è inevitabile continui a diffondere. Prima di tutto viene infatti l’atteggiamento reverenziale, che nonostante a dirigere ci sia il più che apprezzabile Joseph Kosinski con in sceneggiatura Christopher McQuarrie assieme a Ehren Kruger e Eric Warren Singer, paiono tutti essere uomini di Cruise, custode delle chiavi di un successo annunciato dove sembra essere lui a dettare parametri e senso della profondità.

C’è rispetto rigoroso per una formula che si adatta ma assolutamente non stravolge, che sostituisce i Berlin con Lady Gaga e fa sentire tutto il peso degli anni addosso alla cockiness di un Maverick chiamato ad archiviare la bromance, dalla quale non s’è mai ripreso, per far posto a un ruolo da padre surrogato proprio nei confronti del figlio (Miles Teller) di quel Goose che perse in volo.
Non potrebbe esserci prosecuzione più nella natura delle cose, più sfacciatamente e dichiaratamente umana, quasi biologica. Una maniera di mantenere il tramonto una costante romantica ma stagliata all’orizzonte, mentre c’è anche il ritorno di un amore con Penny (Jennifer Connelly), vissuto tra fiammate dalle sfumature puberali messe con ironia alla berlina perché, ancora, il tempo passa e Cruise – Maverick, titano consapevole, lo accetta col sorriso in volto.
Tutto attorno sembra stagliarsi una sfida più grande e più importante di quella che Top Gun: Maverick mette in ballo in prima istanza. Occorre addestrare un nuovo manipolo di piloti da inviare a distruggere un laboratorio di uranio indefinito, sotto il controllo di un nemico indefinito di uno stato indefinito. L’avversario non ha volto perché in questo contesto, che pare richiamare in tutto e per tutto un regime di simulazione totale, l’avversario non è l’umano; basti pensare all’accento posto non sul chi, ma sul cosa, gli aerei di quinta generazione.

E non va letto nell’ottica del tentativo di spersonalizzazione di un Paese ostile (magari più individuabile nel piglio patriottico da Guerra fredda proprio del primo film), quanto piuttosto nello sforzo di riaffermare la centralità dell’umano stesso sul proliferare della tecnica incontrollata e incontrollabile – anche al cinema, CGI, deep fake. Sforzo portato agli estremi nella meticolosità di preparazione al girato, con corsi di formazione intensivi per abituare gli attori a volare per davvero all’interno dei velivoli, nei cui abitacoli sono state poste innovative telecamere in grado di far accumulare centinaia di ore di materiale confluito poi solo in parte infinitesimale all’interno di Top Gun: Maverick. Un’opera di asservimento della tecnica nel tentativo di perseguire il realismo e non di sostituirlo, che da un lato rappresenta un incredibile obiettivo produttivo e dall’altro una lotta ai confini della teoria, se non del filosofico.
Di fianco a tutto questo, lo abbiamo detto, il film poi non dimentica nemmeno per un istante l’importanza cruciale dell’emotività, mai ricattatoria, o dell’impulso adrenalinico da pompare in vena, altrimenti ogni cosa si sarebbe risolta in un testacoda inconcludente. Le sue traiettorie rispetto al passato si fanno però più sotterranee, spostate quasi totalmente sulle spalle di Tom Cruise, perché manifesto di una sfida tra pochi Davide e molti Golia, tra il cuore e il circuito che il tema dell’oggi.