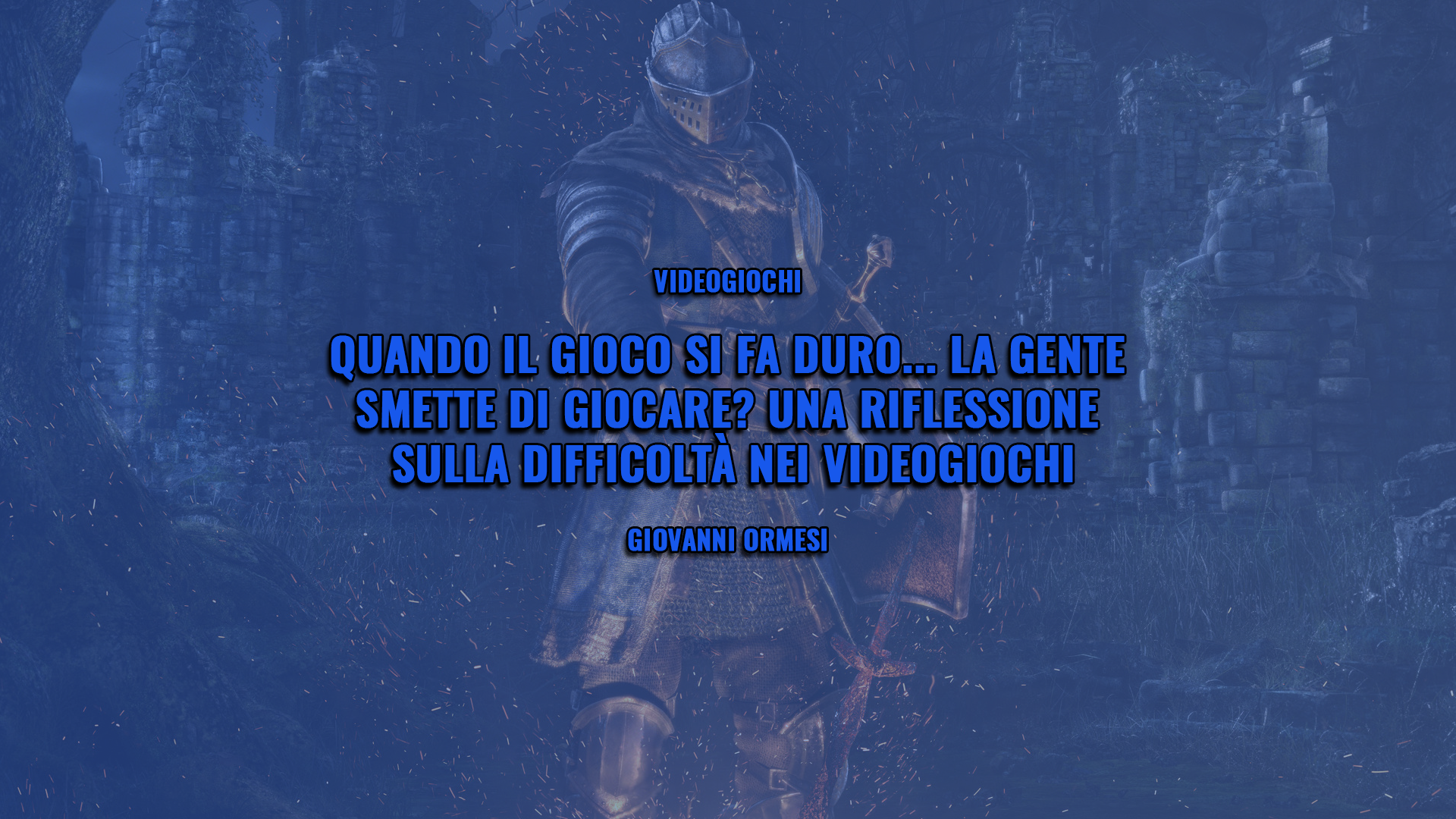Sono almeno vent’anni che sentiamo ripetere che i videogiochi stanno diventando (o sono diventati) troppo facili. Analizziamo questo trend.
Il videogame nasce come gioco di abilità elettronico, come sfida: non a caso i primi coin-op della storia non riproducono vacanze al mare o passeggiate in montagna, bensì guerre spaziali (pensiamo a Galaxy Game e a Computer Space) e partite di ping-pong (no, stavolta il titolo fra parentesi non ve lo metto, tanto lo sapete tutti, NdR). Connaturato nel concetto di sfida vi è quello di difficoltà, che ha accompagnato lo sviluppo del videogioco per almeno vent’anni, fino ai mitici (erano mitici? Non lo so, però adesso tutti ne vanno pazzi, NdR) Novanta, quando si è cominciato a registrare un mitigamento sotto questo versante, mitigamento proseguito fino ai giorni nostri e forse non ancora concluso.

Perché? Cos’è successo? Le cose torneranno come un tempo? Eravamo più contenti prima? Ragioniamoci assieme.
Difficoltà nei videogiochi: il tramonto della filosofia arcade
A mio avviso, l’abbassamento della difficoltà media dei videogiochi è imputabile a due fattori strettamente interconnessi. Il primo è senz’altro l’esplosione del mercato delle home console. Sono sempre esistite, è vero (pensate che il Magnavox Odyssey è uscito nel 1972), ma nella seconda metà degli anni Novanta, con il debutto di Sony sul mercato, il fenomeno ha assunto dimensioni inaudite: nessuna console era mai arrivata a piazzare cento milioni di unità, nessuna si era nemmeno lontanamente avvicinata a quel traguardo (prima del passaggio di testimone a PlayStation, lo scettro era in mano al NES, con appena 62 milioni di unità vendute). Non è un caso che nella seconda metà della decade le sale giochi abbiano conosciuto un declino che adesso le ha rese un fenomeno di nicchia in Occidente.
La transizione da coin-op a home console comportò una ridefinizione di alcuni paradigmi videoludici, stante l’enorme differenza nelle modalità di fruizione: nelle sale giochi si spendeva qualche spicciolo per fare una singola partita, mentre con le home console si faceva un grande investimento iniziale (la macchina, eventualmente con un secondo controller, memory card e giochi, per un totale di centinaia di migliaia di Lire, all’epoca) in cambio della disponibilità tendenzialmente illimitata del titolo acquistato. È la morte della filosofia arcade: tutto il sistema di credit, record, classifiche, continue e schemi impossibili “mangia-gettoni” non serve più a niente. Non c’è più bisogno che il gioco sia difficile per incollare la platea allo schermo; semmai è il contrario: ora che ho speso centomila Lire (o più) per un gioco, vorrei finirlo, magari senza scomodare infiniti santi e madonne; non è un caso il fatto che negli anni Novanta si potessero acquistare in edicola libri con centinaia di pagine di trucchi, originariamente inseriti dagli sviluppatori per agevolare la fase di testing e poi divenuti un fenomeno di costume, come nel caso di Grand Theft Auto.

Difficoltà nei videogiochi: il videogioco come prodotto di massa
In quegli anni il videogioco diventa un fenomeno di massa, e in ciò io individuo il secondo fattore fondamentale per l’abbassamento della difficoltà. Per molto tempo il mondo videoludico è stato appannaggio, quantomeno fra gli adulti, di una nicchia più o meno ampia di nerd, mentre negli ultimi vent’anni è divenuto progressivamente più popolare, fino ai giorni d’oggi, in cui lo stesso termine “nerd” ha perso gran parte della sua accezione negativa (pensate anche solo al fatto che state leggendo questo articolo su un sito che si chiama “Stay Nerd”, NdR). Ogniqualvolta un movimento, un fenomeno o un’opera transita nel mainstream, è inevitabile una qualche sorta di “banalizzazione”, che garantisce la fruibilità a una platea sempre più numerosa, solitamente sacrificando almeno una parte dell’originaria cerchia di accoliti. Nel mondo videoludico uno degli effetti di questa banalizzazione è stata la crescente agevolazione del giocatore, sempre più “preso per mano” dagli sviluppatori.

Adesso ci destreggiamo nei livelli grazie a comodi radar e indicatori, raramente abbiamo l’affanno di terminare le vite (perché non ci sono più), quando perdiamo ricominciamo da un checkpoint vicinissimo e spesso non abbiamo nemmeno la seccatura di raccogliere nuovamente i collectible, possiamo ricaricare la salute aspettando qualche istante nascosti dietro a un riparo e, generalmente, possiamo finire la maggior parte dei titoli senza grossi intoppi, magari scalando la difficoltà nei videogiochi in corso d’opera. La situazione attuale è il risultato di una stratificazione pluriventennale, in un contesto in cui il mercato videoludico non ha mai conosciuto una flessione: di fatto, queste feature vengono costantemente riproposte perché i giochi che le contengono incontrano il successo della critica (che in fondo non è così rilevante) e del pubblico.
Difficoltà nei videogiochi: il videogioco come esperienza
La maturazione del medium videoludico ha portato più di qualcuno a concepire il videogioco come opera d’arte. Ora, prescindendo da questo complicatissimo discorso, che richiederebbe decine di saggi per essere sviscerato, limitiamoci a constatare che nelle ultime due decadi è affiorato un nuovo paradigma, non necessariamente alternativo rispetto a quello precedente (anche se molto spesso di fatto è così), che vede il videogioco non come una sfida, bensì come un’esperienza sinestetica: insomma, siamo agli antipodi della filosofia arcade, ma, come vedremo fra pochissimo, una non esclude l’altra. Moltissimi giochi abbracciano in tutto o in parte questo paradigma: non si tratta solo dei recenti walking simulator, ma anche di tutte quelle opere che, seppure appartengano a generi “tradizionali”, pongano particolare enfasi sulla trama, sulla sceneggiatura e/o sulla direzione artistica.
Fra le decine di nomi che mi rimbalzano in testa, cito Rez: appartiene a un genere tradizionale (è uno sparatutto su rotaie), ma offre un’esperienza che esula dal mero godimento “blastatorio”; è emblematico perché è strutturato come un arcade vecchio stile, ma moltissimi giocatori (fra cui il sottoscritto) lo hanno affrontato piuttosto come un’esperienza audiovisiva in cui sì, si spara, ma soprattutto ci si guarda intorno e si tende l’orecchio, per cogliere quella perfetta armonia fra grafica e sonoro che poche opere sanno comporre. In quest’ottica, trovavo addirittura seccante giocare a difficoltà elevate, in quanto ciò mi distoglieva troppo dalla contemplazione artistica, impedendo il prodursi della sindrome di Stendhal.

La maggior parte di questi giochi è caratterizzata da un livello di difficoltà nullo o scarso, ma ciò non si lega in alcun modo alla massificazione e alla necessità di compiacere un pubblico che sia il più ampio possibile; semplicemente, la sfida, l’abilità, non è il focus dell’opera, talvolta non è nemmeno contemplata.
E gli hardcore gamer?
A ben vedere, tuttavia, la situazione non è così negativa come potrebbe sembrare: è vero che si cerca continuamente di ampliare la platea, ma è altrettanto vero che non si vuole abbandonare la profittevole nicchia di hardcore gamer. Negli ultimi dieci anni sono stati prodotti giochi impegnativi, come i Souls e Sekiro di FromSoftware, Hollow Knight, Salt and Sanctuary, Super Meat Boy e The Binding of Isaac; inoltre, quasi tutti i giochi hanno vari livelli di difficoltà, che possono modificare significativamente l’esperienza in toto, come abbiamo visto quest’anno con il remake di Resident Evil 2.

Quello che mi auguro io è che il livello di sfida sia sempre più personalizzabile: non basta avere una modalità facile in cui i nemici fanno pochi danni, una media in cui fanno i danni “giusti” e una difficile in cui ne fanno tanti; è bello poter scegliere anche se fruire di determinate agevolazioni (come avviene in The Sinking City con gli indicatori delle indagini) o disattivare determinati svantaggi (come nei recenti Fire Emblem, in cui il permadeath è opzionale). Questa è la quadratura del cerchio.